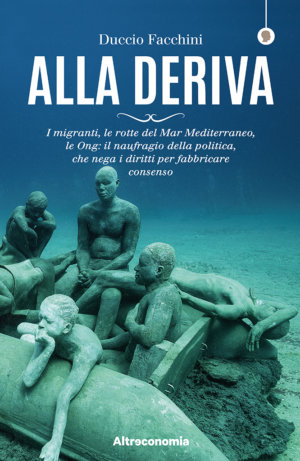Diritti / Inchiesta
Così le prefetture italiane hanno escluso 100mila persone dall’accoglienza in quattro anni

Tra 2016 e 2019, 100mila tra richiedenti asilo e beneficiari di protezione, si sono visti revocare le condizioni materiali di accoglienza dagli uffici del Governo. Una prassi diffusa da Nord a Sud -come dimostrano i dati aggiornati al 30 settembre 2019 ottenuti da Altreconomia tramite accessi civici- in grado di incidere profondamente sulla vita di migliaia di accolti divenuti “revocati”. Una prassi che potrebbe essere ribaltata da una recente sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea
Negli ultimi quattro anni le prefetture italiane hanno escluso dal sistema di accoglienza almeno 100mila persone, tra richiedenti asilo e beneficiari di protezione, negando loro vitto, alloggio, vestiario e sussidi economici. Una prassi diffusa da Nord a Sud -come dimostrano i dati aggiornati al 30 settembre 2019 ottenuti da Altreconomia tramite accessi civici- in grado di incidere profondamente sulla vita di migliaia di accolti divenuti “revocati”. Oggi, quella prassi “svuota centri” che il ministero dell’Interno non ha ancora gli strumenti per misurare a livello centralizzato, potrebbe essere ribaltata da una sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea. A metà novembre di quest’anno, infatti, la Grande sezione di Lussemburgo ha richiamato i Paesi membri a rispettare “l’obbligo di garantire un tenore di vita dignitoso” alle persone in accoglienza. Nessuno escluso.
Per comprendere i riflessi della sentenza anche sul contesto italiano è necessario chiarire il concetto di “revoca” e le sue “regole”. Il punto di riferimento è la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2013/33/UE, relativa all’accoglienza dei richiedenti protezione internazionale. È da questa che deriva l’obbligo (formale) per tutti gli Stati membri dell’Unione europea di “provvedere a che i richiedenti abbiano accesso alle condizioni materiali di accoglienza” nel momento in cui manifestano la volontà di chiedere la protezione. Quest’obbligo, però, non è assoluto. Il legislatore europeo ha previsto diverse circostanze in cui le condizioni possano essere ridotte o, come extrema ratio, revocate (articolo 20 della direttiva). Si va dal caso di chi abbandona senza permesso o senza darne informazione il “luogo di residenza determinato dall’autorità competente dello Stato membro”, a quello di chi non compare al colloquio personale per la procedura d’asilo. Da chi avanza una domanda “reiterata” a chi, “senza un giustificato motivo”, non abbia presentato la domanda di protezione internazionale non appena ciò sia stato “ragionevolmente fattibile” dopo il suo arrivo nello Stato membro di riferimento. Gli Stati dell’Ue possono inoltre ridurre o revocare l’accoglienza anche a quel richiedente che avesse “occultato” risorse finanziarie e quindi beneficiato in maniera “indebita” di vitto, alloggio, vestiario.
Non è finita. La direttiva 2013/33 ha aggiunto anche “sanzioni” applicabili ad altre due ipotesi: quella di “gravi violazioni delle regole dei centri di accoglienza” o di “comportamenti gravemente violenti”. Pur non precisandone la natura, la norma chiarisce che qualsiasi sanzione deve essere “obiettiva, imparziale, motivata e proporzionata alla particolare situazione del richiedente” e deve “in ogni caso” salvaguardare l’accesso all’assistenza sanitaria e un tenore di vita dignitoso.
Quale membro dell’Unione europea, anche il nostro Paese ha recepito la direttiva sull’accoglienza. Lo ha fatto nel 2015 per mezzo di un decreto legislativo (142/2015), e lo ha fatto male. “A differenza di quanto previsto dalla norma dell’Unione -spiega l’avvocato Anna Brambilla, socia dell’Associazione per gli studi giuridici sull’immigrazione (asgi.it)-, la normativa italiana non ha previsto alcuna ipotesi di gradazione delle misure sanzionatorie in danno dei richiedenti asilo accolti”. Tradotto: il prefetto può disporre la revoca delle misure di accoglienza senza contemplare alcuna riduzione. Oltre ad aver cancellato il principio di gradualità, il legislatore ha previsto la revoca anche nei casi di “violazione grave o ripetuta delle regole delle strutture in cui è accolto” il richiedente asilo o di suoi “comportamenti gravemente violenti”. È una forzatura: la direttiva europea, infatti, aveva sì previsto in quelle circostanze non meglio precisate “sanzioni”, ma aveva specificato che queste non avrebbero in ogni caso dovuto limitare l’accesso all’assistenza sanitaria e un tenore di vita dignitoso. L’Italia, invece, ha optato per mettere subito in strada le persone. In questo modo è stato dato in mano ai prefetti un potentissimo strumento “svuota centri di accoglienza”. E questi lo hanno utilizzato senza esitazioni.
Lo dimostra il numero dei provvedimenti emessi negli ultimi anni: almeno 100mila dal 2016 al 30 settembre 2019. La mappatura inedita è stata possibile grazie alla procedura di accesso civico generalizzato (Freedom of information act, FOIA) inoltrata a tutti i 106 uffici territoriali del Governo, 84 dei quali hanno risposto al 20 novembre 2019. Inutile invece passare dal livello centrale: il ministero dell’Interno, a oltre quattro anni dall’entrata in vigore del decreto 142, ci ha fatto sapere di non avere ancora una rilevazione dell’andamento delle revoche e ha invitato a “desumerla” dalla “consultazione dei siti di ciascuna Prefettura”. Una risposta che fa riflettere visto che già a gennaio 2018, all’epoca della nostra prima inchiesta sull’argomento (vedi Ae 202), dal Viminale avevano assicurato di star “procedendo al monitoraggio e alla raccolta dei dati presso le Prefetture e provvedendo a stilare una statistica che sarà disponibile a breve”.
Riscontri agli accessi civici alla mano, dunque, è possibile ricostruire la situazione nel biennio 2016-2017 e in quello più recente 2018-2019 (primi nove mesi). Partiamo dal primo periodo, quello 2016-2017, rispetto al quale 60 prefetture hanno comunicato l’adozione di 41.761 provvedimenti di revoca delle condizioni materiali di accoglienza. Proiettando quel dato certo sul totale degli uffici (106, come detto), è possibile stimare almeno 70mila provvedimenti, 60mila a voler essere prudenti. Dentro quei 41.761 provvedimenti certificati c’è il boom registrato a Roma, dove i migranti “revocati” e posti fuori dal sistema di accoglienza sono stati addirittura 4.408, a Brescia 2.222, a Bologna 2.202, a Caserta 1.686, ad Avellino 1.424. Mentre la direttiva 2013/33 prevede che le revoche debbano essere “adottate in modo individuale”, in alcuni casi -come a Roma- vige l’adozione di “maxi decreti” di revoca con frequenza mensile che hanno interessato gruppi di richiedenti e non invece i singoli.

La stragrande maggioranza dei provvedimenti di revoca deriverebbe dall’allontanamento “volontario” dei migranti dal centro di accoglienza, ma accanto a questo ci sono anche casi disparati, tutti a discrezione delle singole prefetture. A Napoli, ad esempio, la prefettura ha predisposto un “regolamento di accoglienza” ai sensi del quale è sufficiente anche solo una “assenza ingiustificata di un solo giorno” per procedere alla revoca. A Verona è disposta la revoca per l’“assenza non autorizzata nelle ore notturne, anche per una sola notte”. A Pistoia può ricadere su chi si “dedica all’accattonaggio”, acquista, detiene o vende “beni di dubbia provenienza” o viaggia senza biglietto sui mezzi pubblici. A Roma è capitato il caso di una revoca motivata dal fatto che un migrante accolto avrebbe tentato di “sottrarsi al controllo effettuato dalle autorità di pubblica sicurezza” in un parco pubblico. A Firenze, invece, è stata negata l’accoglienza a chi aveva accumulato 66 ore di “assenze” a scuola.
Tra il primo gennaio 2018 e il 30 settembre 2019, la musica non è cambiata. In quel periodo, infatti, la prefettura di Bari ha revocato l’accoglienza a 1.679 persone, Cosenza a 1.326, Cuneo a 891, Napoli a 540. A Gorizia i provvedimenti sono stati 1.172, nel 95% dei casi perché le persone avrebbero volontariamente abbandonato le strutture di accoglienza. La prefettura di Milano ne ha disposti 534, con un’accelerazione nei mesi estivi del 2019 osservata dal Naga (naga.it), storica associazione che in città fornisce assistenza sanitaria, sociale e legale ai cittadini stranieri. Nadia Bovino, operatrice del servizio legale, racconta di un “crescente e tragico accanimento” da parte dei centri di accoglienza, che notificano revoche facili anche solo dopo due giorni di assenza.

Le 57 risposte ricevute da altrettante prefetture danno conto ufficialmente di 24.945 nuovi provvedimenti di revoca. Facendo la proiezione su scala nazionale, se ne possono stimare almeno 40mila, a conferma del ricorso generalizzato a questa misura. Non sono mancate risposte curiose. È il caso di Roma: “Considerata l’elevata mole di dati richiesti, la difficoltà nell’elaborazione degli stessi e l’esistenza di plurime cause di revoca delle misure di accoglienza -ha fatto sapere l’area Servizi, asilo, immigrazione della prefettura- non è possibile soddisfare la richiesta in questione”. Quel che è certo è che da Vibo Valentia ad Aosta, nessuna prefettura oggi è tenuta a conoscere dove siano finite le persone escluse, perché così prevede la legge. Gran parte ha abbandonato il Paese, altri invece hanno trovato posto da conoscenti e amici, altri ancora si ritrovano in centri informali e precari. “A Milano -racconta Bovino del Naga- le persone revocate le mandiamo al Centro aiuto Stazione Centrale (CASC) in cerca di un posto letto. Se lo trovano bene, altrimenti finiscono al mezzanino della stazione. C’è chi si organizza per un posto letto in un appartamento affollato o chi resta per strada, costretto a cercare fortuna altrove, scappando in altri Paesi europei”. In questi casi il “giro” ricomincia: “Alcuni revocati in Italia ripresentano domanda di asilo in altri Paesi dell’Ue. E ai sensi del Regolamento di Dublino vengono rimandati indietro, in Italia, finendo magari da noi e quindi al CASC, o in strada, o fuggendo di nuovo”.
Un’altra testimonianza arriva dalla Basilicata, dove lavora Angela Maria Bitonti, avvocato e socia di Asgi. “A Matera e a Potenza -racconta Bitonti- le prefetture hanno ricominciato a revocare l’accoglienza anche ai soggetti vulnerabili. Mi riferisco al caso specifico di una mamma con una bambina di quattro anni o a quello di un migrante affetto da gravi patologie psichiatriche e sotto cura farmacologica. Si tratta di revoche tout-court, dove l’amministrazione non si è minimamente preoccupata di informare i servizi sociali del territorio affinché venissero attivate strutture protette, per la sicurezza sia dei miei assistiti, sia della collettività in generale”. Bitonti denuncia una preordinata strategia di svuotamento dei centri entro il 31 dicembre 2019, rivolta anche contro i titolari di protezione umanitaria colpiti dal “Decreto Salvini” entrato in vigore il 5 ottobre 2018.
I numeri del ministero dell’Interno sui centri di accoglienza e sulle persone ospitate rafforzano la tesi di Bitonti. I centri prefettizi sono passati dai 9mila di ottobre 2018 a poco più di 6mila un anno più tardi (-33%). Nel gennaio 2018 gli accolti in Italia erano poco più di 182mila tra centri di accoglienza straordinaria (CAS), quelli del Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati (SPRAR, snaturato e trasformato in Sistema di protezione per titolari di protezione internazionale e per minori stranieri non accompagnati, SIPROIMI, dal “Decreto Salvini”), hotspot e centri di prima accoglienza. Al 15 novembre 2019 sono crollati a 95.755 (la maggioranza ancora nei CAS): un decremento del 50% circa in nemmeno due anni. Oltre alla conclusione dei procedimenti di esame delle domande di asilo e il crollo degli arrivi, ha inciso senza dubbio anche il larghissimo ricorso alle revoche.

In questo quadro buio, lo scorso 12 novembre, è arrivata come un lampo la sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea. Per la prima volta da quando è in vigore la direttiva 2013/33, la Grande sezione si è espressa sulla portata del diritto che gli Stati membri hanno di stabilire le sanzioni applicabili quando un richiedente protezione internazionale si sia reso colpevole di una grave violazione delle regole del centro di accoglienza presso cui si trova o di un comportamento gravemente violento (articolo 20, paragrafo 4). Ovvero quei comportamenti per i quali in Italia si è “puniti” con la revoca immediata.
Il caso in esame riguardava il signor H., cittadino afgano giunto in Belgio nel dicembre 2015, minore e non accompagnato. Pochi mesi dopo la sua sistemazione nel centro di accoglienza di Broechem, H. viene coinvolto in una rissa e arrestato dalla polizia, intervenuta su richiesta dei gestori della struttura. Questi ultimi decidono di sanzionarlo revocandogli temporaneamente le condizioni materiali di accoglienza per 15 giorni. H., che nel frattempo è stato rilasciato, è messo per strada e trascorre alcune notti in un parco di Bruxelles. In quei giorni, con il suo tutore, decide di impugnare la misura di esclusione e di chiedere il risarcimento del danno subito. La tesi di H. è che tra le sanzioni che potevano essergli inflitte non c’erano la revoca o la riduzione della sua accoglienza, perché altrimenti a rimetterci sarebbe il pieno rispetto della dignità umana sancito dall’articolo 1 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (“La dignità umana è inviolabile. Essa deve essere rispettata e tutelata”). Dopo una serie di rinvii, si è espressa la Corte di giustizia dell’Unione. Il pronunciamento è straordinario: “Anche le sanzioni più severe […] non possono privare il richiedente della possibilità di provvedere ai suoi bisogni più elementari”.
Non solo: ogni Stato membro -Italia inclusa- è chiamato ad “assicurare un siffatto tenore di vita in modo permanente e senza interruzioni”, ovvero soddisfare “bisogni elementari” quali “nutrirsi, lavarsi e disporre di un alloggio”, senza pregiudicare la “salute fisica o psichica” della persona accolta o porla “in uno stato di degrado incompatibile con tale dignità”. Conclusione: “Uno Stato membro non può prevedere, tra le sanzioni che possono essere inflitte a un richiedente in caso di gravi violazioni delle regole dei centri di accoglienza nonché di comportamenti gravemente violenti, una sanzione consistente nel revocare, seppur temporaneamente, le condizioni materiali di accoglienza”.
È un’affermazione “rivoluzionaria” se confrontata con la normativa e la prassi delle prefetture italiane. Gianfranco Schiavone, studioso di migrazioni, vice-presidente dell’Asgi e presidente del Consorzio italiano di solidarietà-Ufficio rifugiati onlus di Trieste, parla non a caso di “distanza siderale”. “Gli Stati non possono mettere in strada le persone senza pensare alle conseguenze gravi che questa scelta comporta sulla vita reale di chi è colpito dal provvedimento -spiega Schiavone-. Anche se il principio sancito dalla Corte ha riguardato la violazione delle regole o i comportamenti violenti, di certo non si potrà sanzionare in maniera persino più dura colui che mette in atto comportamenti che non sono connotati da alcun disvalore come l’allontanamento per un periodo di tempo limitato dal centro perché tenta di lasciare il Paese”. Qualcuno potrebbe obiettare che alla luce di questa sentenza sarà impossibile escludere anche chi dovesse abusare dell’accoglienza. “La portata della sentenza è enorme perché interpreta in modo molto restrittivo le ipotesi nelle quali si può procedere a una revoca -continua Schiavone- ribadendo il principio fondamentale della extrema ratio: in caso di violazioni, lo Stato, nel nostro caso le prefetture, nel rispetto del principio di proporzionalità, deve prima di tutto trovare altre soluzioni rispetto alla revoca. Potrebbe spostare l’interessato in un’altra struttura, eventualmente più sorvegliata, e ridurre, se del caso, alcune delle prestazioni. Ma lo Stato non può mai abdicare alle responsabilità che ha nei confronti delle persone che è tenuta a prendere in carico, né può, con provvedimenti irragionevoli, generare a sua volta un disagio sociale”. Le ricadute della sentenza riguarderanno inevitabilmente anche il decreto 142/2015. “La Corte non risolve la controversia nazionale -spiega l’organo di Lussemburgo-. Spetta al giudice nazionale risolvere la causa conformemente alla decisione della Corte”. Sta di fatto che questa decisione “vincola egualmente gli altri giudici nazionali ai quali venga sottoposto un problema simile”.
È un cambio di prospettiva radicale che investe anche il ministero dell’Interno, il quale troppe volte ha concepito l’accoglienza dei richiedenti asilo più come una concessione che come un obbligo. Lo dimostra il caso di una revoca disposta a fine 2018 dalla prefettura di Avellino a carico di un richiedente allontanatosi “arbitrariamente e ingiustificatamente” (parole del ministero) dal centro di accoglienza per tre giorni e poi rientrato. Quando l’interessato ha fatto ricorso al Tar della Campania impugnando il provvedimento di revoca, il Viminale ha “resistito” e si è costituito in giudizio. Una delle tesi sostenute dal Governo fa riflettere: “Risulta provato che la controparte non abbia dimostrato di aver svolto alcuna attività lavorativa regolare e che, pur beneficiando delle misure di accoglienza generosamente messe a sua disposizione dallo Stato italiano, abbia preferito rendersi irreperibile”. Un obbligo fondamentale è divenuto concessione “generosa”, a dimostrare quanto siano ancora lontani la Grande sezione di Lussemburgo e il pieno rispetto della dignità delle persone. Ma uno spiraglio oggi c’è.
© riproduzione riservata