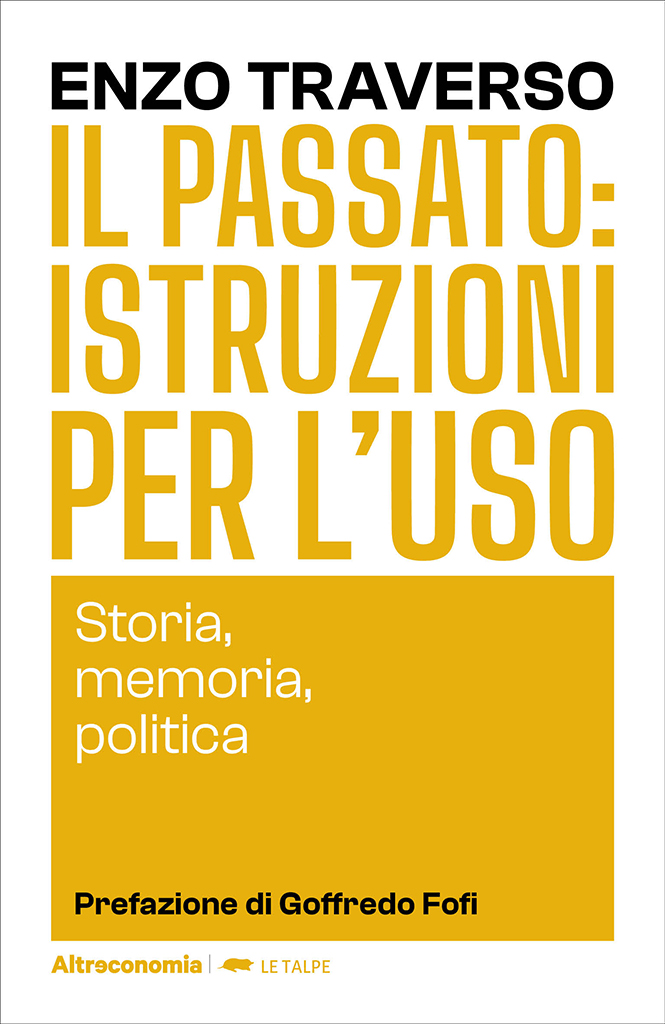Cultura e scienza / Intervista
Zehra Doğan. L’arte politica dei corpi

Le opere dell’attivista curda denunciano le violenze della Turchia contro il suo popolo. Una pratica segnata dall’esperienza della clandestinità e del carcere
Zehra Doğan è una pittrice, attivista e giornalista curda. Nel 2017 è stata condannata a 33 mesi di carcere per aver pubblicato su Internet alcuni post in cui denunciava le violenze del regime turco contro il popolo curdo. In particolare, un suo disegno di Nusaybin (città turca a maggioranza curda al confine con la Siria) in macerie e con le bandiere turche che sventolavano sui palazzi divenne virale e fu soprannominato “Guernica curda”, con riferimento al famoso quadro di Picasso che ritrae gli orrori della guerra civile spagnola. Per quell’opera Doğan ha scontato quasi tre anni di prigionia, divisi tra il carcere di Diyarbakir e quello di Tarso, da dove ha continuato a dipingere con i materiali che aveva a disposizione in cella. Durante la detenzione ha ricevuto la solidarietà di noti attivisti tra cui il dissidente cinese Ai Weiwei e l’artista di strada Banksy che le ha anche dedicato un murale a New York. Uscita di prigione, la storia di Zehra è diventata il libro “Prigione numero 5”, edito in Italia da BeccoGiallo.
Non era la prima volta che Doğan finiva in carcere. Prima del 2017, infatti, l’attivista aveva preso parte come caporedattrice a Jinha, la prima agenzia del mondo fondata e gestita interamente da donne. Un’esperienza nata nel 2012 e costretta a chiudere nel 2016, con il decreto legge numero 657 emesso dal presidente Recep Tayyip Erdoğan. In quell’occasione, Doğan fu condannata per apologia del terrorismo a nove mesi di carcere che scontò nell’istituto penitenziario della città di Mardin. Abbiamo incontrato l’attivista, ospite a Torino presso il centro culturale Polo del ‘900.
Durante la sua prigionia, ha realizzato più di 300 opere d’arte che ha fatto “evadere” dalla cella grazie all’aiuto delle sue compagne. Come le ha realizzate e come ha fatto a essere così produttiva?
ZD Le opere sono uscite dal carcere in maniera illegale, senza che gli agenti si accorgessero di nulla. Non posso rivelare i dettagli. Ma è vero che è stato un lavoro collettivo, così come lo è stata la loro realizzazione. Le opere sono state create con materiali di fortuna: i colori sono stati ricavati utilizzando frutta o verdura schiacciata, avanzi di cibo, anche il sangue mestruale; i pennelli sono stati fatti con i capelli o le piume di piccione; per la carta ho usato le lettere che mi venivano recapitate o carta di giornale recuperata. Per fare tutto questo è servita la collaborazione di un gran numero di persone. Nelle mie opere, insomma, c’è anche un pezzetto di ciascuna di loro. Riguardo al fatto che sia stata così produttiva, io stessa non so come sia avvenuto: sicuramente lo sono stata come reazione al luogo in cui mi trovavo, la prigione, dove mi era impedito di esprimermi, anzi, dove ero finita proprio a causa della mia espressione. Non realizzare quelle opere avrebbe significato accettare la pena. Tra l’altro, quando ho disegnato la distruzione di Nusaybin, mi trovavo nel punto più basso delle mie motivazioni, non avevo prospettive. In carcere, invece, ho sentito il bisogno di disegnare, di raccontare ciò che stava accadendo. Ecco, è stato il mio modo di ribellarmi, di fare resistenza al tentativo esterno di silenziarmi.
Che cosa rappresentano le sue opere?
ZD Sicuramente il corpo delle donne è un simbolo ricorrente. Io stessa mi sono spesso chiesta quale significato attribuirgli. È propaganda? È provocazione? Sono arrivata alla conclusione che non si tratta né dell’una né dell’altra. È arte che assume valenza politica ma non perché io voglia fare arte politica ma perché sono una donna che si occupa di politica e che fa arte. Per come la vedo io, l’arte è un modo di esprimersi ed esige un’estrema onestà: essendo io una donna che si occupa di politica, lascio che ciò traspaia nella mia produzione. C’è poi un aspetto particolare nei miei lavori che ha a che fare con la deformazione delle figure femminili e con il fatto che le donne nelle mie opere hanno spesso gli occhi aperti, spalancati. Sono due elementi che per me hanno un grande valore: la distorsione che subiscono i corpi delle donne che io ritraggo è quella imposta da secoli di sguardo maschile, di manipolazione da parte di un sistema maschile oppressivo. E gli occhi aperti stanno a significare che queste donne guardano in faccia la realtà senza avere paura di affrontarla.
È stata condannata per un disegno e ha usato l’arte per rivendicare questa ingiustizia. Nelle sue opere qual è la relazione tra arte, attivismo e giustizia?
ZD A questa domanda tendo a dare sempre la stessa risposta che però per me assume un significato molto grande e si rifà a quanto sosteneva Frantz Fanon, il quale raccomandava agli artisti di assumere un ruolo politico a partire dalla loro esperienza personale. L’artista che vuole incidere in qualche modo su questioni politiche non può limitarsi a rimanere chiuso nel suo atelier, ma deve trovare una sua collocazione in un movimento reale. È il motivo per cui la mia opera è stata così incisiva: perché rivela l’onestà con cui io l’ho prodotta in quanto parte in causa. Le mie opere rappresentano la mia posizione all’interno di uno scontro, di un conflitto. Non è un caso se c’è chi ha trovato una similitudine tra il ritratto dell’assedio di Nusaybin con il “Guernica” di Picasso: non si tratta di una parentela stilistica ma di un legame con la veridicità con la quale mi sono accostata all’opera e con ciò che essa ha saputo trasmettere.
“Le carceri sono luoghi dove la resistenza si accumula e organizza. Ogni persona entrata lì dentro ha lasciato qualcosa di sé: sui muri si è stratificata l’eredità della resistenza curda”
In una passata intervista, a proposito del carcere, ha detto che “ne è valsa la pena”. Pensa di essere diventata un’artista grazie al periodo di detenzione?
ZD In realtà non mi sono mai definita “artista”, né prima del carcere né ora. Perché questa definizione è un po’ ingombrante, rappresenta più di quanto io mi senta. Nella mia lingua siamo abituati a sentirci chiedere “ne è valsa la pena?” come se dovessero farti rimpiangere o pentire delle scelte fatte. Io non mi pento di nulla, non mi pento delle espressioni artistiche che ho usato per denunciare il governo turco. È chiaro che avrei preferito non farmi nemmeno un minuto di carcere, però devo ammettere che quell’esperienza è stata un percorso di crescita e consapevolezza politica. E poi, nella realtà che viviamo, i popoli oppressi sono costretti a pagare un prezzo per la loro libertà.
Più in generale, il carcere è un luogo straordinario in merito alla costruzione del movimento di resistenza curdo dove la resistenza si accumula e organizza. Io questa storia l’ho assorbita proprio nei luoghi di detenzione e mi è servita da fonte di ispirazione. Ogni persona entrata lì dentro ha lasciato qualcosa di sé: sui muri si è stratificata l’eredità della resistenza curda e se hai una sensibilità artistica puoi cogliere dei segni all’interno di queste strutture e comunicarli all’esterno. Magari per la vostra cultura può sembrare strano quanto sto dicendo ma in Turchia l’attivismo si consolida in prigione e il movimento curdo continua a esistere attraverso esso.
Pensa ancora al carcere? Teme di tornarci?
ZD Sicuramente se io tornassi in Turchia (Doğan attualmente vive a Berlino, ndr) sarei di nuovo arrestata. Non so quale potrebbe essere l’iter questa volta perché la Turchia è un Paese imprevedibile. Ma so che durante la mia assenza continuano a cercarmi a casa, a importunare i miei parenti. Mesi fa mia nipote che vive ad Ankara è stata fermata dai servizi segreti che l’hanno minacciata per avere informazioni su di me.
Prima di finire in prigione, ha vissuto diversi mesi in clandestinità. Che cosa ha provato?
ZD Per quanto riguarda il periodo di illegalità prima della mia cattura posso dire che è meglio la prigione, per tutta una serie di fattori: prima di tutto, per quanto lunga può essere la pena, sai quando finirà. Mentre quando fuggi è tutto più indeterminato.
A questo si aggiunge che tu stessa ti collochi all’interno di una prigione perché non sai dove andare, interrompi le relazioni con i tuoi parenti, non fai nulla perché qualsiasi cosa tu faccia rischia di farti arrestare, e così finisci per esistere come un morto vivente, ti riduci a essere l’ombra di te stesso. Può sembrare paradossale ma il carcere offre condizioni migliori perché sei inserito all’interno di una comunità, ti rapporti con altre persone che condividono la tua stessa situazione, e con loro puoi prendere anche parte a forme di resistenza collettiva.
Che futuro vede per la causa curda?
ZD Si è imposta una visione semplicistica per cui il problema dei curdi sia Erdoğan. Ma le violenze verso le minoranze affondano le proprie radici nella nascita della repubblica. C’è l’ombra di Atatürk sulle stragi contro i curdi, contro gli armeni, contro i greci. Solo prendendo coscienza dell’origine di queste vessazioni si potrà ottenere un processo di pacificazione duraturo che non tocchi però solamente i vertici politici ma il sentire comune delle persone.
© riproduzione riservata