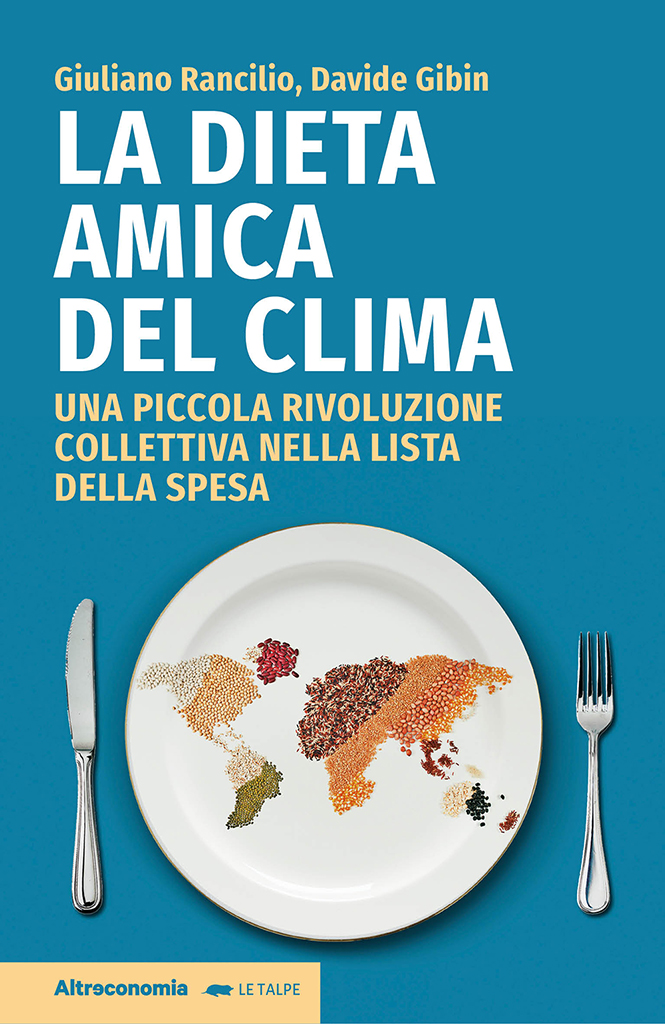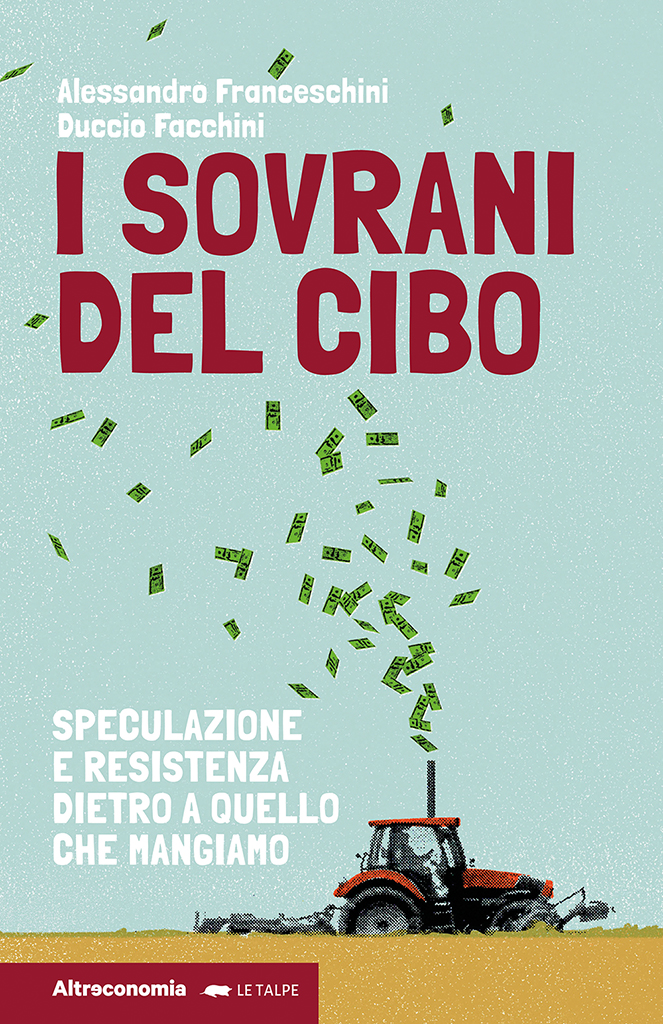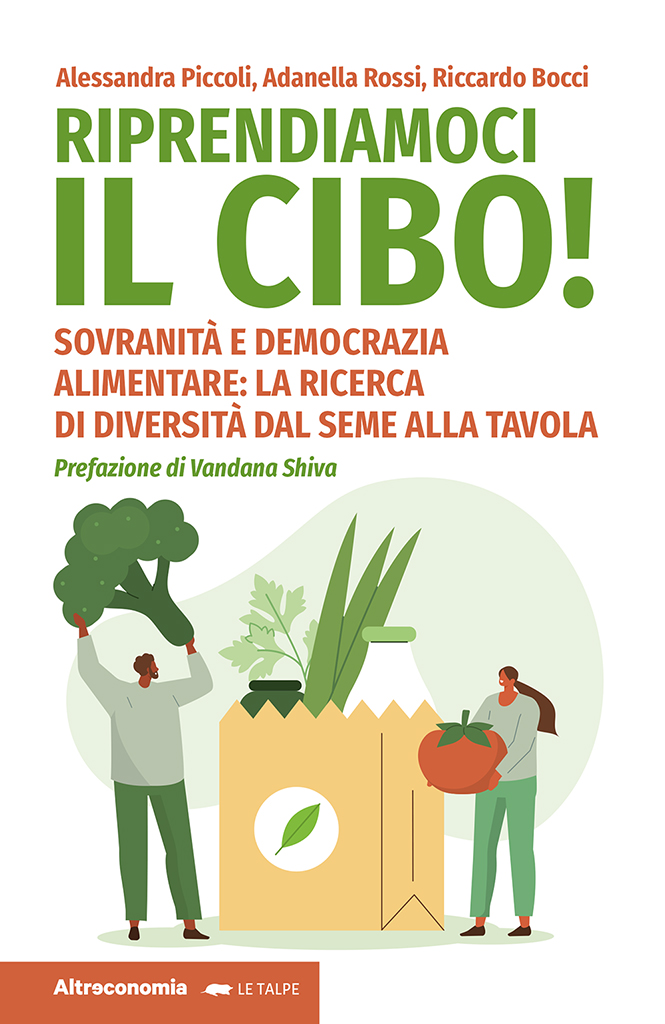Terra e cibo / Intervista
“Until the end of the world”, il documentario che racconta l’allevamento intensivo di pesci

Da più di dieci anni Francesco De Augustinis indaga le filiere agroalimentari e il loro impatto. Per il suo ultimo lavoro ha viaggiato in tre continenti sfatando la narrazione ancora oggi diffusa sulla presunta sostenibilità e sugli impatti reali dell’acquacoltura, pratica che interessa almeno 130 miliardi di esemplari. Il 5 giugno verrà proiettato al festival CinemAmbiente di Torino
Non si parla ancora abbastanza di acquacoltura. Se infatti la consapevolezza delle problematiche causate dagli allevamenti intensivi di animali da terra è piuttosto diffusa (80 miliardi di esemplari), il dibattito su quelli di pesce è ancora ai suoi albori (130 miliardi di esemplari). Eppure anche questi sono modelli intesivi di produzione che hanno conseguenze simili a quelli di polli, tacchini, galline, mucche e maiali.
È questo che racconta Francesco De Augustinis, documentarista e giornalista indipendente che da più di dieci anni indaga le filiere agroalimentari e il loro impatto. Il suo ultimo documentario “Until the end of the world” è infatti un’inchiesta sull’acquacoltura, l’industria alimentare in più rapida crescita al mondo. Secondo i dati della Fao la quota di pesci prodotta in allevamento, dopo un’impennata negli ultimi trent’anni, ha superato quella di pescato e nel 2021 si attestava a 126,04 milioni di tonnellate (a fronte di 92,18 milioni di tonnellate pescate).
In “Until the end of the world” De Augustinis mostra il suo viaggio in tre continenti e prova a sfatare la narrazione più diffusa oggi sugli allevamenti di pesce. Istituzioni internazionali come la Fao li promuovono infatti come un modello sostenibile per l’ambiente, per ridurre l’overfishing, sfamare la popolazione mondiale e rendere le diete occidentali più sostenibili.
Il documentario, tuttavia, espone una realtà diversa: comunità locali di diverse regioni, come gli abitanti dell’isola di Poros in Grecia o la popolazione indigena Kawésqar in Cile, lottano contro l’espansione degli allevamenti ittici accusati di inquinare le acque incontaminate, di impossessarsi delle risorse naturali e persino di favorire la fame e l’insicurezza alimentare.
Il 5 giugno sarà presentato alla ventisettesima edizione del festival CinemAbiente organizzato dal Museo nazionale del cinema di Torino e dedicato ai film a tema ambientale, che si terrà dal 4 al 9 giugno e a cui parteciperà anche Altreconomia con la presentazione del suo volume “Antropocine, lo schermo verde. Manuale di percorsi e idee per un Italian Ecocinema” del ricercatore e giornalista Marino Midena.
De Augustinis perché ha deciso di focalizzarsi sull’acquacoltura?
FDA È stato un percorso di ricerca che mi ha portato a lavorare su questo tema. Tutto è iniziato tra il 2018 e il 2019 quando è nato One Earth un progetto di giornalismo indipendente attraverso cui ho prodotto oltre a “Until the end of the world”, altri due documentari: “Deforestazione Made in Italy” e “One Earth, tutto è connesso”. Quest’ultimo nello specifico raccontava l’esplosione dei problemi ambientali, climatici, etici e anche di salute legati all’aumento di allevamenti intensivi di animali da terra. Si parlava di un numero spaventosamente grande: 80 miliardi di animali allevati ogni anno nel mondo. Ma c’era un altro numero che emergeva da quel lavoro che era ancora più sorprendente: circa 130 miliardi di animali d’acqua allevati. Questo è stato il primo campanello d’allarme. Il secondo è stato il sostegno allo sviluppo dell’acquacoltura da parte di istituzioni nazionali e internazionali. Nei due precedenti documentari emergeva la consapevolezza del fatto che dobbiamo cambiare il nostro sistema alimentare perché è insostenibile. Tra le soluzioni proposte dalla Fao e da altri soggetti internazionali spesso ricorreva l’acquacoltura con l’idea che non potendo permetterci di produrre tutta questa carne, potremmo mangiare più pesce (la cosiddetta Blue transformation). Grazie a questa narrativa, l’Europa, il Regno Unito, gli Stati Uniti e altri stanno sostenendo attivamente la creazione di allevamenti in mare di pesce perché in realtà oltre il 90% delle specie ittiche sono già sovrasfruttate o sono ai limiti massimi dello sfruttamento. Questo vuol dire che se si vuole produrre di più non si può contare sulla pesca che è già al suo limite massimo, e quindi si propone di ricorrere all’acquacoltura. Però questa è una narrativa sbagliata ed è quello che abbiamo cercato di raccontare in questo lavoro.

Perché questo è il momento più giusto per parlare di allevamenti di pesci?
FDA Negli ultimi anni per fortuna si è creato un grande dibattito sugli allevamenti intensivi degli animali da terra, mentre questo manca ancora per quelli di pesce. L’acquacoltura è infatti un fenomeno più recente che si è sviluppato negli ultimi trent’anni, per cui ancora oggi l’industria descrive sé stessa come incredibilmente sostenibile. Per questo è importante invece raccontarla come un’industria che ha problemi identici a quelli degli allevamenti di terra, ovvero è un sistema intensivo di produzione che non tiene conto del benessere degli animali, inquina paradisi terrestri dove vengono messi milioni di pesci e distrugge risorse. Come racconta il documentario, oltre a provocare lo sfacelo degli ecosistemi marini, c’è infatti anche un tema legato alla produzione di mangimi. La maggior parte dei pesci allevati sono carnivori e la quantità di pesce selvatico usato per i mangimi è maggiore di quella che poi effettivamente si produce negli allevamenti. Questo è uno dei principali paradossi che abbiamo raccontato e il motivo alla sua base è prettamente economico. Con il termine acquacoltura si intendono tanti tipi di produzione: dalle alghe alle vongole, ai piccoli pesci. Se si decide di darle appoggio incondizionato dicendo che è sostenibile, si sviluppa maggiormente quella che ha più valore economico, cioè l’allevamento di salmone, spigole, orate e altre varietà che sono redditizie. La quantità cambia a seconda della specie, ma l’industria stessa ammette che per produrre un chilogrammo di spigole o orate, ha bisogno di almeno 1,2/1,4 chilogrammi di pesce selvatico. Quindi il rapporto è maggiore di uno e anche se fosse pari a uno, stiamo comunque parlando di trasformare pesce commestibile e a disposizione di persone che ne hanno bisogno per sfamarsi, in farine per nutrire degli animali per farne un prodotto “ricco”, perché il salmone è un prodotto solitamente per una nicchia, non ha lo scopo di sfamare la popolazione mondiale.

Per questo le persone che ha intervistato parlano di questo sistema di allevamento come una pratica di neocolonialismo?
FDA Questo aspetto è emerso dalle comunità che abbiamo incontrato: per motivi diversi parlavano sempre di colonizzazione. Abbiamo sentito questa parola per la prima volta in Grecia, che non è proprio un Paese dove ti aspetteresti di sentirla e poi di nuovo in Senegal e in Cile. Perché parlano di colonizzazione? Perché vedono queste industrie crescere con l’appoggio di fondi e governi prendere il controllo di intere porzioni di territorio, di risorse che sarebbero essenziali per la loro vita. In Grecia, nell’isola di Poros, ci sono due fondi di investimento, uno statunitense Amerra e uno degli Emirati Arabi Mubadala che prenderanno il controllo di un quarto dell’isola e del suo mare per insediare progetti di acquacoltura. E questo rischia di essere un colpo mortale per la sua economia che vive di piccola pesca di sussistenza e soprattutto di turismo. E loro parlano di colonialismo perché non hanno voce in capitolo, subiscono e basta. Tutta l’isola è contraria, le amministrazioni, i sindaci e la popolazione ma non possono fare nulla. Lo stesso abbiamo visto in maniera ancora più eclatante in Senegal che basa la sua dieta sulla pesca dei piccoli pelagici come sardine, aringhe. Lì le aziende straniere, perlopiù europee, fanno accordi con il governo senegalese e rastrellano i mari per prendere questi pesci che vengono poi usati per i mangimi, per fare farina e olio di pesce per i nostri allevamenti. Questo per loro è neocolonialismo nel senso di sottrazione di risorse senza che sia possibile opporsi.

Uno degli aspetti più interessanti dei suoi documentari è la capacità di collegare fenomeni che interessano parti del mondo molto distanti tra loro. Il titolo del documentario “Until the end of the world” è riferito infatti al fatto che è arrivato fino in Patagonia per raccontare l’acquacoltura. Forse ci vuole anche suggerire fino a dove ci stiamo spingendo?
FDA L’idea del titolo è nata arrivando nella Patagonia cilena a Punta Arenas, una cittadina che si affaccia sullo Stretto di Magellano che era nota come la fine del mondo. Questa cosa per me era evocativa del fatto che esiste un’industria, quella dell’acquacoltura, che con l’idea di crescere e di usare sempre più risorse si è spinta fino ai confini della civiltà per andare ad allevare salmone e pescare materie prime nell’Oceano antartico -come il krill che è l’ingrediente base della dieta di tutti gli animali che vivono in Antartide, pinguini, balene, uccelli marini e altri-. Ma fino alla fine del mondo è anche in senso temporale, se continuiamo a credere di poter far crescere in maniera indiscriminata il sistema alimentare, quando già usiamo più risorse di quelle di cui abbiamo disposizione, quello a cui andiamo incontro è necessariamente la fine del mondo, non in assoluto del Pianeta, ma del mondo come noi esseri umani lo conosciamo.
© riproduzione riservata