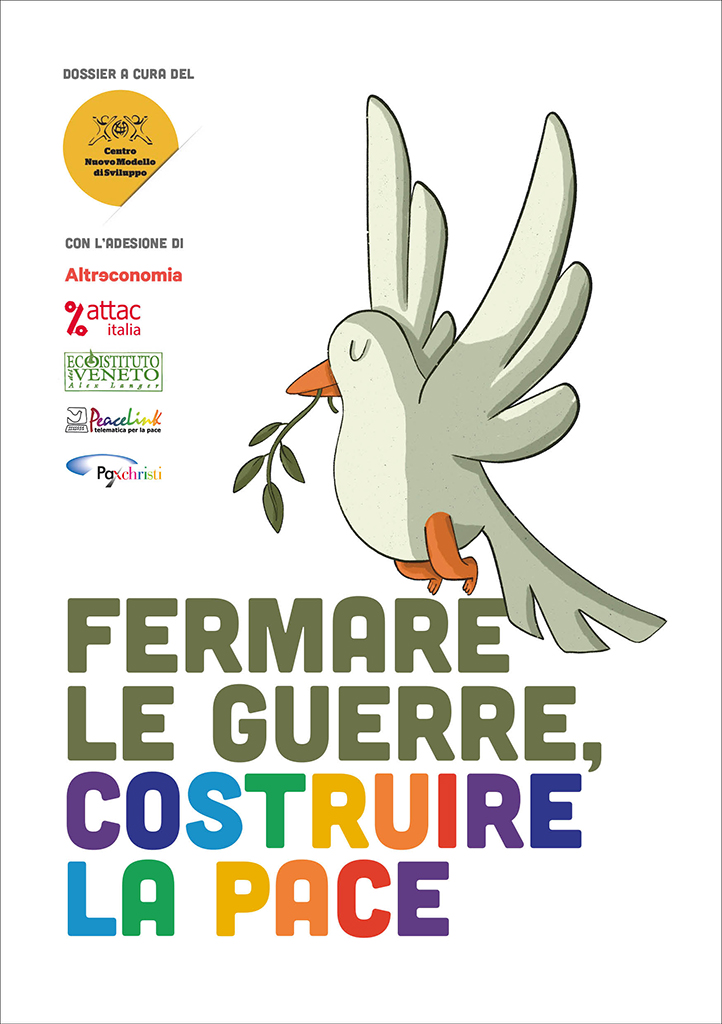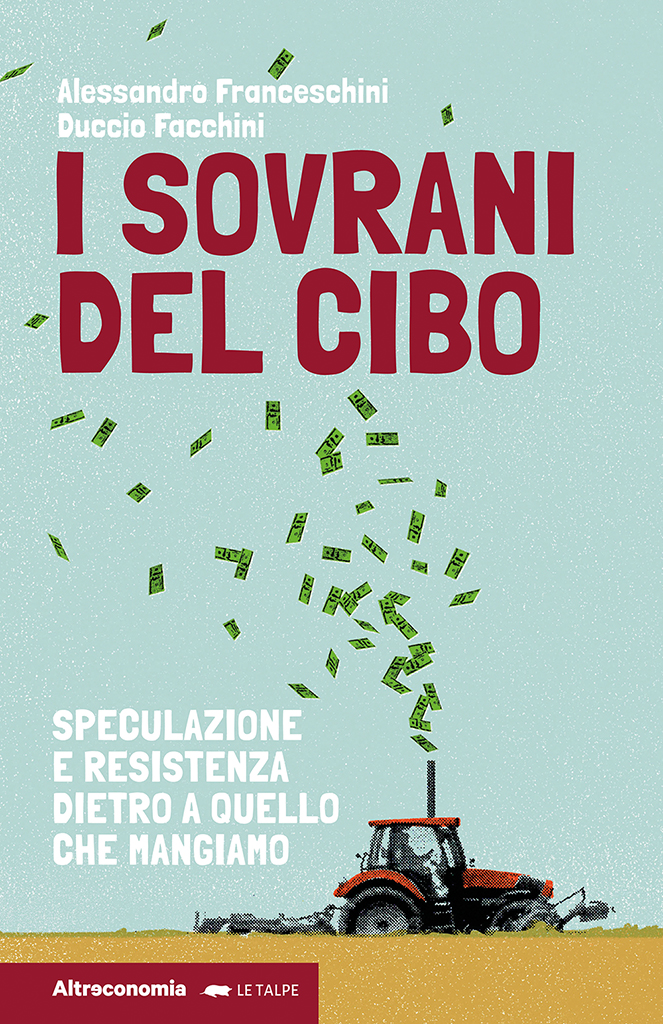Altre Economie / Attualità
Servono pascoli e prati stabili per tutelare la biodiversità

Gli allevamenti come il Satiro dei fratelli Brighi a Novafeltria (RN) sono fondati sul benessere animale e allo stesso tempo preservano il paesaggio montano. I pastori che li gestiscono sono riconosciuti come Custodi delle terre alte
Il vello delle capre allevate dai fratelli Nicola e Lorenzo Brighi è luminoso. “Sono animali sani”, racconta Nicola. Ha 33 anni e insieme al fratello minore, trentenne, ha iniziato quattro anni fa l’avventura del Satiro, acquistando tre capre gravide per farle pascolare nei campi vicino casa, a Legnagnone, nelle campagne di San Leo (RN).
“Vivevo a Bologna, sono un musicista. Il Covid-19 mi aveva lasciato a terra”, spiega Lorenzo. Prima di prendere le capre, per un periodo ha raccolto mele in Trentino, passando quindi come woofer in un piccolo allevamento. “Dopo quella esperienza abbiamo preso coraggio e ci siamo lanciati seguendo i consigli di un amico di famiglia, Paride, dell’azienda vinicola Tenuta Santa Lucia di Mercato Saraceno (FC)”, aggiunge Nicola, che prima di dedicarsi al Satiro era direttore commerciale per l’azienda di famiglia, che produce infissi a Santarcangelo di Romagna.
“Abbiamo visto nell’allevamento di capre e nella lavorazione del latte per farne formaggio uno strumento per esprimere il nostro punto di vista sul mondo”, sottolineano insieme i due fratelli. Quando il numero di capi è cresciuto, arrivando a una ventina, hanno scelto di rilevare un vecchio caseificio a Casano, nel territorio del Comune di Novafeltria (RN). La proprietà corre lungo il crinale tra le valle del fiume Marecchia e quella del torrente Uso. Lo sguardo corre fino alla Riviera romagnola. “Pascolo con vista”, scherza Nicola. La proprietà intorno alla stalla è di 32 ettari che in parte sono bosco. Nove sono di pascolo su prati stabili, ricchi di biodiversità, insetti, farfalle.
“Quel campo è ricchissimo di essenze, sono almeno cinquanta in primavera”, sottolinea Lorenzo. È lui che, dopo aver frequentato l’Accademia internazionale dell’arte casearia a Treviso, si occupa di trasformare il latte in formaggio. “Seguiamo l’idea del pascolo razionale, nell’ultimo anno abbiamo inserito anche le vacche da carne -racconta Nicola-, perché accanto alle capre completano la copertura del pascolo e lo fertilizzano, permettendo una gestione ottimale dei prati”.
Durante l’autunno e l’inverno, quando i pascoli sono stressati, l’alimentazione in stalla è il fieno dell’azienda agricola Corelli di Pennabilli (RN), da prati stabili alle pendici del Monte Carpegna. Il resto della “razione” è dato da cereali coltivati su terreni di proprietà, mentre il mais biologico è acquistato. “Grazie all’uso della schiacciatrice possiamo creare una miscela che permette di far digerire al meglio il cereale all’animale -dice Lorenzo, che lavora a latte crudo circa cento litri di latte al giorno-. Oggi le nostre capre sono 85 di cui 47 in lattazione. La stalla è tarata su un massimo di cento animali. Potrei arrivare a trasformare 280 litri di latte”.
Il senso del limite fa parte della filosofia aziendale, come la volontà di proporre formaggi per tutti, spingendo al massimo la qualità. “La strategia aziendale è costruita sul benessere animale -spiega Nicola- perché la capra che sta bene garantisce un latte di alta qualità, che regala formaggi buoni e sani”. Il Satiro è una delle trenta aziende agricole in tutta Italia che hanno aderito al nuovo presidio Slow Food “Prati stabili e pascoli”, presentato in occasione dell’ultimo Terra Madre Salone del Gusto 2024, che si è tenuto a fine settembre a Torino. È figlio del progetto “Salviamo i prati stabili e i pascoli”, nato per portare l’attenzione dell’opinione pubblica su un patrimonio di valore e a rischio scomparsa, sulle Alpi, sugli Appennini, in collina e in pianura.
Le superfici diminuiscono in montagna per via dell’abbandono e in pianura per l’avanzare di monocolture e cemento. La caratteristica dei prati stabili è quella di non essere arati, dissodati o coltivati, né sottoposti a diserbo o trattati con antiparassitari. Non sono, però, selvatici: i pastori li sfalciano e li curano portando gli animali al pascolo. A Torino i fratelli Brighi hanno ricevuto il riconoscimento di Custode dei prati stabili e dei pascoli. “L’azione del ‘custodire’ è fondamentale -secondo Slow Food-. L’essere umano fornisce il proprio contributo nella custodia e nel mantenimento dei delicati equilibri delle terre alte”.
Tra gli altri custodi c’è Gian Vittorio Porasso, pastore piemontese che con il suo gregge di 130 capi passa nove mesi a Castelnuovo di Ceva (CN), a 750 metri sul livello del mare, portandolo poi in alpeggio ai 1.360 metri di Paraloup, in Valle Stura, nei pascoli intorno alla borgata alpina che fu sede della prima brigata partigiana, recuperata dalla Fondazione Nuto Revelli. “Sono qui perché c’era la volontà di recuperare una porzione di pascolo abbandonato”, afferma Porasso, rimasto in montagna sino alla fine di settembre. Classe 1969, è diventato pastore 18 anni fa. “Quando ho acquistato la cascina di Castelnuovo ero un giovane architetto e avevo una specie di sogno -racconta-. Mia mamma era originaria di Ormea (CN), poi la sua famiglia si trasferì a Ceva (CN), era gente che aveva le capre”.

Per lui il pascolo è vita: “Nel 2009 a ‘Cheese’ -fiera internazionale del formaggio di Bra (CN)- indossavo una maglietta con il motto ‘Pascolo ergo sum’. Ho senso di esistere come pastore perché porto gli animali al pascolo. Lì pulsiamo insieme come un unico organismo bilanciato. Non potrei fare questo mestiere da stanziale in pianura -osserva-. L’allevamento all’aria aperta, il mantenimento dei pascoli, la biodiversità, sono alla base della nostra produzione. Non ho mai associato l’allevamento a una stalla”. Per gli animali, il pascolo è fonte di benessere: “Ai miei brillano anche gli occhi”. Per questo anche in inverno, durante la giornata, gli regala qualche ora di pascolo libero, “nei versanti esposti a Sud che restano presto senza neve”.
Una scelta, la sua, che non è legata solo alla volontà di conservare il paesaggio e la biodiversità, ma che pone l’accento sul valore nutraceutico dei formaggi: sono più ricchi e non è solo una questione di gusto. Forte del proprio percorso, Porasso affronta anche in modo non convenzionale uno dei grandi temi del pascolo contemporaneo, cioè la coesistenza con i predatori, in particolare il lupo: “Rappresenta una minaccia, ma se uno fa il pastore a tempo pieno, presidiando il gregge ogni giorno con i cani, questo funziona come deterrenza”.
Offre spunti non convenzionali anche Viola Marcelli, che da alcuni anni con il fratello Jacopo ha affiancato i genitori Nunzio Marcelli e Manuela Cozzi alla Porta dei Parchi di Anversa degli Abruzzi (AQ), da quarant’anni un presidio agricolo nella Valle del Sagittario. “Lavoriamo a settecento metri sul livello del mare. I nostri capi pascolano 365 giorni all’anno, eccetto quando nevica, ma succede sempre più raramente”.
Gli animali hanno a disposizione oltre mille ettari, il 17% dei quali all’interno di aree protette. Il gregge è composto da 1.300 pecore e quattrocento capre. “Sono tutti animali da pascolo, di razze selezionate per camminare e pascolare. Non producono grandi quantità di latte ma è grasso, e poi danno lana buona e carne saporita. Pascolano dall’alba al tramonto. Quella dei miei genitori è stata una scelta sofferta, nel senso che le difficoltà ci sono, anche per mantenere lavori che stanno per scomparire”. L’azienda dà lavoro a venti persone, in un borgo di duecento. I pastori sono cinque. Nessuno di loro è italiano. Arrivano da Romania, Pakistan, Macedonia, Marocco: “Solo grazie a loro abbiamo potuto continuare ad allevare in questo modo. Le contaminazioni, a noi, piacciono parecchio”.
Dal suolo al piatto
“Stiamo provando l’esistenza di un trasferimento di biodiversità dal suolo al piatto, il fatto che la natura possa dare elementi nutrizionali incredibili”, spiega Andrea De Vecchi, che dopo la laurea in Medicina e chirurgia e la specializzazione in Scienza dell’alimentazione, sta svolgendo un dottorato di ricerca inter-ateneo -tra l’Università di Scienze gastronomiche di Pollenzo e quella di Torino- su cibo e nutrizione. L’analisi è sul valore nutraceutico dei formaggi da prati stabili, “non si concentra tanto su macro e micro-nutrienti (proteine, grassi, fibre, zinco, selenio) ma sui composti bio-attivi, quella gamma di elementi -come i polifenoli, una della classi più conosciute- che hanno un ruolo quasi farmacologico per l’organismo, in particolare contrastando patologie croniche non trasmissibili, che però possono essere ereditate attraverso i comportamenti di tutti i giorni, come la dieta, nell’accezione più corretta di stile di vita”.
© riproduzione riservata