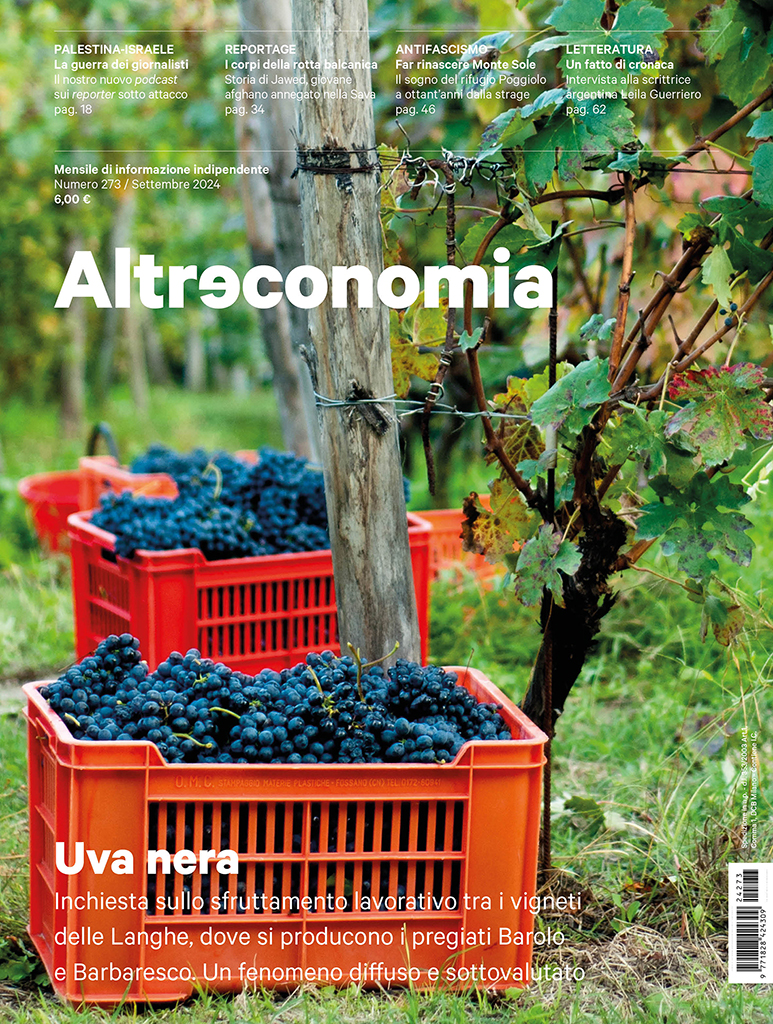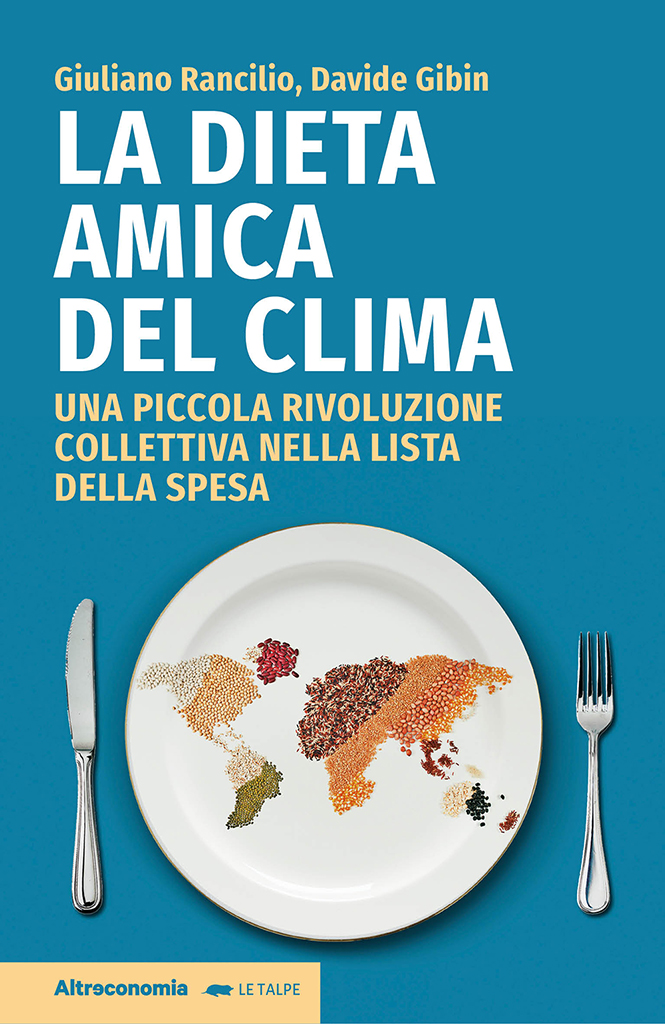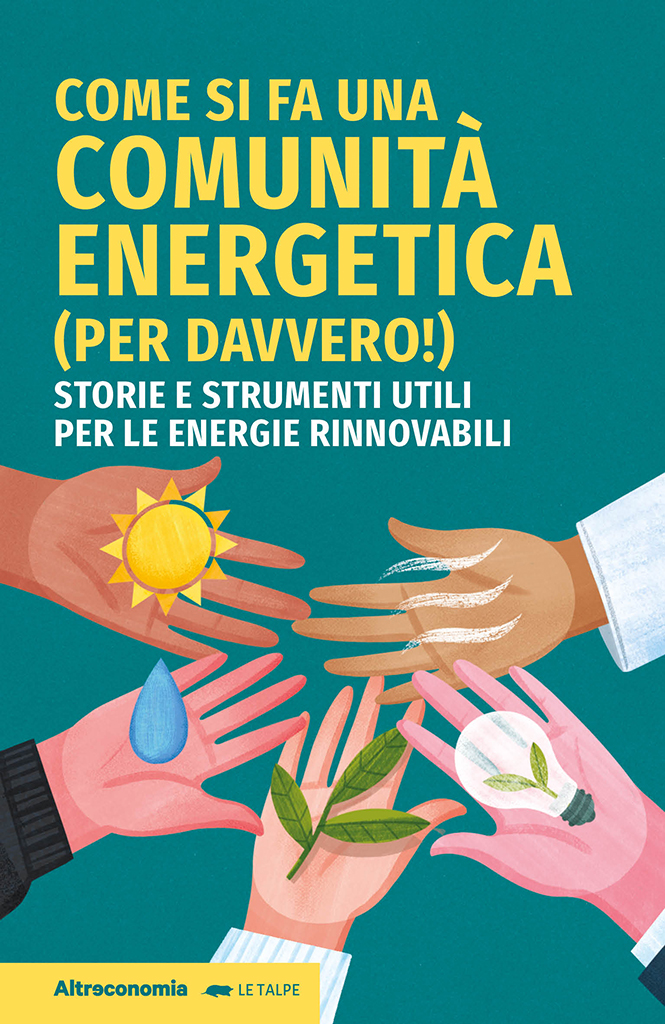Crisi climatica / Intervista
John Vaillant. Bruciati dal fuoco amico

Ne “L’età del fuoco”, pubblicato in Italia da Iperborea, lo scrittore racconta la storia della città di Fort McMurray, cuore dell’industria petrolifera canadese, rasa al suolo da un incendio. Da fonte di sviluppo, le fiamme diventano il nemico
“Non ho mai visto niente di simile. Per come è nato, per come si è spostato, per come si è comportato, ha riscritto le regole”. Sono le parole con cui il capo dei vigili del fuoco di Fort McMurray descrive l’incendio boschivo scoppiato nella notte del primo maggio 2016 e che nel giro di poche ore si è ingrandito per poi distruggere buona parte della città nel Nord della provincia canadese dell’Alberta.
Questo vasto incendio ha provocato l’evacuazione di tutti gli abitanti, oltre a ingenti danni economici, in una cittadina che è considerata il centro dell’industria petrolifera del Paese. È da questa vicenda che John Vaillant, scrittore e giornalista canadese, prende spunto ne “L’età del fuoco”, libro tradotto e pubblicato quest’anno in Italia dalla casa editrice Iperborea. Un reportage narrativo che indaga il rapporto profondo degli esseri umani con il fuoco.
“C’è dell’ironia nel fatto che un incendio divampato naturalmente distrugga un’industria basata sulla combustione artificiale. E questo è successo a Fort McMurray”
Da elemento centrale nello sviluppo della società contemporanea e nella crescita del settore petrolifero, il fuoco sta diventando sempre più temibile e distruttivo, anche a causa della crisi climatica.
Vaillant, il libro inizia con un breve prologo sull’incendio scoppiato nel maggio 2016, poi nella prima parte viene raccontata la storia dell’industria petrolifera canadese. Che ruolo ha avuto quest’ultima nella vicenda raccontata?
JV È una sorta di espressione vivida ed estrema del settore petrolifero globale. La narrazione delle questioni ambientali ha molto più effetto quando si cala in un luogo preciso, con persone particolari. Fort McMurray è un’anomalia, uno strano mostro creato dall’industria petrolifera che ha appetito per l’energia e per il denaro. Il settore si basa sulla combustione: per esso il valore è nel fuoco, perciò si può definire un’industria del fuoco. C’è dell’ironia nel fatto che un incendio divampato naturalmente distrugga un’industria basata sulla combustione artificiale. A Fort McMurray è successo questo: il fuoco scoppiato nella foresta è divampato attraverso la città distruggendo anche l’industria. L’aspetto sorprendente di Fort McMurray è che si può vedere tutto questo accadere in un luogo particolare, quasi come se la città si trovasse su un’isola. L’industria petrolifera ha creato un’enorme ricchezza, infatti Fort McMurray è una delle municipalità più ricche di tutto il Nord America, il reddito medio familiare è di circa 200mila dollari, nonostante la città sia isolata nella foresta boreale a circa mille chilometri a Nord del confine statunitense. Tuttavia, questa ricchezza economica è molto artificiale e precaria, tutta la nostra realtà è molto più fragile di quanto siamo disposti ad ammettere. Ho deciso di iniziare con l’industria petrolifera canadese perché era il modo più logico di impostare la storia, dato che questo mondo è così sconosciuto alla maggior parte delle persone, soprattutto agli americani, nonostante abitino vicino al Canada.

Il libro racconta la crescita esponenziale di residenti attratti da stipendi elevati, esemplificata da alcuni soprannomi, come “Fort McMoney” o “Fort Crack”. Che tipo di città è in realtà Fort McMurray?
JV È una città di persone in carriera, un luogo ambizioso perché si va lì per lavorare e ci si aspetta di venir ricompensati abbondantemente, non si va per il paesaggio o per la vita sociale. In molti sono arrivati a Fort McMurray con qualche conto particolare da pagare, come i prestiti per l’università, pensando di guadagnare velocemente per poi rientrare nelle loro cittadine. Spesso però si rimane bloccati al Nord perché si guadagna parecchio, si accendono dei mutui ma poi è difficile rivendere la casa e le persone restano come intrappolate. Fort McMurray è una città di lavoratori dominata dall’industria petrolifera, quasi mono-industriale. Questo settore è terribilmente inquinante perché la lavorazione del bitume è molto più impattante rispetto a quella del petrolio o al gas. Appena fuori dalla città ci sono quasi duemila chilometri quadrati di paesaggio distrutto dall’estrazione petrolifera e nessuno ha l’intenzione o le possibilità di risanarlo. In città invece si registrano tassi elevati di asma, di cancro e di altre gravi malattie e perciò le persone non pensano di invecchiare a Fort McMurray ma hanno un piano di fuga, e questo dice molto.
Il reddito medio famigliare di Fort McMurray è di 200mila dollari. La città canadese è una delle più ricche di tutto il Nord America grazie a un’economia che si è interamente sviluppata sull’estrazione di petrolio. La stessa industria che poi ha contribuito a raderla al suolo
Come si ottiene il petrolio in Alberta?
JV Il bitume è una sostanza simile al catrame che si trova in una matrice di sabbia intorno a Fort McMurray. Non è liquido e non è nemmeno petrolio. Per estrarlo bisogna scavare la sabbia, scaldarla finché il bitume non si scioglie, quindi raccoglierlo per poi riscaldarlo per far evaporare le frazioni utilizzabili, che possono cioè essere trasformati in diesel o in petrolio. In questo processo sono necessarie enormi quantità di gas naturale, che è già un ottimo combustibile ma che viene utilizzato per trasformare una sostanza che non è un combustibile in qualcosa che vi si avvicina e che poi deve essere nuovamente raffinato in un impianto molto distante. Questo processo estrattivo è folle e insostenibile e l’industria delle sabbie bituminose può sopravvivere solo grazie a enormi sussidi governativi. Infatti il settore ottiene quasi gratuitamente la terra e il gas e non ha costi d’esplorazione perché le sabbie bituminose si trovano in superficie. Oltre a queste circostanze particolari, le compagnie hanno bisogno di un mercato a cui vendere il petrolio, che è quello degli Stati Uniti a cui va la grandissima parte del greggio dell’Alberta.
“La questione è come possiamo dimostrare la nostra riconoscenza al fuoco, che ci ha fatto prosperare, andando allo stesso tempo avanti con la transizione”
Nel libro propone una definizione di essere umano, “homo flagrans”, che sottolinea il rapporto simbiotico della nostra specie con la combustione. Gli incendi devastanti sono un chiaro segno che gli esseri umani hanno ormai superato il limite?
JV Assolutamente. Ed è difficile ammetterlo perché il fuoco è stato un nostro fedele compagno che ci ha aiutato molto: possiamo dire che è come un cane, lo abbiamo addomesticato e incorporato nelle nostre esistenze. Voi lasciate il vostro bambino sul tappeto a giocare con il cane anche se, in realtà, questo discende dai lupi. Ma non lascereste mai vostro figlio con un lupo. Abbiamo quindi addomesticato il cane a tal punto che ci sentiamo sicuri a tenerlo in casa. La stessa cosa è successa con il fuoco. Nelle nostre case ci sono fuochi che bruciano, come nel camino, e lasciamo lì i nostri bambini, anche se sono presenti vari oggetti infiammabili. Paradossalmente, il fuoco ci è piaciuto troppo, siamo diventati troppo bravi ad alimentarlo. Ciò che ci ha fatto superare il limite è stato il passaggio dal carbone solido agli idrocarburi, che ha prodotto così tanta energia e l’ha resa così accessibile che ora abbiamo sovralimentato l’atmosfera al punto da rendere più facile la combustione degli incendi. Il fuoco avrebbe dovuto facilitarci la vita ma la nostra passione ha reso possibile che gli incendi si sviluppassero come non avevano mai fatto prima. Ora stiamo vedendo gli impatti atmosferici globali delle nostre attività che stanno cambiando l’intero Pianeta, qualcosa difficile da comprendere per le nostre menti e la nostra politica. La questione è come possiamo dimostrare la nostra riconoscenza al fuoco, che ci ha fatto prosperare, andando allo stesso tempo avanti con la transizione. È un enigma politico e quasi emotivo, e per risolverlo dobbiamo avere una comprensione profonda di chi siamo e da che cosa dipendiamo, per poi poter andare avanti.
Nell’ultima parte del libro, “La resa dei conti”, racconta la lunga presa di coscienza dei danni ambientali causati dall’umanità. I gravi incendi che sono scoppiati in Canada possono rappresentare una spinta decisiva per agire contro la crisi climatica?
JV Ciò che sorprende è la rapidità con cui le persone tornano al business as usual. Una delle cose che ho imparato scrivendo questo libro e che non mi aspettavo è la fedeltà quasi servile che abbiamo verso lo status quo. Fort McMurray è un esempio perfetto: l’incendio del maggio 2016 ha causato la più grande e rapida evacuazione dovuta a un incendio nei tempi moderni, è stato il disastro più costoso della storia canadese. Qual è stata la risposta? Ricostruire la città esattamente nello stesso modo e fare le stesse cose che si facevano prima. La popolazione ha scelto di ignorare la realtà della crisi climatica in cui viviamo, che in città ha mandato chiari segnali della sua pericolosità, preferendo invece il ritorno a uno status quo del XX secolo che è impossibile da mantenere. William Gibson, autore americano di fantascienza, scrive che “il futuro è qui, il futuro è già qui, solo che non è distribuito in modo uniforme”. Questa è la verità in termini di azione per il clima. Molte persone hanno visto quello che è successo a Fort McMurray e hanno capito che dobbiamo davvero cambiare le nostre politiche ambientali. Eppure, ci sono anche molte entità potenti, tra cui l’industria petrolifera, che non vogliono che le cose si evolvano perché continuano a trarre enormi profitti. È difficile sapere chi ne uscirà vincitore, ma ormai siamo consapevoli che nel nostro futuro si verificheranno parecchi danni ambientali a causa dell’esitazione delle persone e della politica a cambiare.
John Vaillant sarà in Italia per presentare il suo libro ‘L’età del fuoco’ (Iperborea): appuntamento al Festival Internazionale di Ferrara sabato 5 ottobre e al Festival Pianeta Terra di Lucca domenica 6 ottobre
© riproduzione riservata