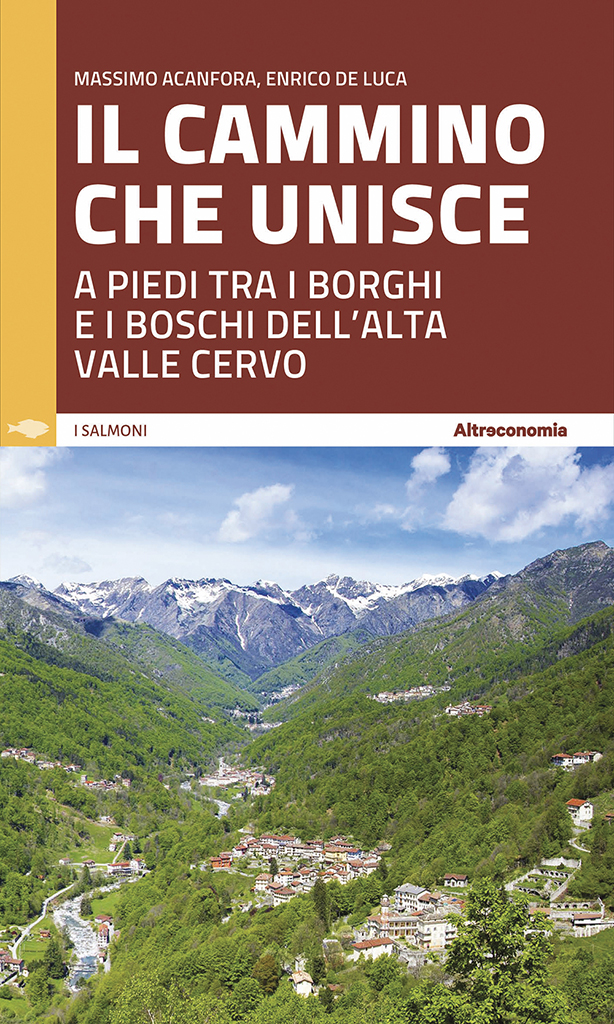Cultura e scienza / Intervista
Igiaba Scego. Una famiglia in mezzo alla storia tra la Somalia e l’Italia

Nel suo ultimo romanzo, “Cassandra a Mogadiscio”, la scrittrice riflette sul legame coloniale tra i due Paesi, sull’uso della lingua e sulle cicatrici provocate dal trauma delle migrazione e della fuga. Una vicenda autobiografica che fa in realtà memoria collettiva, recuperando le testimonianze di chi è stato privato del proprio passato
L’immagine in bianco e nero della copertina di “Cassandra a Mogadiscio” raffigura due donne: una ha i capelli chiari e folte sopracciglia, l’altra ha la pelle scura e indossa un garbasar, un abito tradizionale somalo. La fotografia è stata scattata nel 1956 alla Fiera campionaria di Milano e per la scrittrice italo-somala Igiaba Scego (in foto) ha un significato particolare: “L’abbiamo ritrovata io e mio fratello Abdul nell’archivio della Fiera ed è l’unica che raffigura la mia hooyo, mia madre, da giovane”, spiega la scrittrice italo-somala che a febbraio 2023 ha dato alle stampe il suo ultimo libro per i tipi di Bompiani.
Nata a Roma nel 1974 da genitori rifugiati in Italia dopo essere fuggiti alla dittatura di Siad Barre, Scego inizia questo racconto autobiografico dalla notte di Capodanno del dicembre 1990: mentre si prepara per andare a una festa con gli amici, ascolta al telegiornale le notizie dei primi scontri a Mogadiscio che segnano l’inizio della guerra civile nel Paese del Corno d’Africa. Un conflitto che, con forme diverse, si trascina ancora oggi. “Questo libro è nato dall’urgenza di raccontare la storia della mia famiglia. Negli ultimi anni mi sono resa conto di essere una sorta di ‘ponte’ tra il Novecento e il Ventunesimo secolo, tra mia madre e mia nipote Soraya (la figlia del fratello, ndr) che non hanno una lingua in comune che permetta loro di comunicare”.
“Cassandra a Mogadiscio” è costruito sotto forma di lettera alla giovane, cui Scego racconta la storia della famiglia intrecciandola a quella del Paese d’origine, all’esperienza della diaspora e al trauma della guerra civile. Un testo in cui l’italiano si mescola a decine di parole in somalo, restituendo così la musicalità di un lessico intimo e misto cui si aggiungono anche termini in arabo (lingua della pratica religiosa), in portoghese e in inglese parlato dalla giovane Soraya.
Igiaba Scego, come è nata questa tua ultima pubblicazione?
IS Ha origine da una mia riflessione autobiografica: non è la prima volta che provo a parlare della mia famiglia e del mio passato, lo avevo fatto anche in altre pubblicazioni precedenti, ma sentivo di non essere mai riuscita a scavare veramente in profondità. Durante la pandemia da Covid-19, quando sono stata costretta a restare a lungo sola in casa, ho avuto la possibilità di riflettere su questo tema e nel 2020 mia madre, che aveva avuto qualche problema di salute, è tornata a vivere con me. Questa situazione ha creato la condizione ideale per parlare e confrontarci sulla storia della nostra famiglia, ho raccolto la sua testimonianza e ho capito che il nodo di tante questioni irrisolte della nostra famiglia erano legate alla guerra civile somala.
Chi sono gli autori da cui hai tratto ispirazione per impostare il tuo racconto sotto forma di lettera a Soraya?
IS Il mio principale riferimento -non solo per questo libro, ma per tutta la sua riflessione sui temi della razza- è lo scrittore afro-americano James Baldwin, che nel 1963 scrisse al nipote una lettera sul tema dell’emancipazione. Un altro modello per me molto importante è stata bell hooks, in particolare nella sua riflessione sul fatto che l’autobiografia è politica. Mi sono formata sui testi di intellettuali e scrittori afro-americani e afro-europei. Non a caso la prima parola di questo libro (“Amatissima”) è un omaggio a Toni Morrison ed è un modo per legarmi a quella tradizione
Nel racconto fai ampio ricorso a termini della lingua somala, una di quelle che ricorre più frequentemente è jirro. Che cosa significa?
IS Letteralmente vuol dire “malattia”. Può indicare semplicemente il raffreddore ma anche la malattia dell’anima e io l’ho usata nel suo significato più ampio per descrivere la sofferenza nata dalle tante difficoltà vissute dalla mia famiglia a seguito della guerra, della fuga e dell’esilio.
Nel testo si racconta bene come i traumi provocati dalla guerra e dall’esilio permangano nel tempo e si “tramandino” a chi non ha mai vissuto direttamente queste esperienze.
IS Si tratta di un tema che è stato studiato a fondo dalla psichiatria, l’esempio più significativo in tal senso è quello della Shoah: le generazioni successive hanno ereditato i traumi dei sopravvissuti, sotto forma di un malessere che può portare alla depressione e persino al suicidio. Anche il trauma della guerra può essere ereditato e in molte famiglie migranti viene trasmesso dai genitori a figli e nipoti. Il fatto di non parlare apertamente di quello che si è vissuto, ad esempio, è un problema. Invece occorre affrontare questo vissuto per superarlo. Il libro, in questo senso, vuole essere una cura.
Per te l’italiano è la lingua madre, mentre i tuoi genitori l’hanno studiata durante gli anni della colonizzazione della Somalia. È la stessa lingua?
IS Ho molto riflettuto sull’italiano che uso e che amo profondamente, ma che per la Somalia è la lingua del potere gerarchico e coloniale, quella del generale Rodolfo Graziani per cui mio nonno lavorava come traduttore. Negli anni Cinquanta, quando l’Italia ha esercitato il mandato fiduciario delle Nazioni Unite, è diventata la lingua della burocrazia. Poi è successa un’altra cosa: i somali l’hanno risignificata ascoltando le canzoni pop di Gianni Morandi e Adriano Celentano, e l’hanno fatta propria. Ma c’è un altro italiano, che viene parlato ancora oggi nelle questure ed è un italiano duro e ostile con cui si scontrano tutti gli stranieri che devono rinnovare il permesso di soggiorno.
Gli italiani hanno a lungo rimosso il proprio passato coloniale, come si spiega questo fatto?
IS Quel passato era stato rimosso perché scomodo: rimandava al fascismo e alla sconfitta subita al termine della Seconda guerra mondiale. Inoltre, Roma ha cercato di rifarsi una “verginità” in Africa quando nel 1950 le Nazioni Unite le hanno affidato l’amministrazione fiduciaria della Somalia: una situazione paradossale in cui all’ex colonizzatore venne affidato il compito di accompagnare il giovane Stato da poco indipendente verso la democrazia. Oggi, fortunatamente, questa rimozione del passato coloniale è stata in parte superata grazie al lavoro di studiosi come Angelo Del Boca, scrittori come Gabriella Ghermandi e Francesca Melandri. Oggi l’Italia è diversa rispetto a quello in cui arrivarono i miei genitori: è un Paese plurale e penso sia stata la presenza dei corpi delle persone migranti a suscitare degli interrogativi sul suo passato coloniale.
Il popolo somalo ha perso sia gli archivi privati (familiari) sia quelli pubblici, in altre parole ha perso parte rilevante della propria storia. Come sopravvive un popolo privato della sua storia?
IS Vorrei avere una risposta. Sono pochissimi gli archivi che si sono salvati, ad esempio quello dell’emittente Radio Mogadiscio, mentre paradossalmente molte tracce della memoria somala sono custodite negli archivi italiani: io ho ritrovato foto dei miei genitori in quello della Fiera di Milano. “Cassandra a Mogadiscio” è un tentativo di fare memoria attraverso l’oralità, recuperando le testimonianze di chi ha perso documenti e immagini del proprio passato. Ed è un’operazione quanto mai necessaria: parlando con diversi giovani rifugiati mi sono resa conto che non sanno nulla di quello che è successo in Somalia negli anni Settanta e Ottanta. Fortunatamente stanno uscendo molti libri in somalo che raccontano la storia del nostro Paese in quel periodo.
© riproduzione riservata