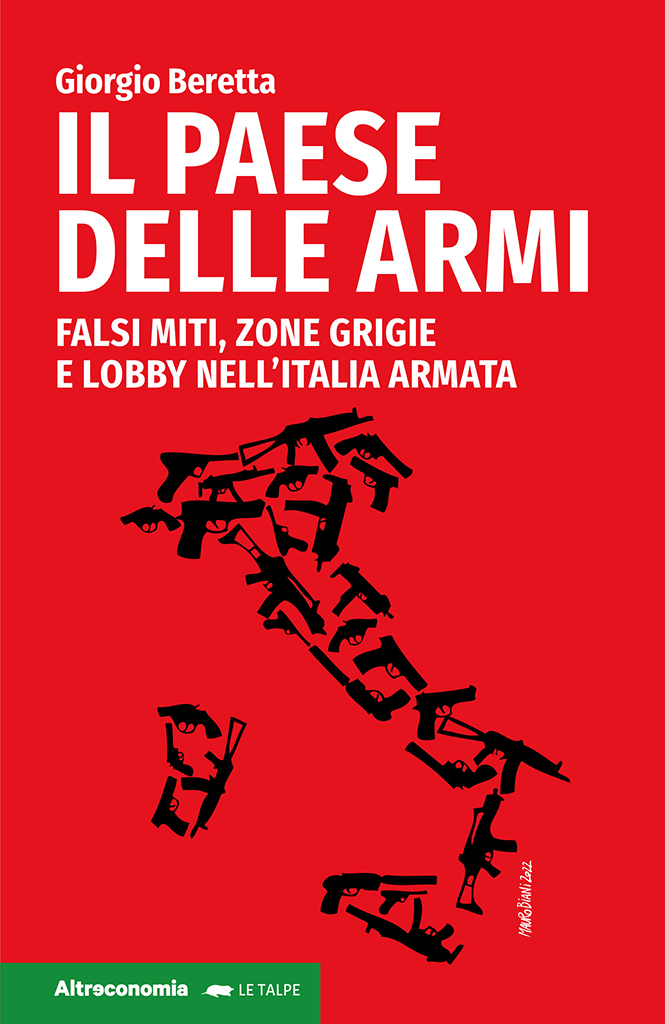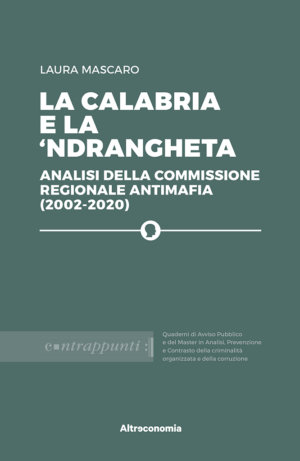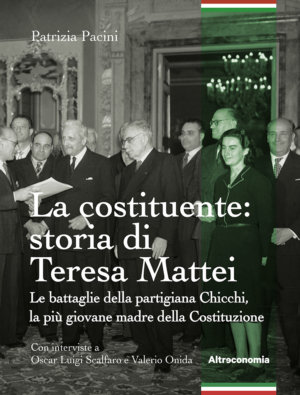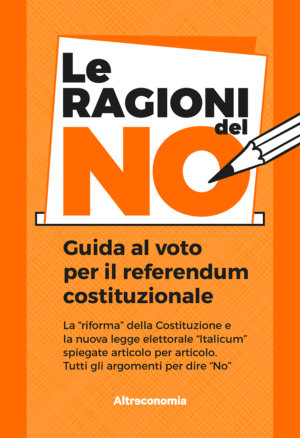Interni / Intervista
L’irrazionalità sistemica dei decreti flussi. Perché non è solo una questione criminale

Nemmeno un quarto delle persone straniere entrate in Italia per lavorare riesce a ottenere un contratto regolare e i documenti. Di fronte ai dati della campagna “Ero straniero” e al flop del meccanismo che regola l’ingresso di lavoratori e lavoratrici dall’estero, il Governo Meloni ha spostato il dibattito sulle prassi illecite. In realtà le falle sono a monte, come spiega l’avvocata e socia Asgi Nazzarena Zorzella
“Non si può escludere, in generale, che ci possa essere un interesse della criminalità, organizzata o meno, rispetto al meccanismo dei decreti flussi che regolano gli ingressi per lavoro dei cittadini stranieri in Italia ma tutto ciò è la conseguenza di un sistema normativo irrazionale e farraginoso. Come sempre la criminalità, piccola o grande, si organizza a seconda di dove c’è opportunità. Non dobbiamo dimenticarlo”.
Quello di Nazzarena Zorzella, avvocata che da trent’anni si occupa di diritto dell’immigrazione e dell’asilo e socia Asgi, è un punto di vista privilegiato per comprendere il dibattito esploso nelle ultime settimane in tema di quote e ingressi per lavoro nel nostro Paese.
Un salto indietro aiuta a fare ordine. A fine maggio la campagna “Ero straniero. L’umanità che fa bene” -promossa da A Buon Diritto, ActionAid, Asgi, Federazione Chiese Evangeliche Italiane (Fcei), Oxfam, Arci, Cnca, Cild, Fondazione Casa della carità Angelo Abriani con il sostegno di decine di organizzazioni- ha pubblicato il dossier “I veri numeri del decreto flussi: un sistema che continua a creare irregolarità”, facendo emergere il flop istituzionale. Parlano i numeri. Nel 2023 le domande pervenute dai datori di lavoro nei cosiddetti “click day” sono state infatti sei volte più numerose delle quote di ingressi stabilite: 462.422 istanze inviate a fronte di 82.705 posti disponibili. Non solo: nella fase di finalizzazione della procedura che prevede l’assunzione e il rilascio dei documenti, a fronte di 74.105 posti realmente disponibili (perché 8.600 sono conversioni di altri permessi), sono state appena 17.435 (cioè il 23,5%) le domande effettivamente portate a termine con la sottoscrizione del contratto e la richiesta di permesso di soggiorno per lavoro. Tradotto: è il sistema a generare irregolarità e ricattabilità, con una minima parte delle lavoratrici e dei lavoratori che entrano in Italia con il decreto flussi che riescono poi a stabilizzare la propria posizione lavorativa e giuridica, ottenendo lavoro e documenti, mentre la stragrande maggioranza scivola in condizioni di subalternità.
Ci sarebbe un modo per evitare questa situazione, uno strumento previsto proprio dal Testo unico immigrazione del 1998 riformato dalla “Bossi-Fini” nel 2002, ovvero il permesso di soggiorno per attesa occupazione che può essere rilasciato in caso di indisponibilità all’assunzione da parte del datore di lavoro. Peccato che, come ricostruito dai dati raccolti da “Ero straniero”, nel 2023 ne sono stati rilasciati la miseria di 84 (fino a gennaio 2024). Un numero del tutto insufficiente rispetto alle decine di migliaia di persone che avrebbero necessità di poter rimanere legalmente in Italia e cercare un nuovo lavoro.
Di fronte all’enormità di questi dati, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni il 4 giugno ha ipotizzato invece l’infiltrazione della criminalità organizzata nella gestione delle domande presentate. “Sono stati utilizzati come meccanismo per consentire l’accesso in Italia, per una via formalmente legale e priva di rischi, a persone che non ne avrebbero avuto diritto, verosimilmente dietro pagamento di somme di denaro”, ha dichiarato, tentando di spostare il dibattito -e riuscendoci a livello mainstream- su una stortura illecita e non invece su quella che, a detta dell’avvocata Zorzella, è una stortura di sistema. Le abbiamo chiesto di spiegarci dettagliatamente il perché.
Avvocata Zorzella quali sono i principali meccanismi del sistema d’ingresso per lavoro in Italia che causano irregolarità e contribuiscono a creare precarietà e ricorso al lavoro nero, con tutto ciò che tale condizione comporta a livello sociale ed economico per il nostro Paese?
NZ Il vizio originario è proprio il meccanismo legale del decreto flussi che continua a riproporre il sistema dell’incontro a distanza tra l’offerta e la domanda di lavoro. Ce lo trasciniamo ormai da decenni ed è pacifico, assodato e consolidato che è uno dei grandi produttori di irregolarità per le persone che entrano in Italia. Nel nostro Paese oggi è presente un sistema produttivo di piccole e medie aziende che hanno bisogno di conoscere le persone con cui lavorano, magari anche di mettere alla prova le loro competenze. Per cui è paradossale, anacronistico e irrazionale mantenere questo sistema di chiamata a distanza, fingendo di non conoscere il lavoratore che si intende chiamare. Che cosa succede quindi nella maggior parte dei casi, in un percorso sperimentato ormai da anni: le persone entrano in Italia, regolarmente con visto turistico o irregolarmente, trovano lavoro in nero e aspettano che esca la regolarizzazione o il decreto flussi. Se piacciono al datore di lavoro, sarà lui a partecipare alla “lotteria” dell’assegnazione di una quota attraverso i “click day”. Ci sono persone che aspettano anni prima che il datore di lavoro riesca ad ottenerne una perché vengono esaurite nel giro di pochi secondi dall’apertura della procedura per la richiesta. Questo sistema è l’opposto di quello che dovrebbe caratterizzare le catene migratorie tradizionali, basate sulle famiglie o i connazionali e dunque sulla conoscenza diretta che loro hanno dei datori di lavoro sul territorio e che consentirebbe di chiamare quel tal lavoratore o lavoratrice. Il sistema del decreto flussi, invece, ignora quel meccanismo e impone una chiamata fingendo di non conoscere il lavoratore o la lavoratrice ed è evidente che se non c’è stato un pregresso periodo di soggiorno in Italia prima della chiamata, l’alternativa è affidarsi a soggetti italiani o stranieri che reperiscono proposte di lavoro, anche se non è detto che tutte siano a fronte di pagamento di denaro.
Enfatizzare possibili segmenti di criminalità significa nascondere meccanismi che derivano proprio dalla legge. È proprio il meccanismo normativo che crea quindi irregolarità e che permette che si possano creare anche dei mercati economici paralleli per acquisire la possibilità di entrare in Italia, all’interno delle quali possono anche innestarsi delle vere e proprie truffe che sono soprattutto, se non esclusivamente, a danno dei lavoratori e delle lavoratrici che vorrebbero entrare in Italia per lavorare regolarmente. Un’altra causa, sempre conseguenza strutturale del decreto flussi, è la mancanza in Italia di un sistema legislativo di regolarizzazione ad personam, cioè la possibilità di acquisire il permesso di soggiorno che è il titolo che legittima la permanenza sul territorio nazionale, per chi arriva in Italia (anche con un visto regolare per turismo) e successivamente trova un’opportunità di lavoro. Il terzo fattore che spiega quello che sta succedendo e che svela anche la strumentalizzazione e la manipolazione della realtà da parte della politica, è l’assenza di canali di ingresso per ricerca di lavoro, che dovrebbero essere, a mio parere, il sistema principale di ingresso regolare. Questo era un meccanismo legale, previsto nel Testo unico sull’immigrazione quando è stato emanato nel 1998. Si trattava dell’articolo 23 che poi è stato riformato molte volte e che la prima grande riforma della legge nel 2002, la cosiddetta Bossi- Fini, ha abrogato perché definito troppo libertario in quanto lasciava la persona libera di autopromuoversi.
Da allora non è stato più ripristinato. Prevedeva infatti la possibilità, nell’ambito sempre delle quote del decreto flussi, di entrare dimostrando una minima capacità reddituale che era pari all’importo dell’assegno sociale annuo. Per cui una persona chiedeva il visto per ricerca di lavoro, arrivava in Italia e otteneva un permesso di soggiorno per ricerca occupazione, cercava lavoro, entro un anno se lo trovava – e l’hanno trovato tutti- veniva trasformato in un permesso per motivi di lavoro. È vero che anche nei quattro anni in cui è stata una norma di legge non è stato molto utilizzato, però era un sistema all’interno delle quote, cioè non si trattava di un “liberi tutti” e negli anni in cui è stato sperimentato ha avuto buoni esiti.
Ci sono poi diversi motivi per cui il nulla osta rilasciato al lavoratore e alla lavoratrice può essere revocato, ce li può spiegare?
NZ Il controllo della congruità delle domande dell’azienda, cioè il numero di dipendenti che ha rispetto alla sua capacità reddituale, prima era affidato all’Ispettorato del lavoro. Adesso invece viene fatto attraverso un’asseverazione da parte di consulenti del lavoro o di commercialisti o avvocati. Una volta che il lavoratore e la lavoratrice sono entrati in Italia, lo Stato o l’Ispettorato possono fare dei controlli sulla veridicità e sulla fondatezza di questa asseverazione ed eventualmente revocare il nulla osta. Oppure, dopo l’ingresso, potrebbe arrivare il nulla osta negativo della questura che deve verificare che il lavoratore o la lavoratrice che il datore di lavoro vuole chiamare non abbia un’espulsione dall’Italia o da un altro Paese dello spazio Schengen o dei precedenti penali per periodi pregressi in Italia. Un altro scenario che può verificarsi è che il datore di lavoro non sia più disponibile perché magari è passato troppo tempo, sono cambiate le condizioni del mercato o le sue condizioni reddituali o altro.
In questo caso non è previsto, quantomeno formalmente, il rilascio di un permesso di soggiorno per attesa occupazione e questo vuol dire che il lavoratore o la lavoratrice entrato con un visto per lavoro non può regolarizzare il proprio soggiorno sul territorio nazionale, anche se trova un’altra occasione di lavoro. Tutto ciò crea ovviamente ulteriore irregolarità e danno per il lavoratore e la lavoratrice che non avendo la possibilità di rimanere regolarmente sul territorio nazionale, si immetterà nel mercato del lavoro nero. Ci sono poi altre criticità, sempre genetiche dello stesso sistema del decreto flussi che questo governo ha complicato, nel senso che si va sempre più verso la selezione sia dei Paesi sia delle tipologie di lavori per i quali può essere richiesto il nulla osta e poi il visto. Questi ultimi coincidono con le carenze del mercato del lavoro italiano ma solo in parte. E questo succede perché non c’è più il documento programmatico, istituito dal Testo unico sull’immigrazione che doveva essere redatto di concerto dei vari ministeri ma anche delle associazioni sindacali, datoriali e delle associazioni del terzo settore. Il documento fotografava il mercato del lavoro e individuava anche le misure di integrazione sociale per i lavoratori e le lavoratrici. L’ultimo documento programmatico è del 2004-2006. Per cui attualmente la selezione delle tipologie di lavoro viene fatta dal ministero del Lavoro e dal ministero dell’Interno.
Che ruolo ha quindi la criminalità organizzata?
NZ È un po’ lo stesso meccanismo del traffico di esseri umani. Perché esiste il traffico di esseri umani? Perché non ci sono canali regolari di ingresso. Nessuno si metterebbe nelle mani dei trafficanti con il rischio di morire nel mar Mediterraneo o nella rotta balcanica se potesse acquistare un biglietto anche a mille e cinquecento euro. Se non dai nessuna alternativa non puoi dopo lamentarti che ci siano questi fenomeni la cui rilevanza è comunque tutta da accertare.
Proposte alternative come i corridoi lavorativi potrebbero essere una soluzione?
NZ Si sta configurando un ulteriore canale preferenziale che sono gli ingressi fuori quota che possono presentare elementi di criticità. Si potrebbe pensare: “meno male che gli ingressi non sono tutti ristretti all’interno delle quote” che sono del tutto inadeguate. La possibilità d’ingresso fuori quota è riservata alle associazioni datoriali che promuovono dei corsi di formazione nei Paesi di origine delle lavoratrici e dei lavoratori. Una volta completati, viene rilasciato il visto di ingresso. Insomma, c’è un collegamento molto stretto tra questi corsi di formazione e la possibilità di ingresso in Italia. Per il Testo unico sull’immigrazione, dalla Bossi-Fini del 2002, il datore di lavoro quando chiede il nulla osta deve garantire anche l’alloggio e le spese di rimpatrio. È vero che questo meccanismo in parte liberalizza, va oltre il sistema del decreto flussi. Dall’altra però la mia preoccupazione è che sia un meccanismo che lega indissolubilmente il lavoratore e la lavoratrice al proprio datore di lavoro. All’interno di questo meccanismo stanno iniziando i corridoi lavorativi, che sono nati sulla falsa riga dei corridoi umanitari (che già a mio avviso avevano delle grossissime criticità perché non avevano né hanno una effettiva base giuridica) basati su un’applicazione dell’art. 23 del Testo unico immigrazione. Corridoi lavorativi che presuppongono un periodo di formazione all’estero e poi l’ingresso in Italia per essere assunti da aziende individuate dall’Ente promotore del Protocollo.
Il primo corridoio lavorativo che è stato stipulato fino ad ora tra il ministero dell’Interno, degli Esteri e del Lavoro e la Comunità di Sant’Egidio, presenta tutti i criteri selettivi dei Paesi e dei lavoratori, nel senso che individua innanzitutto tre Paesi che sono Libano, Etiopia e Costa d’Avorio e per adesso riguarda circa 25 lavoratori da formare, per cui un numero abbastanza limitato. Però nell’arco del triennio di validità del protocollo potrebbero essere trecento, un numero ancora esiguo rispetto al fabbisogno del mercato del lavoro italiano che però comincia a essere significativo. L’assunzione di totale responsabilità in capo al datore di lavoro sia della formazione, sia dell’ingresso e dell’alloggio comporta secondo me un rischio: il fatto che stiamo prefigurando un meccanismo quasi di schiavitù moderna, che non è la classica schiavitù chiaramente, perché per legge dovranno rispettare il contratto collettivo nazionale. Però la domanda da farsi è: se tutta la vita lavorativa ma anche extra lavorativa, cioè l’alloggio, è a carico del datore di lavoro e nelle sue responsabilità, come fa il lavoratore e la lavoratrice a prendere conoscenza del tessuto sociale in cui viene immesso? Quali strumenti avrà per “liberarsi” dal legame con il datore di lavoro nel caso voglia cambiare lavoro? Immagino, e spero che sia un’immaginazione causata da eccessiva preoccupazione, residence vicini all’azienda per cui i lavoratori e le lavoratrici si muoveranno da questi all’azienda e viceversa, rimanendo fuori dal contesto della comunità territoriale con cui chi emigra entra in contatto, attraverso cui acquisisce anche la lingua, stabilisce relazioni, etc. E come faranno se vogliono dimettersi per esempio, se non conoscono il tessuto sociale? Chi li orienterà sul territorio a trovare altre opportunità di lavoro? È un meccanismo preoccupante.
Per quanto riguarda la competenza amministrativa: la materia dell’immigrazione è ancora affidata al ministro dell’interno e alle questure, lei cosa ne pensa?
NZ Dopo più di quarant’anni di realtà migratoria in Italia, affidare la materia ancora al ministero dell’Interno, come era nel regio decreto del 1931 cioè il Testo unico di pubblica sicurezza, non è solo anacronistico ma è irrazionale. Da tempo noi associazioni chiediamo che le competenze passino agli enti locali, ai soggetti che giuridicamente hanno competenza per le persone che abitano in quella comunità territoriale. Questo non vuol dire sopprimere i controlli di sicurezza, che è l’aspetto che più preoccupa nel senso che le questure potrebbero comunque continuare a fare i loro controlli di pubblica sicurezza, trasmettendoli poi all’ente locale. A questa criticità di base si aggiunge poi l’inadeguatezza organizzativa delle questure che, anche per mancanza di personale, oltre che spesso e volentieri per interpretazioni restrittive dei testi di legge, determinano delle lungaggini procedurali e procedimentali assurde. Per legge il permesso di soggiorno dovrebbe essere rilasciato entro sessanta giorni, ma capita che una persona arrivi ad aspettare un anno o anche di più e sia in possesso a lungo della sola ricevuta di permesso, con il rischio dio perdere il lavoro e di non potere esercitare i diritti sociali connessi al possesso di un permesso vero e proprio.
© riproduzione riservata