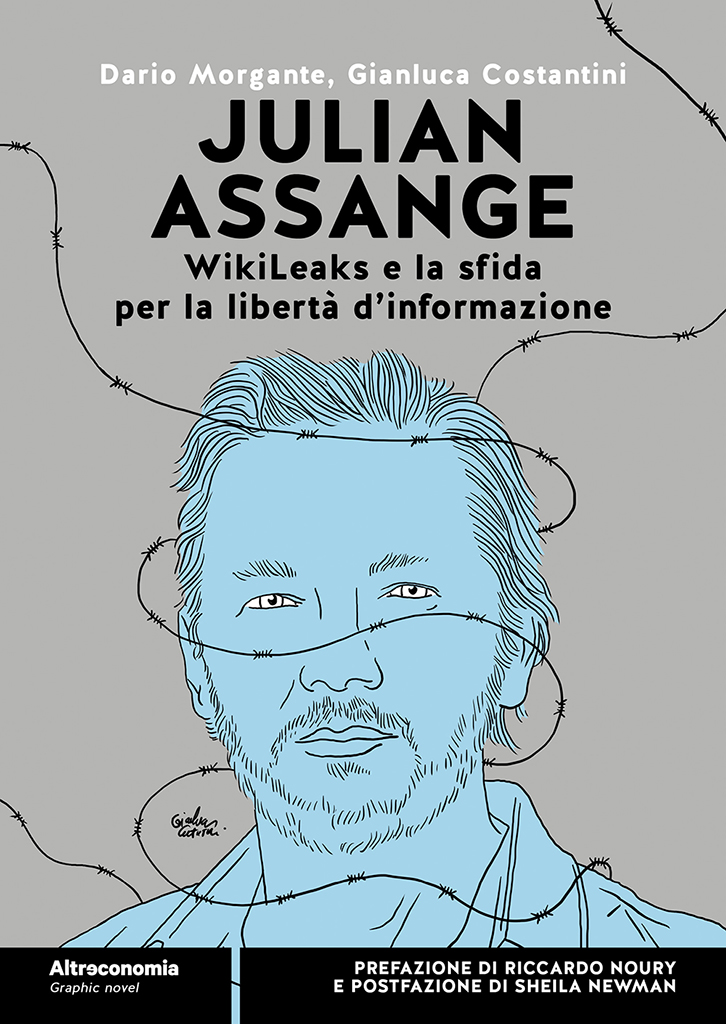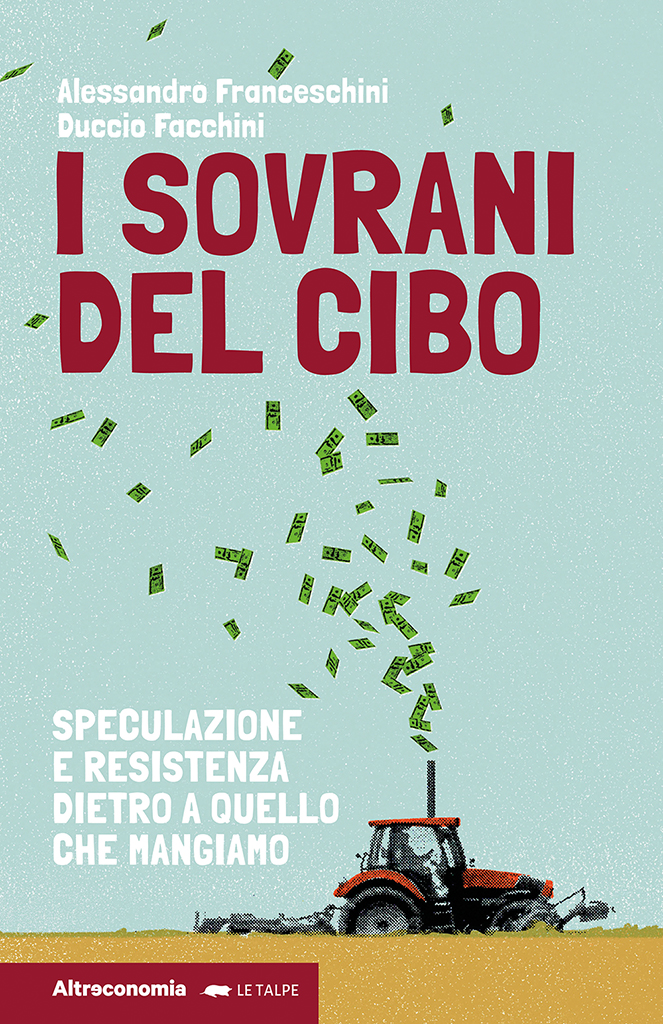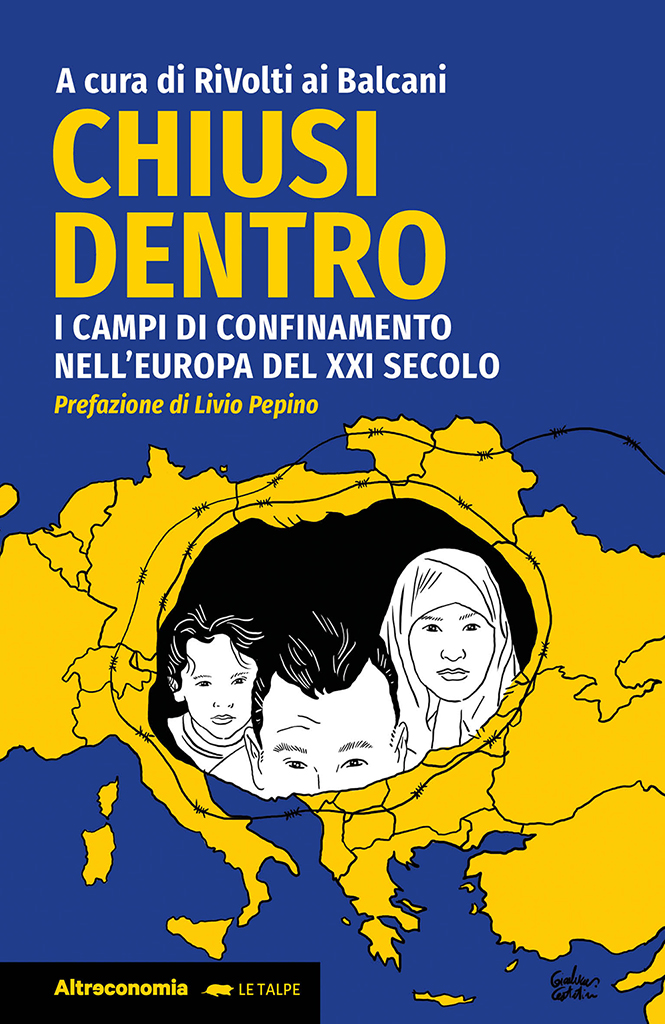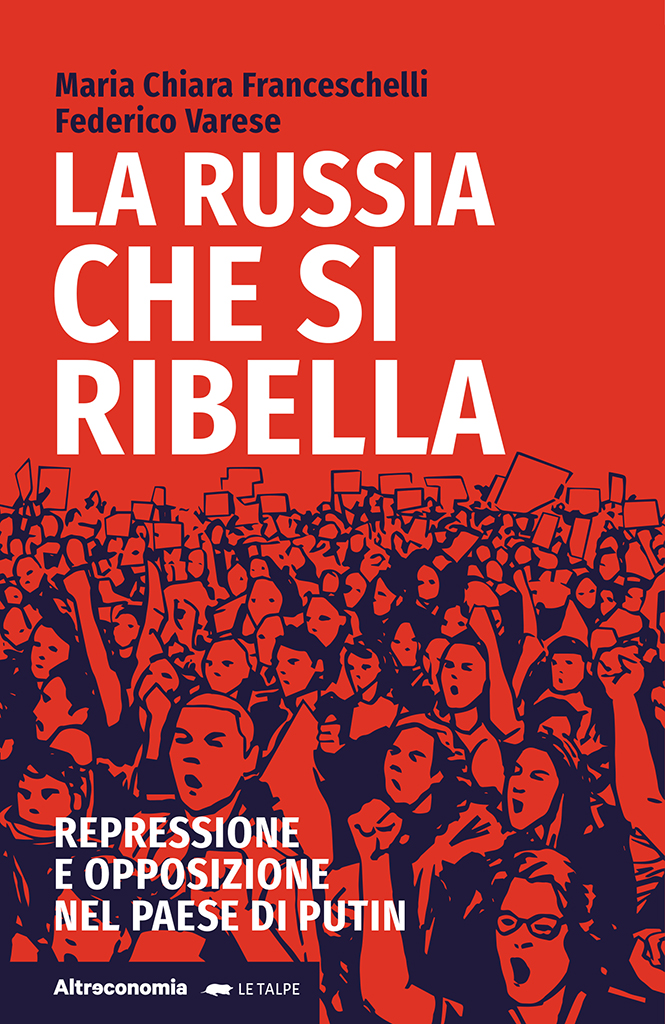Diritti / Attualità
Tra caporalato e sfruttamento, il lavoro delle donne nelle campagne della Tunisia

L’Ong italiana Cospe ha indagato le condizioni delle lavoratrici agricole nel Paese: sono pagate meno rispetto agli uomini e spesso vengono reclutate da intermediari. Irregolarità e incidenti sul lavoro sono frequenti ma sono costrette ad accettare queste condizioni per mantenere la propria famiglia
Nella Tunisia rurale una donna che lavora nei campi viene pagata poco più di tre euro al giorno, il 30-40% in meno rispetto a quanto riceverebbe un uomo per svolgere le stesse mansioni. Non solo: per ottenere quell’impiego spesso deve affidarsi a un intermediario che trattiene per sé una parte di quel magro salario. A questo si aggiungono lunghi orari, scarsa sicurezza, persino minacce e violenze. “Alcune delle lavoratrici con cui abbiamo parlato sono consapevoli che essere pagate tre euro per una giornata di lavoro non è giusto, ma sono costrette ad accettare perché hanno bisogno di quei soldi per sfamare i propri figli”, racconta Amina Ben Fadhl, coordinatrice del progetto “Femmes travailleuses dans l’agriculture: inclusion, réseautage, emancipation”(Faire) della Ong italiana Cospe che ha indagato la complessità del lavoro agricolo femminile in cinque regioni del Paese (Jendouba nel Nord, i governatorati di Sidi Bouzid e Kasserine nel centro, Mahdia nell’Est e Sfax nel Sud) intervistando 91 donne di età compresa tra i 31 e i 50 anni impegnate nei campi o nella pesca artigianale.
Se da un lato è difficile avere numeri certi su quante siano le donne impegnate in agricoltura, quello che è certo è che in molte regioni della Tunisia il settore primario rappresenta l’unico ambito in cui è possibile trovare un impiego anche se spesso precario o stagionale. “Inoltre garantisce flessibilità per continuare a gestire il carico domestico e la cura dei figli, permette anche di non allontanarsi troppo dal proprio luogo di residenza -spiega Ben Fadhl-. Abbiamo poi notato una nuova tendenza: il Covid-19 ha fatto aumentare la disoccupazione maschile, di conseguenza molte donne che in precedenza non erano lavoratrici agricole hanno iniziato a svolgere queste mansioni per mantenere la propria famiglia. Sempre a causa della pandemia abbiamo incontrato anche giovani donne diplomate o laureate che non trovando lavoro nelle città hanno fatto ritorno nei villaggi d’origine”.
Più del 50% delle intervistate ha dichiarato di lavorare sei giorni a settimana e il 27,5% sette giorni su sette, senza che sia previsto nessun riposo. Con una media giornaliera di nove ore e mezza se si calcola anche il tempo necessario agli spostamenti. Il salario medio: 3,50 euro al giorno, inferiore rispetto a quello previsto dal contratto nazionale. Il 55% dichiara di aver accesso al lavoro attraverso un intermediario di sesso maschile, che talvolta è un familiare o un conoscente. Figure il cui ruolo cambia in base alle diverse regioni, al tipo di coltivazioni e che sono presenti soprattutto quando il modello agricolo prevalente è caratterizzato da grandi estensioni di terreno e da una gestione di tipo imprenditoriale, in particolare nei governatorati di Sidi Bouzid e Kasserine: “In questi casi il proprietario dei campi o chi li gestisce si rivolge a questi intermediari, il cui ruolo è molto simile a quello dei caporali in Italia, chiedendo di reclutare decine di braccianti, per un determinato numero di giorni per svolgere un lavoro preciso: dalla raccolta delle patate a quella della frutta -spiega Ben Fadhl-. In questi contesti che sono molto diversi dall’agricoltura di tipo familiare, le donne non riescono a entrare in contatto diretto con i produttori e non hanno modo di aggirare la figura dell’intermediario che, tra le altre cose, si occupa anche del trasporto”.
Raggiungere i campi in tempo per iniziare la giornata di lavoro rappresenta uno dei molti problemi che le lavoratrici agricole devono affrontare: soprattutto quando bisogna percorrere grandi distanze. Solo 14% del campione intervistato si reca al lavoro a piedi, il 9% usa i mezzi pubblici e il 10% altri mezzi di trasporto ma la netta maggioranza (il 66%) deve far ricorso all’intermediario, che non solo si fa pagare di più ma ha un modo ulteriore per consolidare la propria capacità di controllo sulle donne.
In questo contesto l’illegalità è la norma: delle 72 lavoratrici agricole del campione intervistato da Cospe, ben 69 hanno riferito di aver lavorato illegalmente e senza alcun diritto riconosciuto mentre solo tre hanno dichiarato di essere state assunte con un regolare contratto. Altrettanto carenti sono i dispositivi di protezione personale che non vengono forniti neppure quando le lavoratrici sono esposte a pesticidi. “Alcune delle donne con cui abbiamo parlato ci hanno raccontato di utilizzare dei vecchi contenitori di sostanze chimiche per raccogliere e conservare l’acqua da bere durante la giornata”, racconta Ben Fadhl.

Non stupisce quindi che il 71% delle intervistate abbia raccontato di aver subito incidenti sul posto di lavoro o mentre viaggiava a bordo di pulmini o altri mezzi di trasporto inadatti. La carenza di strumenti e misure di protezione è tale che non ci sono neppure kit di primo soccorso e quindi in caso di incidente le donne vengono semplicemente inviate al più vicino centro sanitario di base o continuano a lavorare fino al loro ritorno a casa. “Non avendo un contratto non hanno accesso nemmeno alla previdenza sociale che permetterebbe loro di essere tutelate in caso di infortunio, non hanno i contributi pensionistici -sottolinea la referente del progetto di Cospe-. Ci sono degli ispettori che vigilano sul rispetto delle normative sul lavoro, ma sono troppo pochi e hanno un budget insufficiente per monitorare con regolarità le grandi aree rurali della Tunisia”. Alla fatica e allo sfruttamento si aggiungono talvolta anche violenze verbali e fisiche: il 60% del campione intervistato afferma di esserne stata vittima nei luoghi di lavoro o sui mezzi di trasporto.
“Sono donne che vivono in località isolate, lontane dal centro della città, e non hanno accesso ai servizi dello Stato: ciò le rende più fragili. Devono fronteggiare molti ostacoli, lavorativi, sociale ed economici. Ma al tempo stesso sono donne forti, che resistono e che cercano non solo di lottare per garantire ai figli un futuro migliore, ma anche di creare sinergie e reti per riprendersi i propri diritti”, sottolinea Amina Ben Fadhl. Attraverso i progetti “Faire” e “Gender empowerment, misure di protezione e messa in rete delle lavoratrici agricole” (“Gemma”) Cospe lavora per il riconoscimento dei diritti socio-economici delle donne contadine attraverso lo smantellamento di un complesso sistema di potere in cui si intrecciano mentalità tradizionali, relazioni di genere e pratiche illegali.
Dopo una prima fase dedicata all’ascolto delle istanze e dei bisogni delle lavoratrici agricole tunisine, Cospe ha iniziato a lavorare sia per sensibilizzare le amministrazioni, sia per sostenere le donne in questo percorso di empowerment offrendo loro formazione e coinvolgendole negli incontri pubblici, in modo che possano esprimere le proprie istanze. “Vogliamo fare in modo che siano esse stesse a far sentire la propria voce, cerchiamo di guidarle e camminare al loro fianco per far crescere la consapevolezza che agire collettivamente è il solo modo per generare un cambiamento -sottolinea Ben Fadhl-. Infine finanziamo iniziative che permettono a queste donne di rendersi maggiormente autonome da un punto di vista economico: penso ad esempio alle attività di trasformazione dei prodotti alimentari o a quelle donne che, avendo la proprietà di un piccolo appezzamento di terra, si sono riunite per dare vita a una propria attività agricola”.
© riproduzione riservata