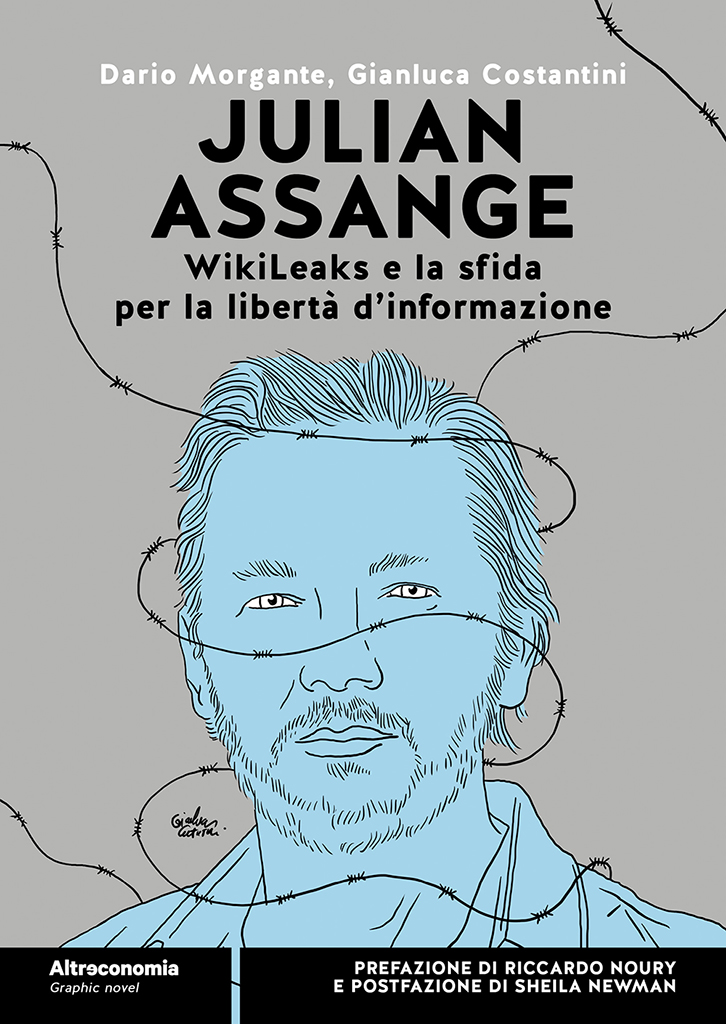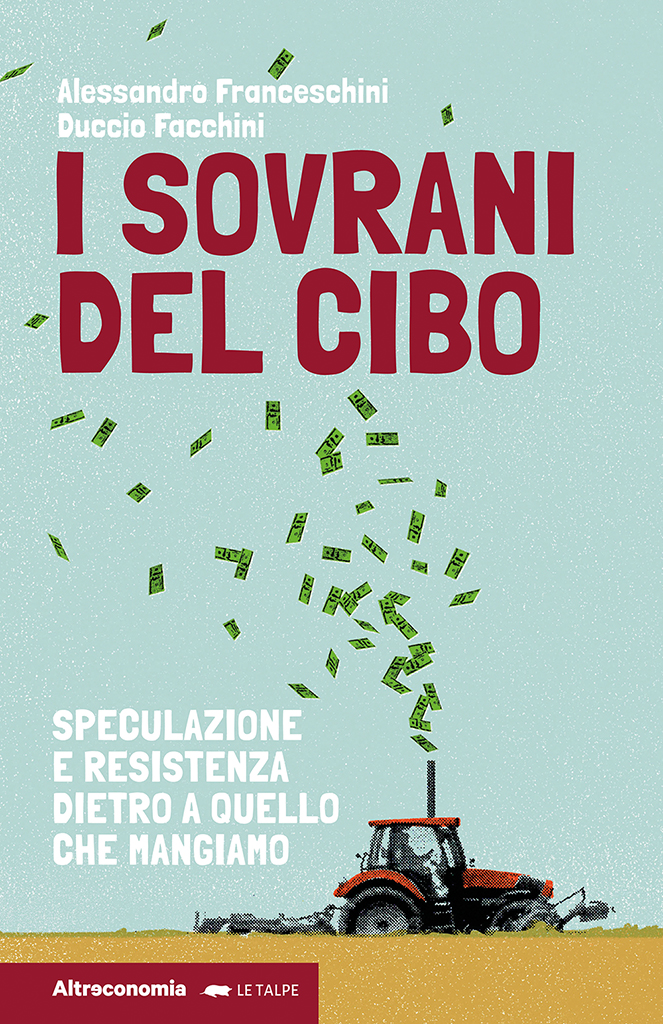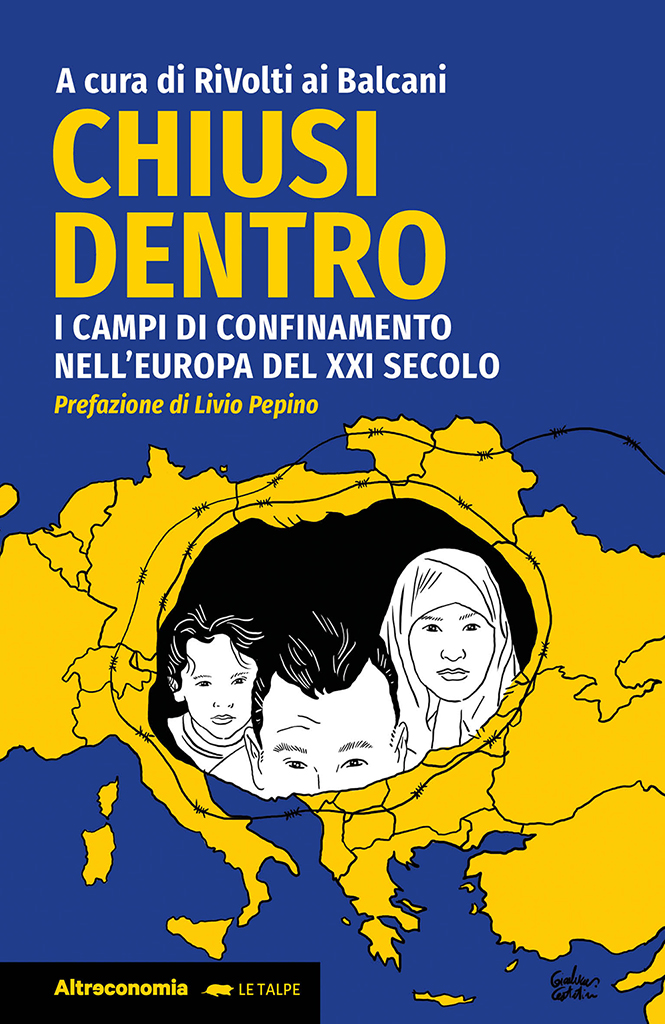Diritti / Intervista
Michela Giachetta. All’origine della violenza di genere

Nel libro “I mostri non esistono” la giornalista racconta il suo viaggio nei Centri per uomini autori di violenza (Cuav). Per capire il lavoro incessante di chi aiuta i “maltrattanti” a riconoscere le proprie responsabilità. E prevenire i femminicidi
Michela Giachetta ha deciso di indagare come funzionano i Centri per uomini autori di violenza (Cuav) dopo il femminicidio di Giulia Tramontano, uccisa dal suo compagno Alessandro Impagnatiello. Era il 27 maggio 2023, Tramontano aveva 27 anni ed era incinta di sette mesi. “Ci sono delle storie che ti colpiscono in maniera particolare, per tanti motivi anche personali -racconta la giornalista-. Ed è quello che è successo a me con questa donna che aveva un’età a metà fra me e mia figlia e abitava a Senago (MI), non molto distante da dove vivo io. Questa proiezione è stata per me un cortocircuito emotivo fortissimo. Mi sono chiesta come si può fermare questa violenza?”.
L’ultima ricerca sui Cuav risale al 2022 ed è stata realizzata dal progetto Viva dell’Istituto di ricerche sulla popolazione e le politiche sociali del Consiglio nazionale delle ricerche (Cnr) e del dipartimento per le Pari opportunità. I risultati dicono che sono 94 e utilizzano metodi differenti -psicoterapeutico, psico-socioeducativo, criminologico- ma hanno obiettivi comuni: fermare la violenza per proteggere le vittime, le donne e i bambini, e far acquisire consapevolezza agli uomini dei loro comportamenti. Chi ci entra, nella maggior parte dei casi, non lo fa volontariamente ma su consiglio degli avvocati o per l’invio da parte dell’autorità giudiziaria.
Giachetta ha deciso di dedicargli un anno di lavoro. Di fare un viaggio dentro queste realtà incontrando gli operatori, partecipando agli incontri di gruppo, entrando in carcere. Il tutto è confluito nel libro “I mostri non esistono” (Fandango, 2024), un lungo reportage in prima persona in cui Giachetta cerca di rispondere ad alcune delle domande inevitabili di fronte a 110 femminicidi nel 2024 (dati dell’Osservatorio di Non una di meno, aggiornati all’8 dicembre) che nel 47,3% dei casi sono commessi da mariti, partner o ex fidanzati.
Giachetta, perché ha deciso di occuparsi dei Cuav?
MG Il lavoro che fanno i Centri antiviolenza (Cav) oggi è noto ed è prezioso e fondamentale. Ma chi si occupa degli uomini che sono i responsabili della violenza? Quando si parla di contrasto alla violenza ci sono due livelli: il primo è la prevenzione, il secondo è fermare gli uomini che l’hanno già commessa, perché il femminicidio è l’ultimo atto, è l’epilogo più tragico ma prima ci sono stati maltrattamenti, soprusi e minacce. Io volevo capire che cosa si stesse facendo in quest’ultimo ambito e sono arrivata ai Cuav. Ne avevo sentito parlare in maniera molto sommaria, avevo letto qualche articolo, ma di fatto ne sapevo poco e nulla. E poiché non esiste un elenco ufficiale di quelli accreditati ho dovuto fare una ricerca per capire dove sono e come arrivarci.

Perché, secondo lei, fino ad ora si è parlato così poco dei Cuav?
MG Perché andare all’origine della violenza è complesso come anche guardarla in faccia e confrontarsi con persone che l’hanno già commessa. Un altro motivo è perché i Cuav sono molto recenti. Il primo, quello di Firenze, è stato aperto nel 2009, mentre il primo Centro pubblico, quello di Modena, nel 2011. Quindi hanno anche meno storia rispetto ad altri Paesi, mi riferisco ad esempio al modello norvegese adottato proprio dalla struttura emiliana. Gli operatori sono andati a fare formazione lì e questo è un aspetto molto importante perché il lavoro con i maltrattanti non si può improvvisare.
Soprattutto nei casi di violenza domestica, ci sono radici culturali molto profonde di stampo patriarcale da sradicare. Infine anche a causa del fatto che, per retaggi culturali, si tende ancora a parlare della donna non solo in quanto vittima, ma anche come se fosse una sua responsabilità proteggersi dalla violenza: è lei che non deve uscire la sera, è lei che deve vestirsi in un certo modo, è lei che deve evitare il “lupo”. Il focus è ancora spostato sulla donna, distogliendo l’attenzione da chi commette la violenza.

Un aspetto che colpisce molto nel suo libro è l’atteggiamento di vittimismo degli uomini, può dirci di più?
MG Me ne hanno parlato quasi tutti gli operatori che ho incontrato, da Palermo a Milano, passando per Torino, Trento e Genova. Gli uomini che arrivano nei Cuav sono diversi fra loro, alcuni giovanissimi, altri avanti con l’età, professionisti oppure disoccupati, manager, ma hanno tutti in comune questo aspetto, all’inizio del percorso: si sentono loro le vittime, della donna che li ha denunciati, del giudice che li ha condannati, di tutto il sistema, dei centri antiviolenza che chissà cosa mettono in testa alle donne.
L’altro filo che molto spesso li lega è quello della minimizzazione, o addirittura negazione, di quello che hanno commesso. Da un lato è sempre la donna che li ha provocati, quindi è sempre colpa sua, loro non volevano, dall’altro era solo una spinta, quando magari la compagna si è presentata al pronto soccorso piena di lividi. Riconoscere la violenza e il fatto di esserne i responsabili è un passaggio che arriva, quando accade, solo dopo, se non al termine di questo percorso. Nel centro di Modena una delle ultime fasi è proprio quella di riconoscerne l’impatto, assumersene la responsabilità e vedere le conseguenze del proprio comportamento.
“Riconoscere la violenza e il fatto di esserne i responsabili è un passaggio che arriva, quando accade, solo dopo, se non al termine di questo percorso”
Quale idea si è fatta sul cambiamento degli uomini maltrattatanti, è veramente possibile?
MG Questa domanda è quella che ho portato in tutti i centri che ho visitato, in quanto donna era la questione più urgente. Mi ha aiutato molto un dialogo che ho ascoltato durante un gruppo psicoeducativo nel Centro di Firenze. Uno degli operatori parlava di cambiamento e un uomo è intervenuto dicendo: “No, questo non è un cambiamento, questa è un’evoluzione. Lo abbiamo fatto, siamo anche quella roba, abbiamo toccato il fondo, dobbiamo evolverci”.
Ho parlato di cambiamento anche con Alessandra Pauncz, la presidente di questo Centro che è l’unico che ha pubblicato sul suo sito l’impact report con i risultati raggiunti. E lei mi ha fatto un discorso su quanto sia difficile il cambiamento profondo, soprattutto quando si è adulti. Però in moltissimi casi, dopo questi percorsi, la violenza fisica cessa. Questi centri fungono da “contenitori”, danno agli uomini gli strumenti per riconoscere la violenza prima che esploda, anche aiutandoli a capire i segnali del corpo che la innescano. Per quanto riguarda la violenza psicologica il discorso è più complicato anche perché è più difficile riconoscerla, quindi monitorarla e misurarla. Però nonostante le criticità io credo fortemente in questo tipo di lavoro, senza questi uomini sarebbero abbandonati a loro stessi.
“I centri fungono da ‘contenitori’, danno agli uomini gli strumenti per riconoscere la violenza prima che esploda, anche aiutandoli a capire i segnali che la innescano”
Perché i mostri non esistono?
MG Gli uomini autori di violenza non sono altro da noi. Questi uomini non fanno parte di una società parallela. Se li consideriamo mostri, alieni, da un lato li deresponsabilizziamo, dall’altro riduciamo la possibilità per gli altri di riconoscere la violenza, che è uno degli aspetti più importanti che è emerso dal mio lavoro. La violenza è un tema che ci riguarda e ci deve coinvolgere, a cui dobbiamo dare spazio nei giornali e nelle scuole e di cui non dobbiamo smettere di parlare.
Nel libro sono presenti informazioni pratiche per contattare o raggiungere i Centri per uomini autori di violenza come numeri di telefono, indirizzi e mail
© riproduzione riservata