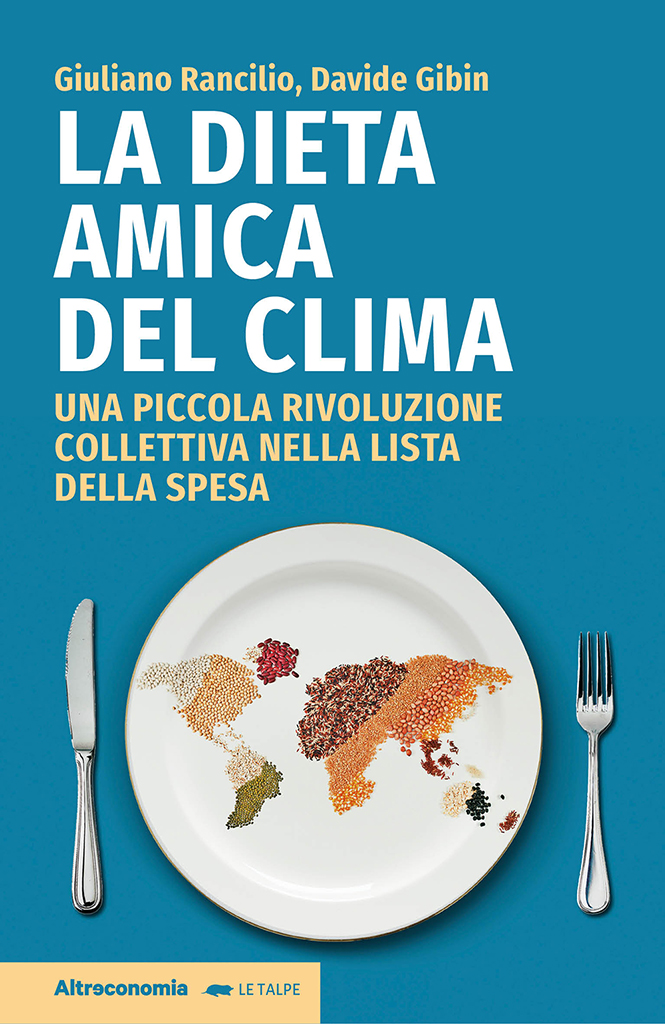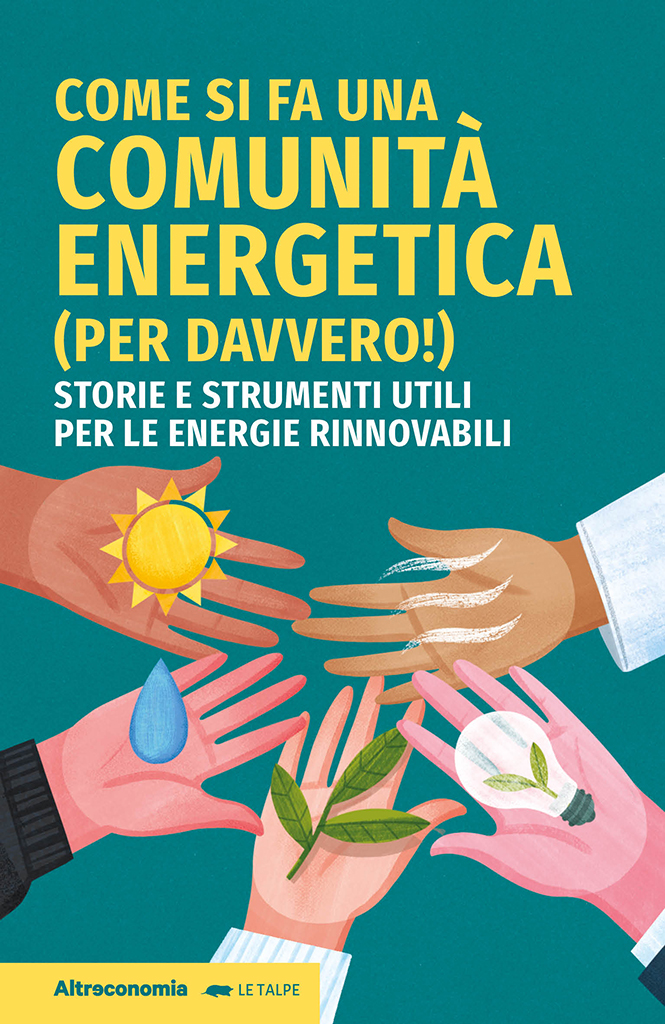Crisi climatica / Intervista
“Il capitalismo verde è un inganno: il mercato ignora le diseguaglianze”

Nel suo ultimo saggio “Quanto vale una balena”, la ricercatrice Adrienne Buller analizza i limiti delle strategie di decarbonizzazione affidate al libero mercato. I risultati che producono lasciano intatti sistemi di potere e le ingiustizie
La più grave minaccia alla transizione ecologica non è il negazionismo climatico ma l’inseguimento di false soluzioni promosse dal “capitalismo verde”. Dal mercato dei crediti di carbonio alle compensazioni per le emissioni di CO2 queste strategie stanno mostrando sempre più i limiti di una decarbonizzazione che lascia intatti i sistemi di potere e le diseguaglianze del sistema economico. E come la “mano invisibile” del mercato non possa frenare da sola l’aumento delle temperature globali. È quanto spiega Adrienne Buller, ricercatrice presso il think tank inglese Common wealth nel suo libro “Quanto vale una balena”, pubblicato in Italia da add editore.
Buller, iniziamo dal titolo. Che cosa significa mettere un prezzo a una balena?
AB Viene da uno studio del 2019 del Fondo monetario internazionale (Imf) il cui obiettivo era quello di stabilire il “valore economico” di una balena. La cifra stimata è stata di due milioni di dollari sulla base di elementi come l’ecoturismo e il ruolo di questi mammiferi nel sequestro del carbonio. Lo studio era animato da buone intenzioni: esprimerne il loro valore per incoraggiarne la conservazione. Ma questo mostra uno dei problemi del modo in cui il capitalismo affronta la crisi climatica: tutto deve essere mediato attraverso il mercato e qualcosa può avere valore solo se ha un prezzo, anche la vita di una balena.
In che cosa consiste il capitalismo verde? Quali sono le sue finalità?
AB A livello ideologico, si basa sull’idea che possiamo affrontare la crisi climatica, trasformando e decarbonizzando completamente l’economia globale, senza dover risolvere nessuna delle relazioni sociali e delle disuguaglianze che definiscono il capitalismo. Suppongo che sia questo il suo scopo: mantenere il più possibile i sistemi esistenti, trasformando al contempo enormi fasce dell’economia. Più concretamente, si tratta di una risposta basata quasi esclusivamente sui meccanismi di mercato, che si tratti dei prezzi del carbonio o di politiche in materia di responsabilità aziendale (i cosiddetti criteri Esg, ndr) piuttosto che su investimenti e interventi pubblici più diretti. Il modo più semplice di vederla è l’idea che se riusciamo a fissare i giusti prezzi, il mercato farà il resto.
Negli ultimi dieci anni, i fondi hedge (come BlackRock, Vanguard e State Street) hanno acquisito sempre più potere. In che modo la loro crescita influenza l’azione, o l’inazione, per il clima?
AB Il rapporto tra queste realtà e il clima è complesso. Da un lato, la loro attività è esposta ai suoi rischi, perché investono su scala globale. Allo stesso tempo, possono guadagnare o perdere moltissimo in base a come viene affrontata la crisi climatica. Non deve sorprendere che siano favorevoli ai meccanismi di mercato e a molte nuove opportunità di investimento (idealmente sostenute dallo Stato) per il settore privato, caratteristiche del capitalismo verde.
Larry Fink, l’amministratore delegato di BlackRock, ha descritto la decarbonizzazione come “la più grande opportunità di investimento della nostra vita”. Le dimensioni di questi fondi si traducono in un alto livello di influenza attraverso le loro decisioni di investimento e il modo in cui esercitano il loro potere come proprietari di grandi aziende, ma sempre più spesso, attraverso l’influenza politica diretta.
BlackRock è molto attiva su questo fronte, svolge attività di lobby in modo molto efficace ed è considerata un’autorità: ecco perché, ad esempio, è stata invitata a fornire consulenza sulle normative europee in materia di finanza sostenibile o perché diversi suoi “ex allievi” hanno ricoperto ruoli molto influenti nell’amministrazione statunitense del presidente Joe Biden in materia di clima e politica economica.
Lei sostiene che i limiti al riscaldamento globale contenuti negli accordi sul clima, come gli 1,5 gradi dell’Accordo di Parigi, derivano da valutazioni economiche. In che modo?
AB L’origine della soglia dei due gradi è attribuita all’economista William Nordhaus e compare per la prima volta in un documento del 1975 in cui fa un “esperimento mentale” sul giusto compromesso tra l’aumento della temperatura e la crescita economica. Parte dal presupposto che, se da un lato l’aumento della temperatura sarebbe dannoso per la crescita, anche l’azione di riduzione delle emissioni lo sarebbe stata.
Il suo lavoro ha avuto un’enorme influenza: Nordhaus ha vinto il premio Nobel per l’economia per il suo “Dynamic integrated climate-economy model” (“Dice”) che esamina le interazioni tra cambiamenti climatici e impatti economici. Si tratta di uno dei numerosi “modelli di valutazione integrata” utilizzati per la politica climatica: molti, però, fanno astrazioni enormi. “Dice”, ad esempio, afferma che l’aumento “ideale” della temperatura media globale sarebbe compreso tra 3,5 e quattro gradi centigradi. Uno scenario che la scienza considera disastroso e che aumenta in modo significativo i rischi di raggiungere diversi punti di svolta ambientali chiave.
Ci sono molte ragioni per criticare la modellizzazione di Nordhaus da un punto di vista scientifico, ma la questione è molto più ampia. Valutare la relazione tra clima e il Prodotto interno lordo (Pil) è una pratica comune, ma ritengo assurda l’idea che la variazione media globale del Pil ci dica qualcosa di utile su come dovremmo intervenire sulla crisi climatica: è un dato troppo grossolano e riflette una priorità sbagliata. Inoltre, così facendo, si perpetua l’idea che l’azione climatica sia intrinsecamente un compromesso con un’economia fiorente, il che non è affatto necessario. La maggior parte della popolazione mondiale ha molto da guadagnare dalla giustizia climatica: energia più sicura e accessibile, aria pulita, comunità più verdi e un’economia che dia priorità ai bisogni di tutti piuttosto che all’arricchimento massiccio di una minoranza a spese del Pianeta.
Il valore economico di un esemplare di balena adulta è stato stimato in due milioni di dollari dal Fondo monetario internazionale sulla base di elementi come l’ecoturismo e il ruolo di questi mammiferi nel sequestro del carbonio. L’intera popolazione globale varrebbe circa mille miliardi di dollari
Per limitare i danni del cambiamento climatico, c’è chi propone di accontentarsi di queste soluzioni perché sono “meglio di niente”. È d’accordo? Oppure esiste un’alternativa?
AB Chi lavora o è anche solo preoccupato per la crisi climatica cerca disperatamente qualsiasi cosa possa incidere. In alcuni casi, gli interventi del capitalismo verde possono avere un impatto. La riduzione del rischio e la sovvenzione da parte dello Stato negli investimenti in energia verde e nei trasporti decarbonizzati -interventi previsti dall’Inflation reduction act statunitense- stanno stimolando gli investimenti del settore privato. Ma il fatto che questi strumenti abbiano un impatto, non significa che sia l’approccio migliore o che siano in grado di garantire la decarbonizzazione al ritmo necessario. Né che tengano conto delle questioni di giustizia su scala nazionale e globale.
Vale anche la pena di ricordare che la maggior parte di questi meccanismi di “mercato” si basa su un significativo sostegno pubblico, sia attraverso sovvenzioni dirette e de-risking, sia attraverso regolamenti per creare nuovi mercati. Questo è certamente vero per l’energia green, uno dei casi che viene tipicamente indicato come prova del “successo” del capitalismo verde. Ma la vicenda è molto più complessa e per chi fosse interessato ad approfondirla, consiglio il libro “The price is wrong” di Brett Christophers, professore all’Università di Uppsala. Se alcune politiche che si adattano al quadro del capitalismo verde potrebbero essere utili alla transizione, molte invece sono una “distrazione” e nel peggiore dei casi persino dannose.
Inoltre, affinché il mercato risolva qualcosa, non solo deve stabilire un prezzo, ma questo deve anche essere redditizio per un soggetto privato.
Al di là delle sovvenzioni massicce -e in questo caso varrebbe la pena chiedersi perché gli Stati non investono direttamente- molti degli interventi di cui abbiamo bisogno per costruire un futuro realmente sostenibile sono semplicemente meno redditizie delle alternative.
Questo vale non solo per la nostra totale incapacità di ridurre i combustibili fossili, ma anche per distinzioni più sottili. Prendiamo ad esempio l’alternativa tra un futuro in cui tutti guidano un veicolo elettrico e uno basato su un sistema di trasporti pubblici decarbonizzati. Solo il secondo è veramente sostenibile, ma non è quello più redditizio. Inoltre, anche il primo scenario può ridurre le emissioni di carbonio, ma rischia di avere ricadute negative, sull’ambiente e sui diritti umani, attraverso l’estrazione intensiva di litio necessario alle batterie elettriche.
Per me questo è un limite fondamentale del capitalismo verde: il mercato non si preoccupa delle ingiustizie e delle disuguaglianze, soprattutto a livello globale. La crisi climatica ed ecologica è fondamentalmente legata alle enormi disuguaglianze sia all’interno dei singoli Paesi sia tra uno Stato e l’altro. Senza occuparsi di queste, non vedo alcun percorso verso un futuro realmente sostenibile, sicuro e giusto.
© riproduzione riservata