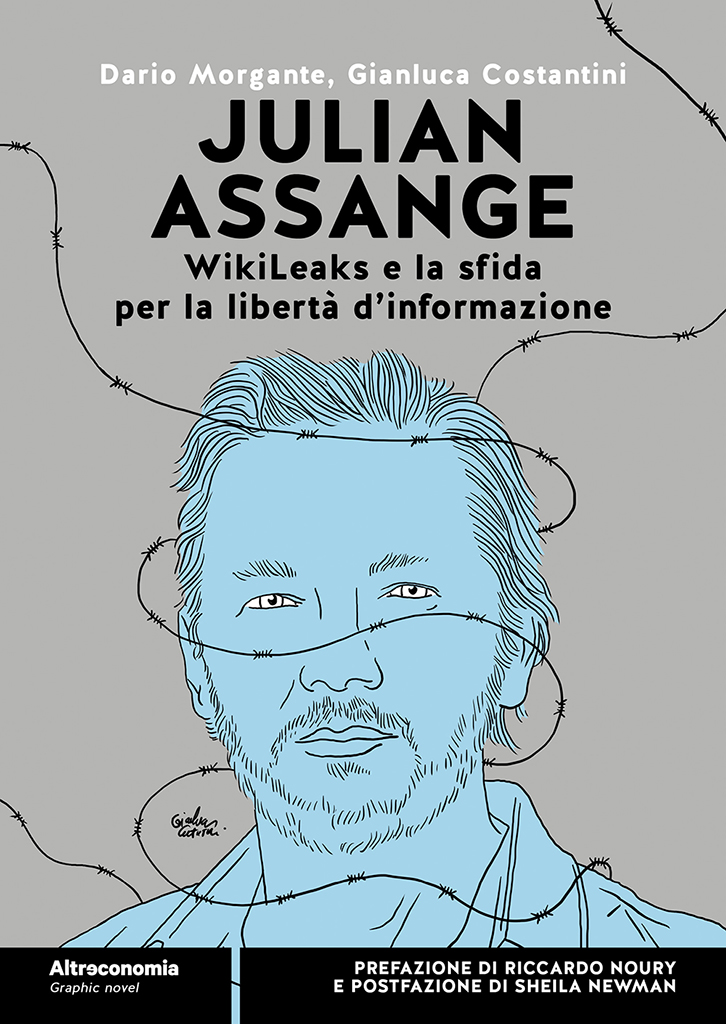Diritti / Approfondimento
Storia di un giovane sarto ivoriano e del suo viaggio-odissea fino a Prato

La ricercatrice esperta di moda Audrey Millet ha dato voce alla testimonianza di Abdoul, partito da Abidjan per comprarsi una macchina da cucire. Un’inchiesta sull’inferno dei migranti e sullo sfruttamento nel comparto tessile toscano
Abdoul si accorge di Audrey per caso, mentre aspetta il verde sulle strisce pedonali che portano alla stazione di Prato. La sente parlare in francese vicino a un market che vende merce cinese di Wenzhou con i marchi “Abidas” e “Chenel”. Lui è in Italia da qualche anno, fa il sarto, parla poco la lingua e quando ci prova le persone normalmente gli dicono “tornatene al tuo Paese”. Così quando incrocia la voce di questa donna con i capelli tinti gli viene naturale domandarle: “Parli francese?”. Lei annuisce e da quell’incontro fortuito nasce un contatto telefonico. Ci vorrà un anno di silenzio e poi la costruzione a poco a poco di un delicato rapporto di fiducia per dare il la a un’amicizia e a un’inchiesta transnazionale sulle forme che può assumere la criminalità organizzata, scritta di getto su migliaia di post-it colorati.
Abdoul, di cui non facciamo il cognome per la sua sicurezza, nato nel 1984 nel quartiere Akouédo di Abidjan, la capitale della Costa d’Avorio, a due passi da una gigantesca discarica a cielo aperto, da raccontare ne aveva e ne ha. Un viaggio di 6.200 chilometri iniziato per caso nell’aprile 2015, per via di una macchina da cucire, lo ha portato da Abidjan a Prato attraversando Ouagadougou (Burkina Faso), Niamey e Agadez (Niger), Gatrone, Sabha, Gargaresh, Tripoli (Libia), il Mediterraneo, Lampedusa, Palermo, Caserta e poi su, nel luglio 2017, fino al Macrolotto del tessile di Prato. Ha passato di tutto, frequentando più la morte che la vita.
Audrey Millet, nata in Francia, sa aspettare e ascoltare: è storica di formazione e di mestiere, ricercatrice ed esperta dell’ecosistema della moda. Scrive senza paura e senza fronzoli, come dimostra il duro e bellissimo “L’odissea di Abdoul”, libro-inchiesta uscito in Francia per le edizioni parigine Les Pérégrines nel 2024 e ancora inedito in Italia.
Come citazione a mo di incipit Millet ha scelto una frase bruciante e attualissima attribuita a Dwight Eisenhower: “Scrivere, fotografare, filmare. Tra cinquant’anni qualche bastardo dirà che tutto questo non è mai esistito”. Il comandante in capo delle forze Alleate in Europa si riferiva ai campi di concentramento nazisti appena dopo averli visti nel 1945. La ricercatrice, invece, si riferisce a che cosa è accaduto e accade ancora oggi alle persone migranti per terra e per mare come Abdoul e agli sfruttati che stanno rannicchiati nel retrobottega buio di un Made in Italy della moda (e non solo) ormai imputridito.

“Raccontare la mia storia è stato come liberarmi, mi ha aiutato, ero chiuso in me stesso e dopo tutto quello che ho vissuto non riuscivo più a fidarmi”, dice Abdoul mentre prova a tenersi in equilibrio su una sedia traballante. Lo incontriamo a Milano, a fine febbraio, durante la preziosa tre giorni dello “Sfashion weekend” organizzata tra gli altri da Abiti puliti e dalla cooperativa Fair. Il luogo protetto è l’ufficio dello Spazio Mosso di via Padova dietro al bancone del bar, appena prima che Audrey presenti in pubblico il suo lavoro di ricerca e denuncia insieme a Francesca Ciuffi del sindacato Sudd Cobas. Abdoul è venuto ad ascoltarla ma rimane in posizione defilata, teme che qualcuno di cui ha parlato nel libro possa cercarlo. A tradurre la chiacchierata c’è Laura Ciriani.
“Raccontare la mia storia è stato come liberarmi, mi ha aiutato, ero chiuso in me stesso e dopo tutto quello che ho vissuto non riuscivo più a fidarmi” – Abdoul
“Sono nato in una famiglia molto povera, mio padre non aveva soldi per farmi studiare e fin da piccolo mi ha affidato a un cugino che aveva un atelier di sartoria a Divo -racconta Abdoul-. Lì ho imparato bene il mestiere”. Dal cugino Seydou prende la mano con una vecchia Singer a pedale. È bravo, si fa la reputazione del piccolo prodigio ma il parente non lo assume e a 31 anni si ritrova a guadagnare in nero 1,5 euro l’ora. “Quando mi sono sentito pronto, sono tornato da mio padre e gli ho detto ‘papà, aiutami a comprare una macchina da cucire’”. Risposta negativa.
Cerca perciò lavoro altrove finché un contatto non gli mette nell’orecchio la pulce che in Burkina Faso ci sono delle opportunità. “Per non deludere mio padre ho scelto di andare a Ouagadougou”. È metà aprile 2015, il primo stadio di quella che Abdoul chiama “la trappola”. Quando dieci anni fa sale su un autobus diretto a Ouagadougou della Rimbo transport voyageurs (mille chilometri, 17 ore, 60 euro) un peschereccio eritreo affonda nel Canale di Sicilia al largo delle coste libiche portandosi giù oltre mille persone, sotto gli occhi delle conniventi autorità europee.
Abdoul, intanto, finisce in un laboratorio di sartoria insieme ad altri tre. Il proprietario gli dà vitto e alloggio ma in cambio impone turni dalle nove di mattina alle sette di sera, sette giorni su sette. La paga è al pezzo, meno di un euro l’uno. Dopo quindici giorni chiede di essere ricompensato ma il padrone fa quello che si svuota le tasche e dice “peccato”. Ottiene solo la paga al netto di vitto e alloggio e se ne va: “Ho deciso di andare avanti, non tornare indietro, e sono andato in Niger”. Prende un altro bus della Rimbo e si fa 14 ore di viaggio per poco più di 500 chilometri.
La fermata è Niamey, la capitale, un altro puntino sulla mappa europea degli accordi volti alla “gestione delle frontiere”. Lui sprofonda nei campi di cipolle viola e la sua vita è un inferno. “Non mi rendevo conto che tutto quello che facevo mi si stava ritorcendo contro. Ho frequentato persone orribili ma non potevo più tornare indietro, mi avrebbero ammazzato”. Si convince che l’unica via sia quella di andare avanti e così prende un altro Rimbo e si dirige 900 chilometri a Nord-Est, verso le miniere di uranio e carbone non lontano da Agadez. “Là ci sono i bianchi”, un’altra pulce. Sono le pagine più difficili del racconto. Abdoul parla di “mostri senza testa”, bambine di neanche dodici anni rapite da bisunti uomini occidentali e cinesi, “una città di barboni dove siamo tutti nella merda”, ronde omicide, “una puzza indelebile di marcio”, adolescenti felici di viaggiare con due uomini sopra un’auto senza targa. “Ad Agadez ho visto le cose più terribili della mia vita, non le augurerei neanche al mio peggior nemico -sottolinea-. È lì che ho ripensato alle parole di mio padre: ‘sii disciplinato’”.

Una delle mille voci che si intersecano nei ricordi di Abdoul gli dice di andare in Libia dove sarebbe forte il mercato dei tappeti per la preghiera. Serve un sarto e a lui serve un’alternativa. Prende posto insieme ad altri su uno dei pick-up diretti a Nord, via deserto del Ténéré, munito di guanti e piumino, un bastone, occhiali da sole, un passamontagna e qualche dinaro. Ma la cosa più importante sono i biscotti e la tanica d’acqua. Nel giro di poche ore gli rubano telefono, passaporto, soldi e orologio: “Mi hanno sequestrato l’identità”.
Nella traversata viene gravemente ferito a una gamba ma è nulla rispetto a quanto accade alle bambine di neanche dieci anni. Vede le persone vendute come schiavi, ammazzate in un soffio, appese per mani e piedi e poi riprese in videochiamata per estorcere denaro alle famiglie, magari in un centro pagato con soldi italiani ed europei. Nel deserto, ancora prima, racconta di aver visto “grappoli” di persone abbandonate a morire ai lati delle vie. Non c’è spazio per la trascendenza qui. “Come le tracce delle ruote del pick-up, queste persone scompaiono in pochi secondi. Tutto svanisce nel deserto. Contiamo meno dei prodotti di altri traffici, come armi e droga”.
Quando gli domandiamo se abbia mai sentito nominare Abu Ayyub al-Masri, il torturatore libico liberato dal Governo Meloni a inizio anno umiliando la Corte penale internazionale, scuote la testa. Il libro di Millet e il racconto di Abdoul a un certo punto cambiano passo e dimensione. Da cronaca disumana del viaggio diventa un affondo nell’economia tessile del Macrolotto di Prato, l’ultimo girone dove giunge il protagonista dell’odissea, alla disperata ricerca di un codice fiscale. Passa da una forma di caporalato a un’altra. Un gestore cinese di un’officina che dà lavoro a una trentina di persone gli propone la paga al pezzo: 1,50 euro (in nero), proprio come suo cugino ivoriano, ma il tetto al giorno è di 30 euro.
1,5 euro al pezzo, in nero, con un tetto massimo di 30 euro al giorno. È la “paga” proposta ad Abdoul dal gestore di un’officina tessile a Prato
Il “consiglio” è di non prendere un alloggio: “Stai qui, abbiamo letti a castello, tende, una doccia, un bagno e una stufa”. Per descrivere il comparto tessile di Prato e della Piana fiorentina Millet usa l’immagine della cloche: la torta all’interno se la spartiscono le organizzazioni criminali italiane e straniere ma a coprire e a dominare tutti ci sono i grandi marchi dei colossi multinazionali. Abdoul ci ha messo sette anni da quando è partito per firmare un contratto a tempo indeterminato e avere i documenti. Oggi lavora su tre turni, prende 1.200 euro netti e si sente liberato. “Anche se la mia situazione migliora so che qui è il Far West: conta solo la legge del più forte”. La sua sedia continua a traballare.
© riproduzione riservata