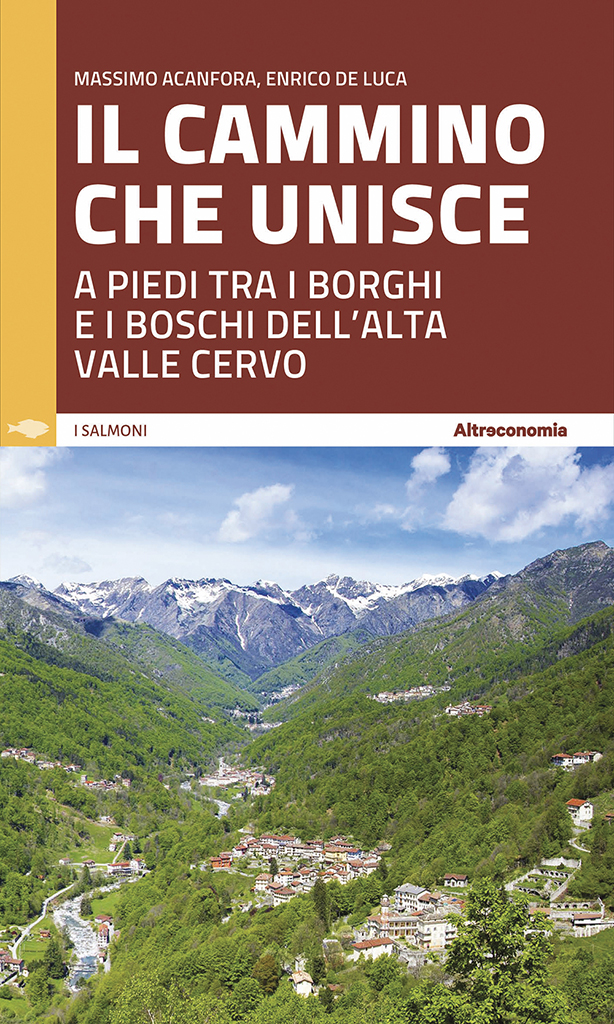Cultura e scienza / Intervista
Quelle “guerre culturali” che amano la vittima ma non spaventano il capitale

Intervista al critico letterario Mimmo Cangiano: a partire dal suo libro “Guerre culturali e neoliberismo” riflette su come postmoderno e poststrutturalismo siano diventati strumenti a favore dello status quo. Le “guerre culturali”, incapaci di mettere in crisi il neoliberismo, sfociano spesso in individualismo e manipolazioni, creando una “cultura della vittima” scollegata dalla lotta contro lo sfruttamento
Un vecchio manifesto del ’68 francese suona oggi come una profezia: raffigurava uno studente in fuga, inseguito da un anziano barbuto, con la scritta “Cours, jeune homme, le vieux monde est derrière toi” (Corri, ragazzo, il vecchio mondo ti vuol riagguantare).
Il concetto era quello della recuperation, ovvero come le battaglie rivoluzionarie vengono recuperate da un sistema capace di trasformarle in merce. Espressioni come politically correct, identity politics, woke, cancel culture, pink o rainbow-washing, importate dagli Stati Uniti, sono ormai note nelle battaglie identitarie progressiste, combattute in nome di genere, etnicità, classe, corpo e orientamento sessuale, contro ogni rimozione o omologazione del “particolare” nel discorso politico, istituzionale e pubblico.
Mimmo Cangiano, oggi docente di Critica letteraria e Letteratura comparata all’Università Ca’ Foscari di Venezia, conosce bene la storia di queste “guerre culturali” nel mondo anglosassone, avendo lavorato per molti anni nell’accademia statunitense. Qui, il post-moderno e il post-strutturalismo (o meglio la sua versione rivista sotto il nome di French Theory), inizialmente ideologie de-costruttive, sono diventati strumenti giustificativi dell’esistente.
Nel suo libro “Guerre culturali e neoliberismo” (pubblicato da Nottetempo), Cangiano ricostruisce l’evoluzione storica di questi movimenti, evidenziando le stratigrafie ideologiche, i piani simbolici e le contraddizioni pragmatiche intrecciate nelle “guerre culturali”. Queste, non riuscendo a liberarsi dai vincoli del sistema neoliberista, rischiano spesso esiti ambigui, derive individualistiche o manipolazioni funzionali. Il risultato è una “cultura della vittima”, totalmente scollegata da qualsiasi pensiero dialettico, ovvero la capacità di ragionare come classe sfruttata in relazione con chi sfrutta realmente. Cangiano ha risposto ad alcune domande a partire dal suo libro.
Vorrei partire dalla citazione all’inizio che prendi da Gramsci, che parafrasandola dice: se una guerra culturale non è legata a una prassi non ha senso, perché il capitalismo non è un’ideologia, prende tutte le ideologie esistenti per farne profitto. Questa può essere una posizione di partenza del tuo discorso?
MC Avevo pensato di concludere il libro con un’altra idea di Gramsci. Si cita spesso la famosa frase di Foucault: “il sapere è fatto per prendere posizione”. Gramsci, invece, direbbe che il sapere è fatto per comprendere qual è la propria posizione all’interno della rete dei rapporti sociali. La cultura, quindi, non serve a immaginare che possa esistere un’ideologia radicalmente anticapitalista, ma a capire come il capitalismo ci faccia diventare sintomi di se stesso, anche con le nostre ideologie e il nostro modo di vivere. Anche il marxismo, pur essendo un’ideologia anticapitalista, può essere fatto proprio dal capitale. Abbiamo le magliette di Che Guevara, o film prodotti dal capitale a scopo di profitto che esaltano valori marxisti. La grande differenza è che il marxismo non ha mai pensato che il suo pensiero potesse superare il capitalismo da solo. Immaginava una soluzione nella prassi, nell’azione, per rompere il meccanismo di mercificazione del pensiero e dei comportamenti. Le guerre culturali, invece, immaginano il capitalismo come un sistema statico e monologico, e pensano che un’ideologia relativista e multiculturale sia immediatamente anticapitalista. Ma non funziona così. Il capitalismo può fare proprie ideologie differenti. Non esiste un’ideologia capace di essere al di là del capitalismo, perché ogni ideologia è figlia del capitalismo.
Perché il discorso del capitale si adatta bene sia a un discorso identitario di sinistra sia di destra?
MC Ci sono molte teorie oggi che vedono il sovranismo come un aspetto del neoliberalismo. Sono abbastanza d’accordo: il capitale riesce a venderti anche le soluzioni ai mali che ha creato. Finora non abbiamo visto nessun governo sovranista di destra fare qualcosa per ostacolare il capitalismo multinazionale. Si parla di identità italiana e difesa del territorio, ma non si fa nulla contro Airbnb per preservare i nostri centri storici o per la qualità del cibo e delle filiere, ad esempio. Il capitale si muove in due direzioni, probabilmente anche per la competizione fra capitalisti e la necessità di Paesi economicamente più deboli di sposare un’ideologia differente per contrastare quella del capitale più forte. A sinistra, invece, si è presa una direzione di culturalismo. Giovanni Arrighi dice che l’unica cosa che interessa al capitale è la possibilità di riprodursi. E per questo può mettere a frutto qualsiasi ideologia. Non è l’ideologia che interessa al capitale, ma il profitto. Finché gli conviene, il capitale adotta logiche patriarcali, non perché odi le donne, ma perché non pagare il lavoro riproduttivo significa riprodursi meglio. Questo è l’aspetto materiale che spesso sfugge. Concepire il capitale come legato a un interesse materiale ci aiuta a capire che non è sposato a vita con un’ideologia specifica. Nel libro critico anche i cosiddetti “rosso-bruni”, che pensano di essere contro il capitalismo focalizzandosi su questioni sociali e materiali. Ma in realtà fanno lo stesso movimento del woke, solo che al contrario. Pensano che un’ideologia identitaria e anti-multiculturale possa mettere in crisi il capitalismo, ma non funziona così. Il capitalismo riesce a sfruttare qualsiasi tipo di ideologia. Marx ci ha insegnato che ciò che noi vediamo come capitalismo dipende dalle azioni di tutti i capitalisti, e che quindi il capitalismo cambia e si adatta. Non esiste un’ideologia capace di superarlo, e dobbiamo spostare la lotta sul piano della prassi.
È in atto una competizione tra minoranze per stabilire chi è la vittima più grande: descrivi una cultura della vittima e, in un certo punto, affermi che la classe non è mai stata vista da Marx come una vittima. Puoi approfondire questo concetto?
MC Ripeto spesso una battuta paradossale: se seguissimo alla lettera le indicazioni che provengono da alcune frange, legate alle guerre culturali della cosiddetta woke culture, dovremmo concludere che Marx non avrebbe dovuto scrivere “Il Capitale”, in quanto la sua identità non era proletaria, ma si sarebbe dovuto limitare a sostenere il movimento operaio come un alleato. Ci sono alcune cose che non funzionano nelle guerre culturali, come la mercificazione dell’identità di cui parlo nel mio libro. Riguardo alla “gara delle vittime”, c’è questa continua esibizione dei tratti non normativi della propria personalità al fine di chiedere al capitale o al potere qualche briciola simbolica. Questo fenomeno è strettamente collegato ai processi materiali e non è un caso che sorga nel momento in cui i meccanismi di protezione collettiva, come lo stato sociale, il welfare, la sanità pubblica, sono sotto attacco. Quando questi meccanismi cominciano a sgretolarsi, vediamo le persone agire sulla base di istanze private, spesso legate ai meccanismi del lavoro autonomo. Marx non vedeva la classe proletaria come una vittima, ma come il soggetto centrale della trasformazione sociale perché era la più vicina al funzionamento dei meccanismi produttivi. Oggi, invece, si tende a definire i gruppi resistenti o rivoluzionari sulla base della sofferenza, il che è problematico. La vittima, infatti, non può mai essere un soggetto rivoluzionario. Marx individuava nel proletariato industriale il soggetto centrale non perché soffrisse di più, ma perché era quello più in grado di comprendere il funzionamento del capitale. Oggi, la terziarizzazione dell’economia ha spostato il centro del sistema, rendendo meno chiaro chi debba essere il nuovo soggetto egemonico. Probabilmente, come suggerisce Cristina Morini, il nuovo soggetto potrebbe essere rappresentato dalle donne, non perché abbiano sofferto di più.
Nel libro noti come l’empowerment, una caratteristica del femminismo, sia diventato un concetto aziendale, come il diversity management uno strumento di controllo dei lavoratori. Puoi descrivere che cosa intendi per “naturalizzazione del capitalismo”?
MC Da un lato, osserviamo questo fenomeno strano in cui, mentre politicamente si accettano molte delle richieste dei movimenti femministi della seconda ondata, assistiamo a una depoliticizzazione dell’economia. Questa dinamica sposta i rapporti di forza materiali e sociali all’interno della sfera privata e interiore. Ricordo una citazione nel libro di Fanon, che descrivendo l’intellettuale algerino tradizionale, dice: “Libera la tua mente e il resto seguirà”, come se bastasse operare su di sé per cambiare il mondo. Di fronte a un sistema che sembra trascendente e su cui non riusciamo più a intervenire politicamente, pensiamo che il privato sia più importante. Questo è ciò che intendeva Lukács con l’idea che quando tutti i linguaggi sono esauriti ci rifugiamo nell’interiorità: con la “prassi dell’individuo isolato”, che vede la propria etica come il luogo dove cambiare il mondo. Riguardo al diversity management, è interessante notare come, ad esempio, Amazon, pochi mesi dopo l’omicidio di George Floyd, abbia messo il banner “Black Lives Matter” sulla sua homepage. Questo può essere letto come un fenomeno di washing, ma c’è di più. Bezos ha iniziato a devolvere milioni ad associazioni contro il razzismo e a organizzare corsi inclusivi nelle sue aziende, mentre contemporaneamente contrastava un sindacato tradizionale in Alabama. Questo fenomeno va oltre il semplice washing e mostra come le grandi corporation utilizzino l’inclusività come strumento di controllo, introducendo un linguaggio politicamente corretto che protegge alcune fasce deboli dei lavoratori, ma allo stesso tempo ostacolando i movimenti sindacali tradizionali.
Parli del particolarismo militante e del fatto che anche in contesti militanti c’è una diffidenza rispetto alla classe lavoratrice. Puoi approfondire?
MC L’effetto di questo individualismo e anti-universalismo è che la classe non è più vista come un soggetto per costruire relazioni e lotte anticapitaliste, ma con disprezzo. Essere parte di una classe non è una questione identitaria, ma una questione di rapporti. Probabilmente abbiamo perso la capacità di pensare dialetticamente. Negli anni, questa contrapposizione tra caratteri identitari e di classe ha portato a divisioni inutili. L’essere donna, non bianco, non eterosessuale modifica la tua posizione all’interno della classe, ma non modifica il fatto che stai vendendo la tua forza lavoro per sopravvivere.
Nel tuo libro c’è una critica del postmoderno come accettazione dello status quo, al limite si prevedono miglioramenti all’interno del capitalismo, “there is no alternative”. A un certo punto parli del concetto di “pappa postmoderna” preso da Furio Jesi: puoi spiegarlo?
MC Jesi parlava di “pappa” riferendosi alla cultura di destra del Novecento che mescola tematiche come il mito dell’agricoltura, del valore d’uso, dell’artigianato, della comunità organica e della razza, e le presenta come una soluzione mentre è già compromessa con lo sviluppo industriale e il capitale. Questo concetto si applica anche a come certe teorie postmoderne e post-strutturaliste vengono utilizzate oggi. Vengono mescolate insieme in un “pappone” che sembra critico, ma in realtà è compatibile con il capitalismo. Questo è il problema: è come se un supermercato vendesse prodotti transgenici e sfruttasse i contadini in Sud America, mentre un altro proponesse un capitalismo etico e tollerante verso le minoranze. Entrambi sono parte dello stesso sistema capitalistico, ma uno è accettato perché sembra diverso. Il capitalismo funziona sempre sfruttando, quindi nessuna inclusione è realmente possibile. Inclusione nel capitalismo significa solo modificare le gerarchie di chi è sfruttato di più e chi meno.
© riproduzione riservata