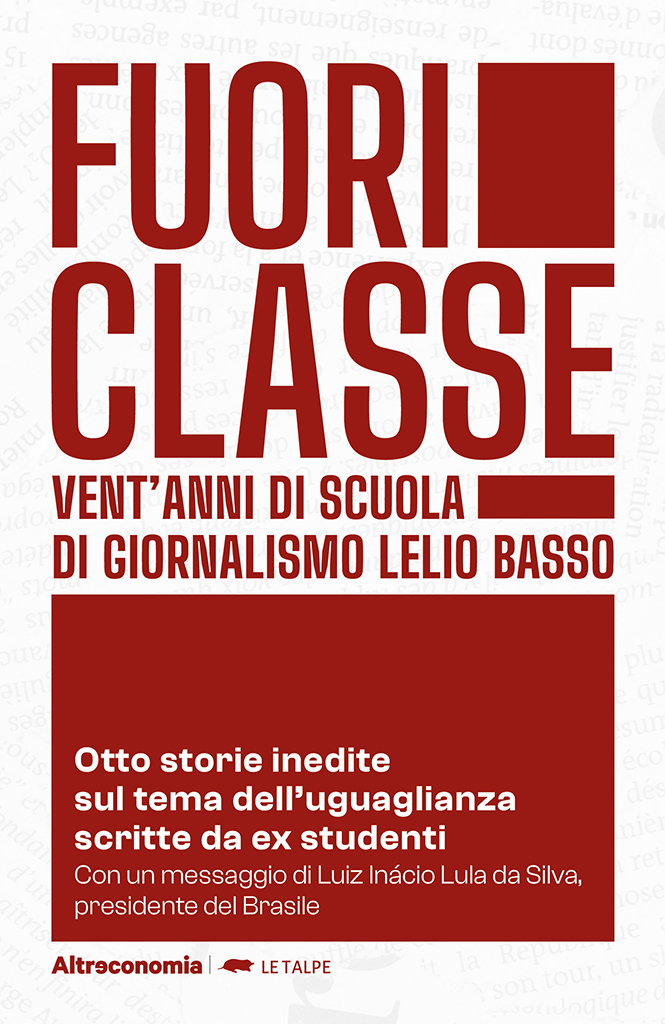Cultura e scienza / Approfondimento
Lo sguardo sulla fine del mondo. Nelle mappe i rischi dell’Antropocene

Il 20 maggio ricorrono i 450 anni dalla pubblicazione del primo atlante, il “Theatrum orbis terrarum” di Ortelius. Rivoluzionò la prospettiva europea sul mondo. Oggi però la cartografia è nelle mani di Google. Ed è un problema
Le antiche mappe non hanno ancora detto tutto. Il 20 maggio 2020 ricorrono i 450 anni dalla pubblicazione del primo atlante della storia, il Theatrum orbis terrarum di Abraham Ortelius; ma la visione rivoluzionaria di cui si è fatto veicolo rappresenta più una minaccia che un dono per il sapere odierno. Paradossale è che la memoria del cartografo fiammingo -capace di restituire un’immagine del mondo organica ma al tempo stesso in continua trasformazione- sia affidata in via quasi esclusiva al suo più acerrimo nemico: Google. Al di là degli aggiornamenti di logo con cui il più importante motore di ricerca del web omaggia ogni anno Ortelius, sono i suoi servizi “Earth” e “Maps” ad aver tradito il messaggio del Theatrum. La denuncia arriva da una piattaforma web che raccoglie proprio l’eredità del fiammingo, l’Atlante per la Fine del Mondo, curata dall’architetto paesaggista Richard Weller e dal suo team di ricercatori in “cartografia ecologica”. Grazie al ruolo di co-direttore del McHarg Center dell’Università della Pennsylvania, Weller ha inaugurato nel 2017 un metodo di mappatura che focalizza l’attenzione sulle aree del mondo di maggior tensione tra biodiversità e crescita urbana. Un atlante complesso, in grado di incrociare metadati proprio come Google ma consapevole della mancanza di oggettività della cartografia contemporanea. Il suo obiettivo è smascherare i pregiudizi insiti nel modo di osservare il mondo, aprendo alla possibilità di rigenerare il Pianeta da una prospettiva non più tecnocentrica. “Non esiste una carta accurata del mondo -aveva messo in guardia Jerry Brotton nel suo saggio ‘La storia del mondo in 12 mappe’- e non ci sarà mai. Il paradosso è che non possiamo mai conoscere il mondo senza una mappa ma non possiamo neanche rappresentarlo definitivamente con una mappa”.
Alla sua voce ha fatto eco Thomas Reinertsen Berg, autore del libro “Mappe, il teatro del mondo”: “Google ha capito che le mappe sono principalmente un oggetto della quotidianità, che sempre più spesso servono a trovare un nuovo negozio, o la casa di uno che vende una bici usata su Internet e sempre più raramente a fantasticare viaggi. Per questo può permettersi di lasciarcele consultare gratuitamente”. Uno strumento, nel migliore dei casi, di trasmissione pubblicitaria. Del rischio di una conoscenza economicamente “interessata”, però, era già ben consapevole Ortelius, abilissimo disegnatore di mappe di Anversa, presto dimenticato dalla storia per via della rapidità con cui queste venivano aggiornate nell’epoca delle grandi esplorazioni. A lui va riconosciuto anche il merito di aver intuito per primo la deriva dei continenti così come l’esistenza del leggendario passaggio a Nord-Est. Ortelius scelse di nominare il suo atlante Theatrum, sottolinea Monica Matei-Cesnoiu in “Re-imagining Western European Geography in English Renaissance Drama”, perché mosso dall’idea che le mappe sono illusioni, “rappresentazioni che fungono da specchi della realtà di fronte all’occhio di chi le osserva”. Non a caso il frontespizio dell’opera, una collezione originalmente composta di 69 mappe provenienti da 86 cartografi (arrivate poi a 151 già nella riedizione del 1591), presenta l’immagine di un proscenio incorniciato da cinque seducenti donne: sono le allegorie dei continenti allora conosciuti e ancora da scoprire, cui è affidato il compito di ricordare che la geografia è, e non può che essere, “l’occhio della Storia”, ossia del tempo.

Una lezione oscurata dai successi della tecnica che, nell’abbaglio del qui e dell’ora, ha sviluppato un modello teorico che l’Atlante della Fine del Mondo giudica oggi fatale per il Pianeta. In riferimento agli obiettivi del Piano strategico per la Biodiversità 2011-2020, elaborato dalle Nazioni Unite e in revisione il prossimo ottobre, l’ideatore dell’Atlante Richard Weller muove dal paradosso della crescita delle aree protette nel corso degli ultimi sette anni. Il loro tasso è salito dal 13,5% a oltre il 15,4% (corrispondente a 20 milioni 600mila chilometri quadrati, distribuiti su circa 209mila siti di 235 diversi Paesi), mostrando un trend positivo verso l’obiettivo del 17% previsto per la fine del 2020. Il problema riguarda il fatto che i modi di misurare le sostenibilità del nostro Pianeta si basano su un paradigma ambientale non più valido. “L’ambiente è oggi inteso come territorio -spiega il paesaggista Rem Koolhaas in “Cities of the world”- e il territorio risulta un continuum disfuzionale”. Grazie alla capacità tecnica di superare o adattarsi a qualsiasi ostacolo naturale, l’unico parametro di riferimento viene considerata la modalità di espansione urbana. Avendo reso obsoleto qualsiasi riferimento all’altro, o al “selvatico” di un tempo, è fallito anche il tentativo di rapportarsi al territorio in un’ottica di “environmental stewardship”: di cura di quel fantomatico “oggetto” che chiamiamo ancora natura, grazie all’azione diretta dell’uomo. L’attenzione scientifica è stata rivolta a come limitare i nostri impatti sul Pianeta, preoccupandosi ad esempio dei pericoli derivanti dall’immissione in atmosfera di oltre 525 miliardi di tonnellate di carbonio (stima calcolata fra il 1870 e oggi).
“Google ha la potenzialità per dominare la cartografia globale.Se faremo progressi rapidi, le applicazioni cartografiche e geospaziali globali saranno nelle sue mani” – Simon Greenman
Eppure non è stato mai preso in considerazione, almeno sino agli ultimi anni, il ruolo che negli equilibri ecosistemici hanno i cianobatteri, co-abitanti del Pianeta responsabili della cattura, o del rilascio dell’anidride carbonica nell’atmosfera, tanto quanto l’uomo (nonché agenti attivi di una delle più grandi estinzioni di massa vissute dalla Terra). “Analogamente la strategia di tutela definita nell’Ecomodernist Manifesto for Good Anthropocene” (2015) -sottolinea Clive Hamilton in “The Anthropocene as rupture”- non ha fatto altro che modificare il concetto di stewardship in una ben più pericolosa idea di geoingegneria, in virtù della quale è possibile favorire il rinselvatichimento (rewilding) della Terra seguendo una visione tecno-utopica di manipolazione ambientale”. Nonostante le critiche di antropocentrismo rivolte all’atlante di Ortelius, la scienza ha continuato a elaborare risposte adattive non uscendo mai da una dimensione autoreferenziale, aggravata però dalla convinzione che la tecnica -sino alla sua trasformazione in Intelligenza Artificiale- fosse in grado di elaborare modelli a prova di errore umano. Ogni processo, in realtà, travalica sempre il flusso di dati prodotti dall’uomo, essendone lui stesso una variabile interna. “La materia di questa cyborg macchina a mappatura perpetua -auspica l’ideatore dell’Atlante per la Fine del Mondo, in riferimento alla cartografia digitale- non deve riguardare solo dove le cose si trovano nello spazio, ma molto più sottilmente come le cose cambiano nel tempo”.
70% la quota di mercato delle mappe gestita da Google. Una posizione dominante che rende ormai inutili i contribuiti alternativi
Se il cartografo fiammingo poteva contare sull’aiuto di sconosciuti in possesso di informazioni su singole regioni della Terra, chiedendo di poter ricevere mappe da consultare, riprodurre e assemblare, oggi il principio di raffigurazione del globo non funziona più in modo democraticamente partecipato. “Le immagini sono il prodotto di un sistema d’informazione geolocalizzato da 20 petabyte e oltre -osserva ancora Thomas Berg nel suo “Mappe”- corrispondente all’incirca a 10mila miliardi di pagine al secondo”. Non sono che la proiezione standardizzata di satelliti che ruotano intorno alla Terra, fornendo aggiornamenti 50 volte al secondo. “Google gestisce il 70% del mercato delle mappe prodotte -aggiunge- e grazie alla sua posizione dominante, dovuta anche al fatto che il 30% di tutte le ricerche su Internet riguardano l’ubicazione di qualcosa, rende ormai inutili i contributi alternativi di altri colossi come Apple, Microsoft o Yahoo”. Nell’ultimo rapporto Icomp, Initiative for a competitive online marketplace, viene perciò sollecitato un intervento delle autorità affinché sia ripristinata il prima possibile la pluralità cartografica, onde evitare che i concorrenti di Google in questo campo continuino a sparire. Per Simon Greenman, fondatore di mapquest.com, l’azienda statunitense di Mountain View ha infatti “la potenzialità per dominare la cartografia globale a livelli storici senza precedenti. Se faremo progressi rapidi per dieci o vent’anni, le applicazioni cartografiche e geospaziali globali saranno in mano a Google”.
© riproduzione riservata