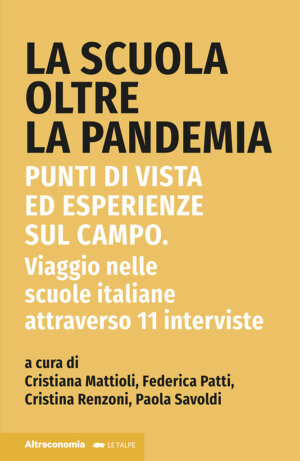Interni / Inchiesta
La riforma dei dottorati rischia di peggiorare la salute dell’università

Le modifiche introdotte nel giugno 2022 garantiscono più tutele ai ricercatori. Ma il mancato aumento delle risorse pubbliche diminuisce i posti disponibili e fa crescere il ruolo dei privati. L’Italia rischia di perdere intere scuole di ricerca
La riforma che ha portato, a fine giugno 2022, all’abolizione dell’assegno di ricerca, che teneva oltre 15mila dottorandi in una condizione di precarietà e incertezza, rischia di peggiorare la “salute” dell’accademia italiana, caratterizzata da poca ricerca di base, aziendalizzazione e precarietà. “La condizione degli assegnisti era indifendibile ma, a fronte di un aumento del ‘costo del lavoro’ per le università, serve un adeguamento delle risorse pubbliche per garantire lo stesso numero di posti di ricerca -spiega Giuseppe De Nicolao, professore ordinario al dipartimento di Ingegneria industriale e dell’informazione all’Università di Pavia e presidente di Return on academic research and school (Roars), rete nata nel 2013 per migliorare la qualità del dibattito pubblico sul mondo della ricerca-. Altrimenti, inevitabilmente, ci si affida al mercato e questo ha grosse incognite: sia perché si va verso una forma di spinta a favore dei settori che hanno più facilità nel reperire finanziamenti esterni, sia perché spesso le aziende si concentrano sull’ultimo miglio della ricerca. Ma quella di base è fondamentale perché non sappiamo che cosa tornerà utile tra dieci anni”.
Per capire le storture della nuova riforma cosiddetta del “pre-ruolo” serve fare un po’ di ordine. La carriera universitaria prevede, a seguito del conseguimento della laurea, la possibilità di proseguire con un dottorato di ricerca della durata fino a quattro anni, come stabilito dalla riforma del dicembre 2021 che ha reso flessibili i tre anni previsti in precedenza. Prima delle modifiche del giugno 2022, una volta concluso il dottorato, le vie per intraprendere la carriera universitaria e diventare professore associato erano principalmente tre: gli assegni di ricerca, i posti da ricercatore a tempo determinato di tipo A (Rtda), senza garanzie di proseguire, e di tipo B, con la possibilità di un passaggio di ruolo senza la necessità di vincere un concorso pubblico. Con la riforma sono stati aboliti l’assegno di ricerca e l’Rtda, sostituiti da un contratto di ricerca della durata di due anni rinnovabile per altri due, ed è stata istituita la nuova figura del Ricercatore in tenure track (Rtt), più simile al “vecchio” ricercatore di tipo B che, come detto, è una sorta di percorso di conferma in ruolo.
“Finalmente viene tutelata la fase di post-dottorato -commenta Annalisa Dordoni, assegnista di ricerca presso il dipartimento di Sociologia dell’Università degli Studi Milano-Bicocca-. La figura dell’assegnista di ricerca era inquadrata come una sorta di collaborazione continuativa e non di lavoro subordinato dipendente. Un unicum in Europa e una posizione poco tutelante. Ma il problema è il mancato aumento dei finanziamenti ordinari per la ricerca”.
Come ricostruito dall’associazione Dottorandi e dottori di ricerca in Italia secondo quanto stabilito dalla cosiddetta riforma Gelmini del 2010 e dal successivo decreto interministeriale del marzo 2011, un assegno di ricerca prevedeva un costo all’università di quasi 24mila euro. Con il nuovo contratto, invece, il costo per l’amministrazione sale a quasi 38mila euro ma per una durata minima di due anni. In altri termini: all’università serviranno, fin dall’inizio, circa 80mila euro per attivare un contratto contro i 24mila necessari prima della riforma. Più diritti ma meno posti disponibili. “In fase di conversione è stata aggiunta una postilla finale: i finanziamenti utilizzati per i nuovi contratti di ricerca non possono superare quanto speso in media dalle università per gli assegnisti di ricerca nei tre anni precedenti -continua Dordoni-. Questo crea inevitabilmente un effetto di ‘espulsione’ dei nuovi ricercatori dalle università. Se il contratto al lordo costa più del doppio dell’assegno e non ho più soldi da spendere potrò permettermi metà delle persone”.

Un problema che riguarda anche il regime transitorio per quei progetti pluriennali che avevano già ricevuto i finanziamenti. “Coordino un gruppo di ricerca di cui fanno parte anche assegnisti finanziati dalla Fondazione per la ricerca sul cancro (Airc) -spiega Gianfranco Bocchinfuso membro della Rete29Aprile e professore associato di Chimica e fisica all’Università Tor Vergata di Roma-. Il progetto è pluriennale e quando il decreto sarà operativo non sarà possibile coprire i costi del numero di persone necessarie per portare avanti la ricerca. Premesso che è sacrosanto l’aumento delle tutele, ma se la riforma non verrà adeguatamente finanziata questo aspetto diventerà problematico sia per chi potrebbe ritrovarsi senza borsa, sia per chi è responsabile di portare a termine ricerche già finanziate per le quali disporrebbe di meno collaboratori”.
“La precarietà degli assegnisti era indifendibile ma, a fronte di un aumento del ‘costo del lavoro’ per le università, serve un adeguamento delle risorse pubbliche” – De Nicolao
La riforma del “pre-ruolo” non riguarda “solamente” il futuro dei 15.489 assegnisti di ricerca registrati dal ministero dell’Università e della ricerca nell’anno accademico 2020/2021 attualmente in organico nelle università italiane, ma rischia di incidere ancora di più sulla cosiddetta “aziendalizzazione” del mondo accademico: se mancano i fondi pubblici, il ruolo dei privati cresce di importanza. Tanto che la stessa ministra dell’Istruzione uscente, Maria Cristina Messa, su richiesta di chiarimenti da parte degli Atenei italiani, con una nota dell’8 luglio 2022 ha specificato come la tagliola prevista per le risorse necessarie per attivare i nuovi contratti non riguardi “quelle provenienti da progetti finanziati, in tutto o in parte, da soggetti esterni”.
“Questo è un duro colpo per la ricerca di base -spiega Sara Ruschioni, professoressa associata dell’Università politecnica delle Marche, dipartimento di Scienze agrarie, alimentari ed ambientali-. Un conto è chiedere a un’azienda un finanziamento per testare un suo prodotto e siglare un protocollo, un altro è invece richiedere risorse per ricerche che non hanno spendibilità sul mercato”. Una tendenza che, dati alla mano, è già presente nel mondo accademico italiano. Al dicembre 2020 il maggior numero di docenti e ricercatori afferisce all’area delle Scienze mediche (14,7%) e appena il 2% a quella di Scienze della Terra, il 2,9% a Scienze politiche e sociali, il 7% a Scienze giuridiche. Inoltre, in queste aree la percentuale di professori (associati e ordinari) rispetto ai ricercatori è più alta che nelle altre: segno di come il “ricambio” sia più lento.

Ruschioni porta l’esempio dei suoi studi sul comportamento delle api. “Nonostante sia un tema fondamentale per capire come sta l’ambiente, la possibilità di trovare finanziamenti è sempre più remota, poiché non c’è un riscontro economico diretto. Fino a oggi, ad esempio, realtà come il Parco del Conero hanno spesso mostrato interesse nel finanziare 24mila euro per un ricercatore, le cose cambiano drasticamente se la richiesta triplica. Sia chiaro: i diritti vanno riconosciuti, ma serve un finanziamento pubblico adeguato”. Questa riforma, quindi, rischia di aumentare la forbice già esistente tra le aree di studio che ricevono più o meno facilmente finanziamenti: una tendenza che non è contrastata dalle risorse europee. “Dovrebbe essere il contrario -spiega De Nicolao-. L’Ue tende a finanziare settori di frontiera perché cambieranno l’orizzonte, delegando agli Stati nazionali il compito di mantenere l’equilibrio con le altre aree di ricerca: in Italia questo contro-bilanciamento non c’è”.
“Un conto è chiedere a un’azienda un finanziamento per testare un suo prodotto, un altro è richiedere risorse per ricerche che non hanno spendibilità sul mercato” – Ruschioni
Nei settori in cui i finanziamenti pubblici sono insufficienti, rispondere alle esigenze del mercato diventa così il prerequisito per poter continuare. “A volte delle scommesse relativamente piccole potrebbero avere grandi ritorni perché nella scienza raramente riusciamo a prevedere dove ci saranno i maggiori sviluppi. Se si stringe l’imbuto vince chi ha le spalle più larghe e avere i finanziamenti esterni, nella feroce concorrenza interna all’accademia, può diventare un atout decisivo”.
Il quadro è reso ancora più complesso dall’utilizzo dei fondi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) destinati alla ricerca per un totale di circa 15 miliardi di euro. Per l’anno accademico 2022/2023 sono state messe a bando più di cinquemila borse di studio per un totale di 300 milioni di euro di investimento suddivisi in diversi ambiti, la maggior parte per “dottorati innovativi che rispondono ai fabbisogni delle imprese e promuovono l’assunzione dei ricercatori da parte di queste ultime”. È significativo che, in parallelo, i ricercatori assunti sui fondi Pnrr saranno ricercatori a tempo determinato di tipo A, la figura precaria abolita dalla riforma del “pre-ruolo” che sopravviverà così fino al 2027 per permettere al Pnrr di andare avanti, con un doppio problema. “Sicuramente l’università beneficia di personale a basso costo per quattro anni ma cosa ne sarà di questi ricercatori? Ci saranno posti a elevata qualificazione per tutti? -osserva De Nicolao-. Senza dire che sulla struttura amministrativa universitaria che gestisce i dottorati verrà improvvisamente a gravare il doppio delle matricole”.
“Serve un’università in cui la parola chiave sia cooperazione, non competizione. Speriamo non sia già troppo tardi per cambiare rotta” – Bocchinfuso
Il problema dei fondi del Pnrr è poi, nuovamente, la decisione su che cosa investire e come farlo con le storture già descritte in precedenza. “Con questi soldi si sta mettendo in atto una mutazione del sistema accademico che sarà duratura: le tematiche sono state decise in modo opaco e con scarso coinvolgimento dell’accademia -continua Bocchinfuso-. Se non aumentano i fondi ordinari ci sarà una sproporzione tra chi fa un tipo di ricerca e chi non lo fa. Perché alcuni, come me, avranno decine di ricercatori e quando dovranno discutere la ripartizione delle risorse ordinarie del personale questa cosa peserà molto: si deciderà di fare un professore associato in quel campo, piuttosto che in un settore in cui a malapena c’è qualche ricercatore. Si rischia di perdere intere scuole di ricerca”.
Una deriva che vede come “punto di non ritorno” la legge 240 del 2010, conosciuta come “Riforma Gelmini”, che portò a un taglio netto degli investimenti sull’università, descritta come sovradimensionata. “Una visione distorta -sottolinea De Nicolao-. Gli stessi che hanno sostenuto quella riforma oggi fanno gli smemorati e, accorgendosi degli errori, tentano un’inversione a ‘U’ senza capire bene che cosa fare e come farlo”.
Dello stesso avviso è anche Bocchinfuso: così come Roars, anche Rete29aprile ha preso forma a seguito delle riforme del 2010. “Verticismo, attenzione al mercato e competizione tra gruppi e colleghi: sono queste le parole chiave di quella riforma che ha accentuato la deriva neoliberista dell’università. Non ha risolto i noti problemi -i ‘baronismi’ ci sono ancora così come i concorsi a tavolino- ma premiato ancor di più le cosiddette ‘eccellenze’ senza preoccuparsi di assicurare un sistema di qualità omogeneo, in tutto il territorio nazionale e in tutte le aree disciplinari. Serve un’università in cui la parola chiave sia cooperazione, non competizione. Speriamo non sia già troppo tardi per cambiare rotta”.
© riproduzione riservata