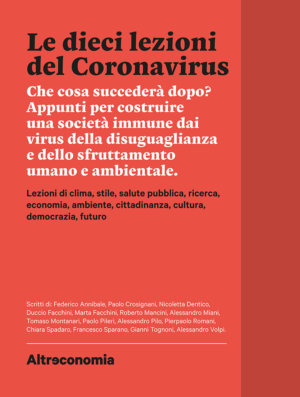Diritti / Opinioni
Il distanziamento sociale mette in crisi la democrazia. Ma non siamo in guerra

“Non parlare di guerra può aiutare ad acquisire una abitudine mentale nuova, cosmopolita, che abbandoni le divisioni, il vocabolario dei conflitti e sappia ragionare in forme unitarie. Sul terreno sanitario, come su quello sociale ed economico”. L’analisi di Alessandro Volpi
Le parole e i simboli hanno un peso rilevante in questa fase. La pandemia e la guerra hanno in comune le vittime, la paura e l’emergenza, intesa come sospensione di ciò che viene definito nei termini della normalità. Non bastano, tuttavia, questi tre elementi a giustificare l’utilizzo del linguaggio bellico per descrivere cosa sta succedendo.
La guerra ha avuto a che fare, nel tempo, con la follia umana, con la volontà di potenza, con il fanatismo religioso, con l’odio razziale, con gli interessi economici, spesso con tutti questi aspetti insieme. Si è combattuta anche per l’aspirazione alla libertà e alla liberazione. La guerra, soprattutto, è stata ed è divisione, contrapposizione; bellum ha la propria origine etimologica in duellum e guerra deriva dal germanico werra (mischia, scontro). La pandemia, invece, accomuna, supera le distinzioni e le divisioni, colpisce tutti senza confini; le guerre si sono combattute per i confini, la pandemia li abbatte. La pandemia non è una guerra, è una catastrofe che ha bisogno di essere affrontata in modo unitario dall’intero Pianeta con lo strumento decisivo di una scienza democratica e universalistica, in grado di rinunciare alle appartenenze nazionali, tipiche invece dei conflitti.
Non parlare di guerra può aiutare ad acquisire una abitudine mentale nuova, cosmopolita, che abbandoni le divisioni, consustanziali al vocabolario dei conflitti, e sappia ragionare in forme unitarie. Sul terreno sanitario, come su quello sociale ed economico.
Il distanziamento sociale, ora necessario, è un ossimoro. Non ci può essere socialità nel distanziamento, termine ben diverso dalla distanza. La distanza può indicare una dimensione, uno stato d’animo, una lontananza fisica che può persino avvicinare per la sua intensità. In questo senso, la distanza può significare un coinvolgimento sociale forte; le comunità degli emigrati, la diaspora di un popolo. Il distanziamento è una pratica da osservare con fredda e accurata scientificità, è la distanza fisica da un pericolo, è un comportamento ossessivo nella misura in cui risulta salvifico e, dunque, rifugge ogni socialità. Il distanziamento induce la diffidenza, la paura, il distacco misurato persino in metri. Appare quindi la negazione della storia che si è costruita sulla vicinanza, sul contatto fisico, sulla forza accaldata e trepidante delle masse, delle folle, delle piazze.
Se il distanziamento diventerà non uno stato di eccezionalità ma la regola comune per lungo tempo, allora dovranno essere ripensate molte delle categorie, in primis, della politica. Non si tratterà infatti solo di sostituire, come già largamente avvenuto, le piazze reali con quelle virtuali, i dibattiti nei circoli, nei teatri, negli spazi aperti e chiusi con le discussioni in rete, da cui discende una destrutturazione dello stesso linguaggio della politica. La regola del distanziamento sociale potrebbe diventare la forma mentis della politica, ancora più diffidente, ancora più impaurita, ancora più bisognosa di certezze apodittiche, di norme ferree, quasi in un costante regime di quarantena sanitaria appunto.
La democrazia fatica a sopravvivere con il distanziamento sociale perché non può misurare a quanti metri tenere la libertà, né può accettare condizioni differenti a seconda del rischio che grava su ogni singolo individuo. La democrazia e il suo sistema di relazioni non possono essere surrogate soltanto dalle immagini e dalla comunicazione online perché hanno bisogno della forza propulsiva della piazza come spazio fisico, della spinta trainante delle grandi manifestazioni, delle aule affollate e delle campagne condotte in strada. La natura virtuale di alcuni strumenti della democrazia può essere una scelta per migliorare la rappresentanza ma non può certo costituirne la sola sostanza perché ogni altra forma è diventata pericolosa. Il distanziamento sociale è, dunque, inevitabilmente un ossimoro.
Concludo con le resistenze tedesche e olandesi alle ipotesi di interventi europei per evitare che la crisi sanitaria diventi un disastro sociale, decisamente incomprensibili e, per molti versi, irritanti. Non ha senso però rievocare la questione dei debiti di guerra non pagati perché è anche per tale questione che è stato difficile creare un’idea reale e condivisa di Europa. Come scrissero in molti, infatti, l’Europa è morta tre volte a Parigi. Una prima volta, al termine della guerra franco-prussiana, quando nel salone degli specchi della reggia di Versailles, Guglielmo I si autoproclamava imperatore di Germania e imponeva ai francesi l’umiliazione di sacrifici territoriali ed economici colossali. Una seconda volta, dopo la prima guerra mondiale, quando la scelta del primo ministro Clemenceau, accecato dalla rabbia revanscista, è stata quella di imporre alla Germania una insostenibile indennità di guerra, ritenendo il popolo tedesco responsabile delle colpe di Guglielmo II. Il trattato di Versailles ha così umiliato un’intera collettività e ha alimentato il fuoco del più feroce nazionalismo, acceso dall’onere di pagare 132 miliardi di marchi oro ai vincitori. Di nuovo, nel 1947, sempre Parigi, al termine della seconda guerra mondiale, i conti con le responsabilità del conflitto sono stati regolati, ancora una volta, con la definizione di pesanti spese di guerra, destinate a colpire una Germania in ginocchio e un’Italia a cui non veniva riconosciuta l’azione rigenerante della Resistenza. Certo, poi, quei debiti sono stati in larga parte cancellati, ma non sono state cancellate le ferite che proprio le indennità di guerra hanno prodotto. Ora più che mai abbiamo bisogno dell’Europa, ma il modo migliore per rafforzarla non è quello della macabra contabilità del dare-avere della storia.
Università di Pisa
© riproduzione riservata