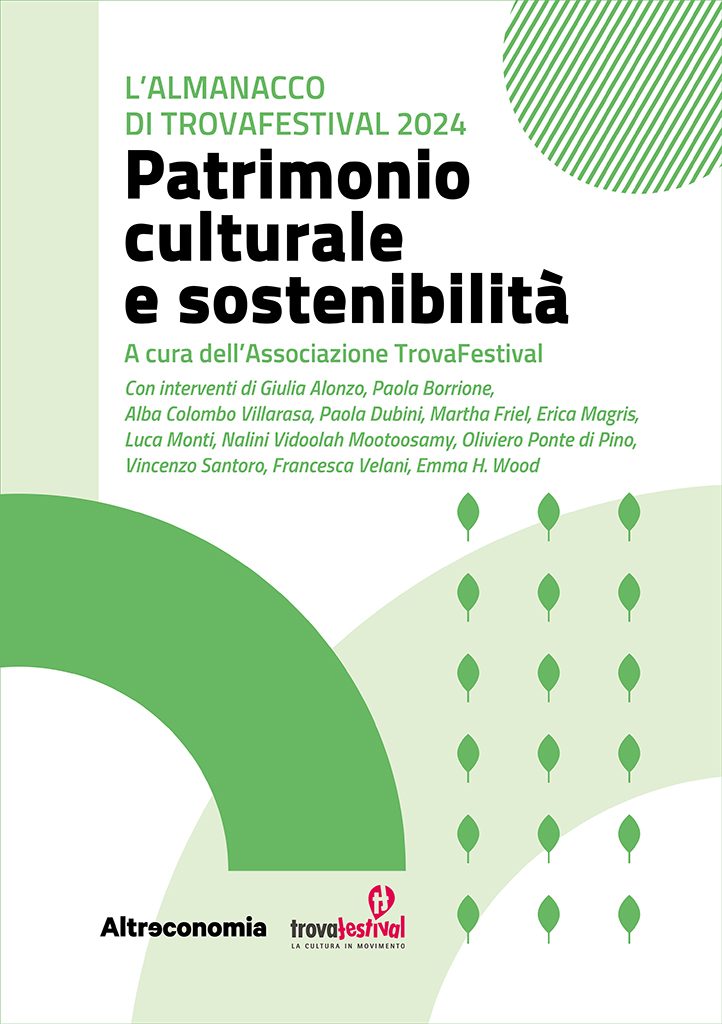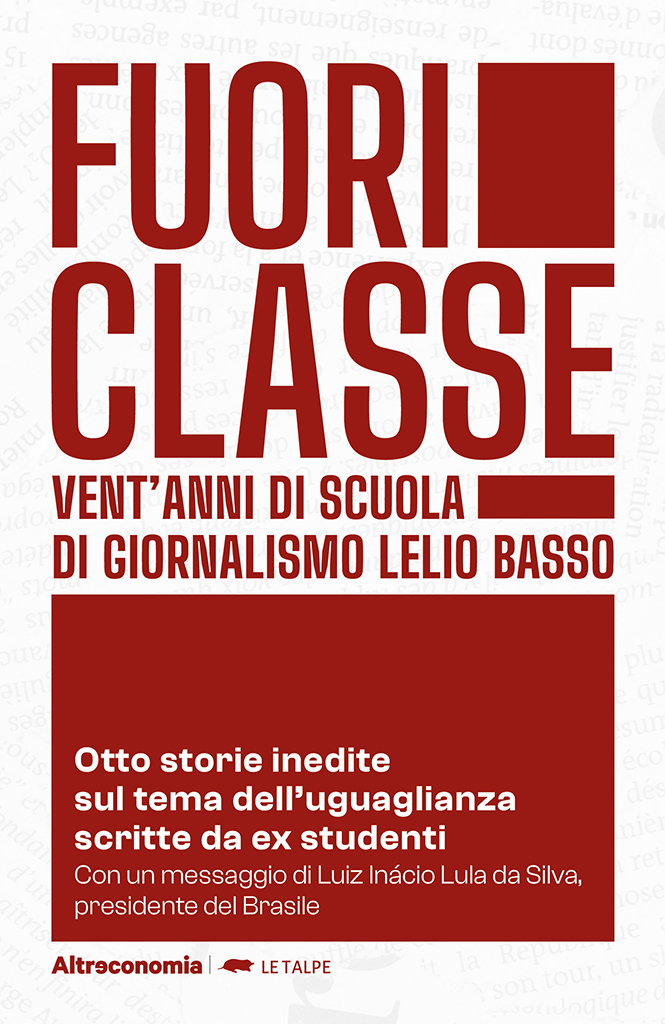Cultura e scienza / Intervista
Daniele Mencarelli. Il bisogno di una “salvezza” sociale

Con i suoi romanzi l’autore racconta i limiti di una società in cui si confonde la “malattia” con il naturale disagio umano e mentale. I servizi psichiatrici non possono essere il “paracadute” che soccorre chi viene scartato dal sistema
Intorno al Duemila un impiegato dei servizi di pulizia dell’ospedale Bambino Gesù di Roma, uno degli ospedali pediatrici pubblici più importanti e grandi d’Italia ma di proprietà del Vaticano, ottenne un appuntamento con il direttore generale per chiedergli di pubblicare una raccolta di poesie da lui scritta e dedicata all’ospedale, ai suoi lavoratori e ai suoi ospiti, i bambini e le bambine spesso affetti da malattie gravissime che morivano prematuramente nelle sue camere e sale operatorie. Un anno dopo la Tipografia vaticana dava alle stampe “Bambino Gesù, ospedale pediatrico” l’esordio poetico di Daniele Mencarelli (poi ripubblicato da Nottetempo nel 2010).
Sono passati vent’anni e oggi Mencarelli è uno degli scrittori più interessanti e apprezzati del nostro panorama letterario. Dopo diverse silloge di poesia, ha scritto tre romanzi tutti per Mondadori: nel 2018 sulla sua esperienza nell’ospedale pediatrico, “La casa degli sguardi”, nel 2020 “Tutto chiede salvezza” e nel 2021 “Sempre tornare”. Con “Tutto chiede salvezza”, premio Strega giovani, Mencarelli rievoca un Trattamento sanitario obbligatorio (Tso) da lui subito nell’estate del 1994 quando aveva vent’anni: una settimana di permanenza obbligatoria in una struttura dei Servizi psichiatrici di diagnosi e cura (Spdc), insieme ad altri pazienti e agli operatori, infermieri e medici psichiatrici. Nel 2022 dal libro è stata tratta una serie tv diretta da Francesco Bruni e prodotta da Netflix (nel cast i giovani Federico Cesari e Fotinì Peluso, nonché Filippo Nigro, Ricky Memphis, Andrea Pennacchi, Vincenzo Crea e Carolina Crescentini) in sette puntate, ognuna dedicata a un giorno della settimana del Tso. Daniele Mencarelli, nato a Roma nel 1974 ma originario dei Castelli romani, è uno dei pochi autori dichiaratamente proletari del nostro panorama letterario e si è distinto come una voce particolarmente originale nel racconto della realtà a partire da esperienze vissute, sia per la produzione poetica sia per quella narrativa. In occasione dell’uscita della serie ha risposto ad alcune domande.
Come è avvenuto l’incontro della serialità?
DM Vengo da vent’anni di lavoro in tv: come accade a tanti scrittori italiani, la Rai è un luogo che, nel bene e nel male, permette a chi fa l’autore di sopravvivere scrivendo. Per tutti questi anni mi sono occupato di prodotti seriali e mai avrei pensato che un mio libro finisse col diventare una serie. Avevo anche aspirazioni cinematografiche -un produttore mi aveva chiesto i diritti del libro per farne un film- invece nel giro di un mese, perché è avvenuto tutto con una tempistica che dire fulminea è dire poco, il regista Francesco Bruni si è innamorato del libro ed è scattata tra me e lui una scintilla. Ci siamo detti: “Proviamo a farne una serie”. E subito dopo: “Proviamo a fare di ogni giorno un episodio”. Da quel momento in avanti è scattata un’affinità ed è scivolato via tutto liscio come l’olio, in un tempo ridicolmente breve rispetto alle produzioni classiche. In pochi mesi abbiamo messo in piedi -come scrittura insieme agli sceneggiatori Francesco Cenni e Daniela Gambaro; per la location, la preparazione e il cast con Bruni e la sua squadra- la serie di “Tutto chiede salvezza”. Si è creato questo clima così armonico forse proprio per il tema trattato: perché ormai nelle nostre famiglie, nei gruppi dei nostri amici, ognuno di noi ha a che fare con il disagio mentale. Era importante raccontarlo seriamente e si è creato buon feeling anche con il protagonista, l’attore Federico Cesari, che è diventato Daniele, il mio alter ego.

Prima della legge Basaglia, che è del 1978, la malattia mentale era una cosa di cui non bisognava parlare. Il tuo libro ha il merito di sdoganare temi ormai molto comuni con una umanità che ha contraddistinto anche i tuoi romanzi precedenti.
DM Questi miei tre libri, che definirei biografici, sono ambientati tutti in quel decennio in cui ho speso buona parte della mia giovinezza, gli anni Novanta. Come accade sempre in letteratura, se si racconta un fatto di un’epoca passata, lo si fa perché quel tema ha un’aderenza al proprio presente. Oggi il tema è ancora più incandescente rispetto ad allora, perché da una parte resistono delle risacche culturali, che ancora vedono la malattia mentale come un tabù. E dall’altra, tema intuito profeticamente da Basaglia, la psichiatria è diventata il paracadute sociale per tanti e tante che non hanno come causa scatenante del loro malessere la patologia psichiatrica. Spesso per questi soggetti la causa è diversa: l’effetto è la patologia, ma le mancanze sono sociali. E questo è un problema che hanno chiaro anche i medici e gli operatori: il consulente scientifico della serie Beppe Dell’Acqua, che ha scritto assieme a Franco Basaglia la legge 180, mi ha detto che oggi la psichiatria cerca di dare risposte a disagi che non sono clinici e di diventare così un grande alibi sociale. Esiste la malattia mentale, ci mancherebbe, ma la psichiatria non può risolvere tutti i problemi che il nostro sistema produce in modo sempre più massiccio. Dopo l’uscita del libro, nel 2020, ho visitato tanti luoghi di cura pubblici e privati, ho collaborato con centri di salute mentale, ho incontrato tanti psicologi e psichiatri perbene che dicono: “Sì curiamo la malattia, ma da noi precipitano tutti quelli che la società rischia di fare fuori”. Questa secondo me è una grande emergenza sociale. In fondo, nel reparto di “Tutto chiede salvezza” convivono sia la malattia mentale riconosciuta, sia quel disagio naturale e più umano che andrebbe intercettato prima. Il grande sogno basagliano era che il secondo fosse educato dalla società.

Il tuo romanzo ha il pregio di saper descrivere in profondità un mondo chiuso come quello istituzionale, che ha una sua intrinseca forza paternalista, perché le persone che ci finiscono subiscono un processo infantilizzante. Che cosa hai capito di questo mondo?
DM Da sempre ho sentito un moto reattivo contro le istituzioni e oggi, da adulto e genitore, continuo ad averlo forse per la mia origine non borghese, di chi si è sempre sentito guardato dall’alto verso il basso. Soprattutto nel corso degli ultimi quattro anni, quelli che ho vissuto da narratore, ho girato di più questi luoghi istituzionali dove a volte incontri chi vive e lavora tentando di mantenere accesa l’umanità e interpretare il ruolo sostitutivo che spesso è necessario in una società dove ci sono delle disuguaglianze. Potrei fare mille esempi. Da tanti centri di salute mentale a Servizi psichiatrici di diagnosi e cura che ho visitato: la loro stessa sopravvivenza è una forma di resistenza. Come il centro diurno “I ponti” al Laurentino 38, quartiere alla periferia di Roma, dove tengo un corso di scrittura con i ragazzi che sono in cura. È un luogo dove ogni giorno entrano educatori, psicologi, infermieri, dirigenti psichiatri che vivificano l’istituzione, la rendono umana. La maggior parte dei luoghi istituzionali, ormai, segue un approccio di tipo economico liberista, per cui qualsiasi scelta deve essere sostenibile con una quantità di denaro in costante diminuzione. Un medico o uno psichiatra dotato di tutti i mezzi umani, clinici e formali che entra a trent’anni in un Spdc e che mette tutte le sue forze, la buona volontà, lo spirito per fare bene il suo lavoro dopo 15 anni finisce le energie, come un soldato in guerra, esaurisce le risorse empatiche e la capacità di riconoscere l’umano che ha di fronte. L’istituzione è un luogo che deve permettere a chi la vive di mantenersi umano.
Per quanto mi riguarda ho vissuto l’istituzione medica da vicino, ma ho conosciuto anche quella della giustizia: per il quotidiano Domani ho scritto un reportage raccontando di un carcere di massima sicurezza a Reggio Calabria. La prima cosa che ha fatto il governo Meloni è stato inasprire ancora di più l’ergastolo ostativo, con un decreto legge che prevede sconti di pena solo dopo trent’anni di detenzione, ossia il fine pena mai, una pena che la Corte europea per i diritti dell’uomo e i costituzionalisti italiani hanno già denunciato come profondamente disumana e anticostituzionale. Chi ho incontrato nel carcere calabrese mi ha detto che molti sentono il doppio ricatto, soprattutto nei confronti delle proprie famiglie, dallo Stato e dalle organizzazioni criminali, se dovessero collaborare con la giustizia.
Una versione estesa dell’intervista è disponibile sul blog Kobo
© riproduzione riservata