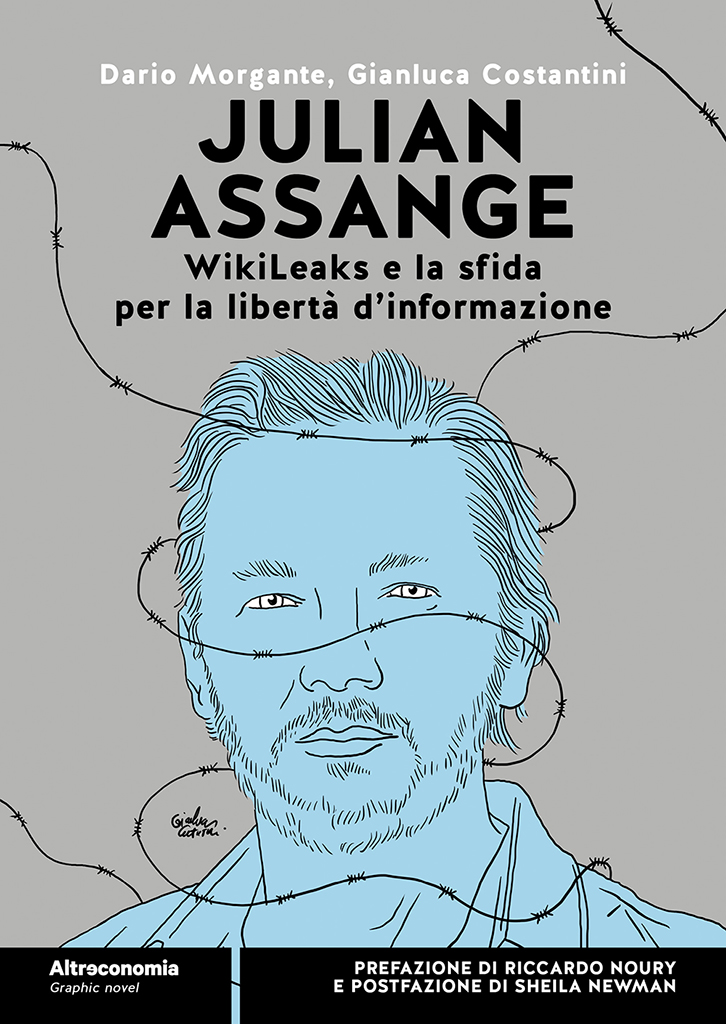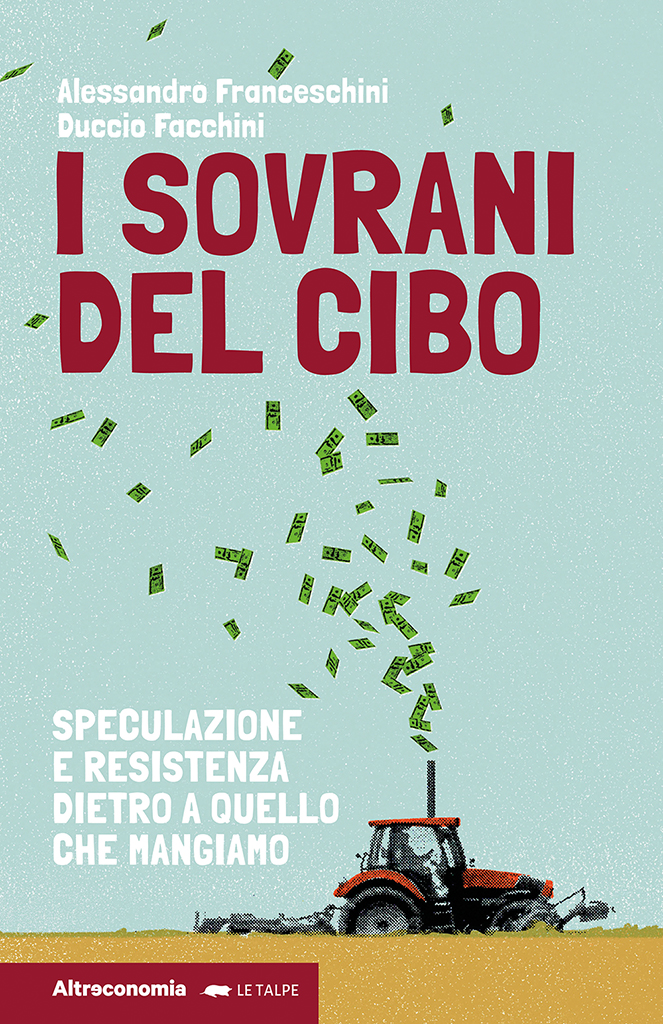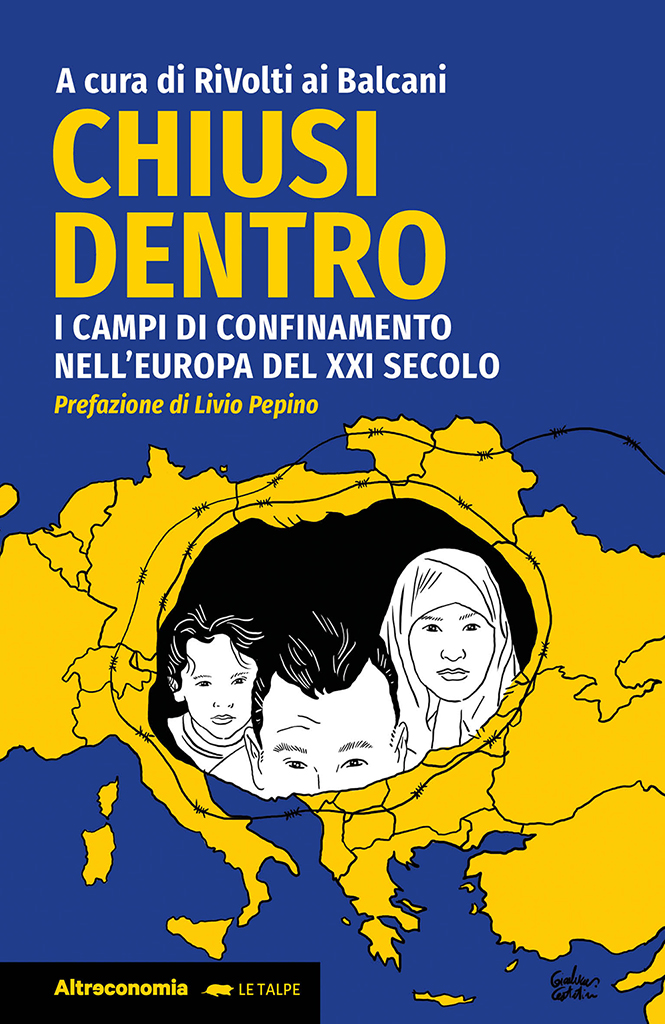Diritti / Inchiesta
Così il profit si sta prendendo il mondo della cooperazione sociale

A dieci anni da “Mafia capitale”, il Terzo settore si ritrova sotto attacco. I grandi soggetti si fanno sempre più strada nei servizi socioassistenziali, agevolati da appalti che mettono al primo posto il risparmio. La nostra inchiesta
Dieci anni dopo la vicenda di “Mafia capitale” il Terzo settore si trova nuovamente sotto assedio. Ma oggi l’attacco è più silenzioso e “interno” al mondo stesso della cooperazione sociale. Trovano infatti sempre più spazio “colossi” maggiormente orientati sulla dimensione economica e molto meno al valore dell’intervento sociale che realizzano. “Lo Stato ha dismesso la propria responsabilità sull’esigibilità dei diritti delle persone piegandola alle esigenze del mercato e quindi favorendo determinati soggetti piuttosto che altri”, spiega Andrea Morniroli, socio della cooperativa Dedalus di Napoli, che si occupa di ricerca, progettazione e gestione di servizi a valenza sociale.
Per Morniroli, da oltre trent’anni attivo nel mondo del sociale e co-coordinatore del Forum diseguaglianze e diversità, uno dei problemi è che spesso le politiche pubbliche non premiano i soggetti del Terzo settore e in particolare le cooperative, che provano a tenere in equilibrio le esigenze dell’essere impresa con il senso del loro intervento sociale. Spesso il pubblico vede gli attori sociali come meri gestori di politiche e non come soggetti con cui condividere la programmazione, in un contesto in cui il primo processo di dismissione è stato quello culturale.
“L’idea di cura dei più fragili agita in termini inclusivi e all’interno delle comunità viene smantellata in tre direzioni -riprende Morniroli-. Si contengono le persone, senza innescare processi di emancipazione; viene ‘messa in produzione’ la sofferenza alimentando il mercato privato e scaricando sulla famiglia, quindi sulle donne, buona parte dei compiti di cura. Il tutto puntando su bandi calati dall’alto, spesso per brevi periodi, in cui l’obiettivo è abbassare il costo degli interventi, con buona pace del loro senso politico e culturale”.
Quella dei servizi socioassistenziali è una fetta di mercato importante. In totale, secondo i dati elaborati da Altreconomia disponibili sul portale dell’Autorità nazionale anticorruzione (Anac) dal primo gennaio al 12 settembre 2024 la base d’asta degli appalti relativi a servizi socioassistenziali è stata di 14,4 miliardi di euro messi a bando attraverso più di 11.400 gare, il 70% delle quali assegnate in affidamento diretto: la modalità più “snella” di tutte per aggiudicare i servizi che però è anche la meno trasparente.

Secondo la banca dati dell’Autorità nazionale anticorruzione (Anac) dal primo gennaio al 12 settembre 2024 gli appalti pubblici relativi a settori affini al sociale sono stati 12.427 messi a bando da 3.119 diverse stazioni appaltanti. Sono quasi cinquemila gli enti che hanno preso parte alle gare (4.979) il cui valore totale (base d’asta) è di 14,7 miliardi di euro. Il numero di procedure più alto si registra a Roma (878) seguita da Palermo (393) e Napoli (345). L’estrazione dalla banca dati è stata fatta per il “codice Cpv” che identifica ogni appalto rispetto al suo oggetto. Abbiamo isolato quelli riferiti all’assistenza socio-sanitaria: si va dall’assistenza domiciliare per alunni con disabilità alle comunità per minori non accompagnati e a persone con gravi disabilità fino alle attività per vittime di violenza di genere. Il dato potrebbe essere al ribasso perché non tutte le amministrazioni registrano istantaneamente le gare o potrebbero esserci errori di classificazione da parte delle stazioni appaltanti. Fonte: elaborazione Altreconomia su dati Anac
Le dinamiche fin qui descritte si osservano soprattutto in alcuni settori di intervento: l’accoglienza dei richiedenti asilo, i servizi relativi alla residenzialità psichiatrica e gli interventi sulla marginalità sociale, come ad esempio per i senza dimora, diventano campo fertile per chi ha maggior capacità di spesa e può garantire all’amministrazione, sulla carta, un maggior risparmio. Andiamo a Trieste dove una vicenda aiuta a capire meglio questo meccanismo. La gestione da circa un milione di euro del centro d’accoglienza “Casa Malala”, ex caserma militare che oggi versa in condizioni fatiscenti con muffa e infiltrazioni d’acqua, nel marzo 2024 è stata assegnata dalla prefettura di Trieste alla Nova Facility Srl, che ha proposto un ribasso del 18% sui costi del capitolato ministeriale, già drasticamente bassi.
18% è il ribasso sui costi del capitolato ministeriale con cui la Nova Facility Srl si è aggiudicata il bando da oltre un milione di euro per la gestione del centro d’accoglienza per richiedenti asilo “Casa Malala” di Trieste
L’Ics (Consorzio italiano di solidarietà) ha impugnato a metà maggio al Tribunale amministrativo regionale (Tar) questa decisione contestando che, in questo modo, i costi per l’erogazione dei servizi, specie per alcuni di essi come la mensa (meno 40%), non sarebbero sostenibili per garantire una qualità minima. Non solo. Con quell’offerta la Nova Facility registrerebbe addirittura una perdita economica di circa 200mila euro rispetto al costo medio stimato dal capitolato. Al di là della disputa legale -Nova Facility contesta infatti tale ricostruzione dei costi- è però utile capire chi è il nuovo gestore di Casa Malala e come possa proporre un ribasso così elevato nella gara d’appalto.
“Aumentano i soggetti che hanno una dimensione sbilanciata sull’aspetto imprenditoriale, a discapito di una visione politica sulle disuguaglianze” – Paolo Felice
Nata nel 2003 con il nome di Nova Marghera Facility Srl è stata controllata dal 2007 alla fine del 2011 dal Gruppo Guaraldo Spa, una delle realtà imprenditoriali più importanti in Italia nel settore immobiliare e delle costruzioni (nata nel 1945) che ha dichiarato il fallimento nel maggio 2018. Il “passaggio” dai mattoni ai migranti arriva nel luglio 2015: prima con l’offerta alla prefettura di Treviso di dare in affitto alcuni appartamenti di un complesso di proprietà, poi anche con la gestione dei servizi di accoglienza. Il 28 ottobre 2015 arriva il primo appalto vinto per i 450 posti dell’ex Caserma Serena (ancora oggi in capo alla Nova Facility) a cui ne seguono ben 56 in quattro anni per un totale di 46,6 milioni di euro. Da parte della stessa prefettura (Treviso) e dello stesso responsabile unico del procedimento. Ma Nova Facility è pronta a quel punto a superare i confini veneti. Ad esempio, nel gennaio 2020, quando si aggiudica la gara della prefettura di Agrigento per l’hotspot di Lampedusa, oppure più recentemente a Bologna dove gestisce i grandi centri d’accoglienza sorti a Ozzano dell’Emilia (ex caserma “Gamberini”) e l’hub da 400 posti nell’ex caserma “Mattei” (in questo caso con il Consorzio di cooperative L’Arcolaio).
La Nova Facility di Gian Lorenzo Marinese, figlio di Lorenzo scomparso a maggio 2024 e tra coloro che salvarono il Venezia Calcio dal fallimento nel 2007, non ha però lasciato i vecchi ambiti di intervento. Continua a lavorare per interventi di manutenzione per la Fondazione Biennale di Venezia di cui dal maggio 2024 è presidente il fratello (Vincenzo Marinese, vicepresidente di Confindustria Venezia) ma soprattutto lo fa attraverso le sue società collegate. La Nova Facility (nove milioni di fatturato nel 2023) infatti è attiva nel settore dell’energia (attraverso la Vega energie Srl che gestisce i servizi energetici dell’omonimo Parco scientifico di Venezia) e in quello immobiliare (attraverso la C.M. Srl e la L.R.M. Srl che si occupano di strutture alberghiere e locazione di immobili).
“Aumentano sempre di più i soggetti che hanno una dimensione sbilanciata sull’aspetto imprenditoriale, a discapito di una visione politica sulle disuguaglianze e sulle crescenti marginalità sociali -spiega Paolo Felice, presidente di Legacoopsociali Friuli-Venezia Giulia-. E il profit guarda con interesse anche a case di riposo e servizi per anziani, su cui la possibilità di fare margine è molto elevata”. In un contesto in cui, secondo il nuovo decreto concorrenza approvato lo scorso luglio, anche questi servizi dovranno essere messi a bando entro il 31 dicembre 2024 dagli enti pubblici.

Un’altra vicenda fotografa come “sanità” e “immigrazione” possono convivere molto bene insieme. Si tratta della Cooperativa sociale Sanitalia, con sede a Torino, che dal 2013 al 2022 ha visto passare il suo volume d’affari da poco più di 27mila euro a oltre dieci milioni. Il core business è quello della psichiatria e degli anziani ma a partire dal 2016 la cooperativa ha cominciato a occuparsi anche di migranti. Lo ha fatto prendendo in gestione alcuni Centri d’accoglienza per richiedenti asilo in provincia di Torino. Anche ad Asti, dove l’offerta presentata alla prefettura era economicamente imbattibile: strutture, personale, ottima capacità organizzativa di spesa. Un piccolo terremoto, a livello locale, nei confronti di piccole e medie cooperative impegnate nell’accoglienza delle persone straniere. Tra cui Piam Onlus (piamonlus.org).
“Non è una questione di qualità dei servizi. Finite le opportunità economiche, chi non è radicato nel territorio lo lascia e ne cerca un altro” – Alberto Mossino
“Non è una questione di qualità dei servizi offerti ma di volontà o meno di collaborazione e coordinamento su un tema così delicato -spiega il presidente Alberto Mossino-. E soprattutto di quello che lasci quando te ne vai: perché è così, finite le opportunità economiche, chi non è radicato nel territorio lo lascia e ne cerca un altro”. E la cooperativa Sanitalia sembra già averne individuati altri buttandosi sulla detenzione amministrativa. La compagine guidata da Simone Fabiano, che a Torino gestisce tra gli altri la “Clinica della memoria”, un centro all’avanguardia per malati di Alzheimer, a metà settembre era in gara per la gestione del Centro di permanenza per il rimpatrio (Cpr) di Torino e Milano (poi aggiudicato alla cooperativa Ekene) ma soprattutto, qualche mese prima, era pronta a fare il grande salto.
Risulta infatti tra le trenta (c’era anche la Nova Facility Srl) che hanno partecipato alla gara da oltre 133 milioni di euro per la gestione dei centri per migranti di Gjadër e Shëngjin in Albania voluti dal Governo Meloni. Il 40% dei trenta partecipanti all’appalto aveva nella denominazione la dicitura “cooperativa sociale” o “consorzio di cooperative”. Procedure che per Giovanni Teneggi di Confcooperative Terre d’Emilia sono incompatibili con l’agire di una cooperativa sociale. “Perché queste hanno il preciso scopo di perseguire l’interesse generale della comunità alla promozione umana e all’integrazione sociale dei cittadini. Il modello Albania è agli antipodi di tutto questo”.
Il 40% dei trenta soggetti che si sono proposti per la gestione dei centri per migranti di Gjadër e Shëngjin in Albania che recava la dicitura di “cooperativa sociale” o “consorzio di cooperative” nella denominazione sociale
Ad aggiudicarsi la commessa è stata la Cooperativa sociale Medihospes che in estate ha aperto ben 379 posizioni per i centri albanesi. Lavoratori e lavoratrici che si aggiungono ai 3.946 dipendenti medi del 2023 (+14% rispetto al 2022) che in tutta Italia gestiscono un portfolio di attività molto diversificato. Dei 160 milioni di fatturato del 2023, la voce asilo e immigrazione pesa per il 47% (75 milioni di euro) seguita dall’assistenza alla persona (44%) e dalla voce “emergenza e marginalità sociali” (7%). Medihospes ha registrato negli ultimi dieci anni una crescita impressionante.

Sono 22,7 i miliardi di euro del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) destinati ad attività che coinvolgono il Terzo settore
Secondo i dati dell’Anac, dal 2014 ai primi sei mesi del 2024 si è aggiudicata un totale di 406 procedure con una base d’asta pari a 1,2 miliardi di euro, passando da due stazioni appaltanti di dieci anni fa alle 33 odierne in tutta Italia. La Cooperativa di lavoro La Cascina (nel 2015 sotto amministrazione giudiziaria per un anno per il suo coinvolgimento in “Mafia capitale”) e il colosso della ristorazione Vivenda Spa (260 milioni di fatturato nel 2023) hanno legami societari con Medihospes che vanta così una solidità economica che le permette di battere la concorrenza degli avversari nelle gare d’appalto. Nel bilancio 2023 la cooperativa prevede ricavi pari a 170 milioni per il 2024, con uno sviluppo consolidato anche grazie alle azioni del Pnrr. Secondo le stime del Forum del Terzo settore e Openpolis, il Piano prevede infatti almeno 22,7 miliardi di euro impegnati in attività che coinvolgono il Terzo settore.
La solidità economica di un soggetto diventa decisiva in un contesto in cui il rapporto con gli enti del Terzo settore e con gli istituti bancari è molto complesso. Come raccontato suAe 272 dal 2012 al gennaio 2024 al non profit (composto da associazioni, fondazioni, comitati e altri enti) sono mancati 3,2 miliardi di euro di credito, un crollo del 31%. Da questo conteggio sono escluse le cooperative. “Non esistono dati quantitativi consolidati”, spiega Valentina Moiso, autrice di un capitolo dedicato al tema nel volume “L’assedio del sociale. Il Terzo settore tra criminalità, mercato e politica” (Mimesis edizioni).
Per la ricercatrice dell’Università di Torino uno dei problemi è che nel momento in cui la cooperativa entra in relazione con l’istituto bancario si trasforma in un ibrido: da una parte è un soggetto che viene considerato in base ai suoi obiettivi di impatto sociale, ma al tempo stesso una serie di dati contabili lo trasformano in un profilo telematico, lo stesso che caratterizza le imprese. “Questo fa sì che la banca rischia di non leggere adeguatamente il soggetto che si trova davanti proponendogli o negandogli interventi che lo rendono ancora più vulnerabile”.
“La macchina ci porta alla destinazione che le indichiamo: il risparmio o la finalità sociale diventa una questione di volontà”- Luciano Gallo
Limitate nell’accesso al credito da un lato, affaticate dai ritardi costanti dei pagamenti dall’altro, le piccole-medie realtà rischiano così di soffocare. Anche a causa di gare pubbliche che riducono sempre di più gli aspetti qualitativi delle proposte progettuali a favore dei requisiti economici. Su questo aspetto, però, le amministrazioni hanno delle responsabilità. “Il nuovo codice dei contratti del 2023 ribalta la prospettiva: la legalità diventa una pre-condizione e il principio ultimo è il risultato da raggiungere”, spiega l’avvocato Luciano Gallo, esperto di rapporti fra Pa e Terzo settore. Una novità importante è la possibilità di scegliere la via della co-progettazione che sulla carta dà la possibilità agli enti di partecipare anche alla programmazione degli interventi. “La via che si sceglie, coprogettazione o appalto classico e soprattutto il fine che si predilige fanno la differenza. La macchina ci porta alla destinazione che le indichiamo: il risparmio o la finalità sociale diventa una questione di volontà”.
© Riproduzione riservata