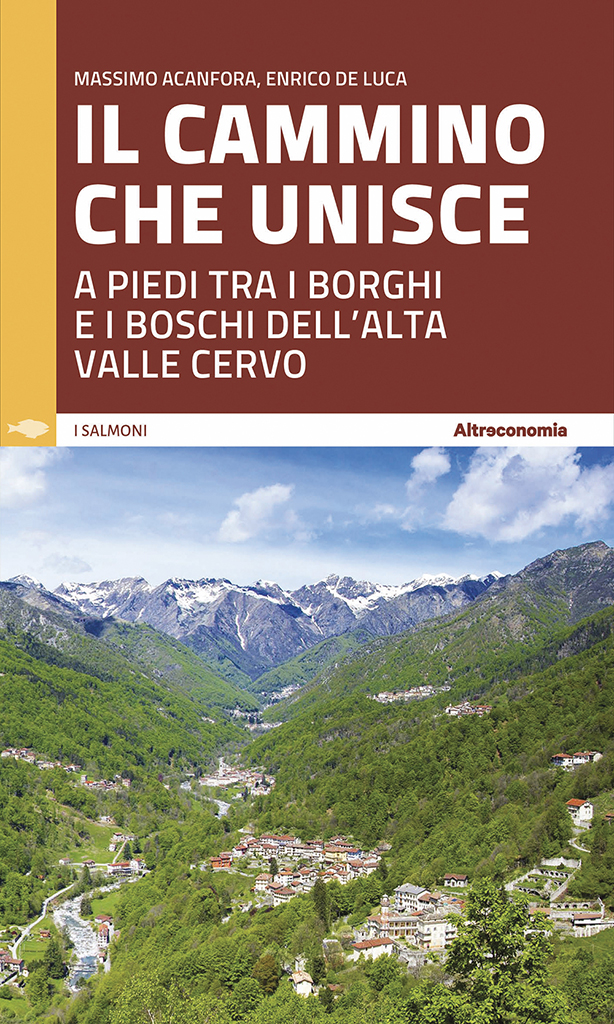Cultura e scienza / Intervista
“Fashion victims”, sul palco c’è l’insostenibile realtà della moda fuori misura

Al Teatro del Buratto di Milano è andata in scena la produzione scritta dal regista e attore Davide del Grosso. Con Marta Mungo, in sessanta minuti, mostra agli spettatori, specialmente delle scuole, un Occidente bulimico e un altro pezzo di Pianeta in cui ogni risorsa, compresa quella umana, viene sfruttata fino a esaurirsi. Ruota intorno a una giornata chiave, il 24 aprile del 2013, la strage del Rana Plaza
Quest’anno il Teatro del Buratto di Milano ha ospitato uno spettacolo che mostra uno spaccato sulla quotidianità di due ragazzi, ma a fare da sfondo c’è una giornata particolare. All’inizio della messa in scena viene subito svelato il tempo in cui si svolge l’azione che verrà mostrata allo spettatore, si tratta del 24 aprile del 2013. Una data che richiama a un evento tragico, ma che non è per tutti così familiare.
Quel giorno in Bangladesh, a Savar, un distretto della capitale del Paese, Dacca, è crollato il Rana Plaza, un edificio commerciale di otto piani all’interno del quale si trovavano negozi, una banca e una fabbrica tessile. Nello spettacolo la tragedia si consuma solo negli ultimi minuti, in cui vengono pronunciate le parole dei responsabili della fabbrica “tornate a lavorare!”, in risposta all’inquietudine serpeggiante generata dagli avvisi di evacuazione. Quel rifiuto di evacuare la fabbrica, costringendo i lavoratori e le lavoratrici a proseguire con le proprie mansioni, ha causato 1.138 morti e oltre 2.600 feriti e invalidi a vita. Lo spettacolo del resto s’intitola “Fashion Victims. L’insostenibile realtà del fashion“.
Tra questi troviamo una dei personaggi centrali dello spettacolo: Mahima, 14 anni. Viene portata in scena ciò che si immagina possa essere stata la sua giornata di quel 24 aprile, in parallelo a quella di un ragazzo di 16 anni, Marco, che nel frattempo a Milano vive la sua, travagliata da dubbi e insicurezze amplificate da un appuntamento con una coetanea. Li seguiamo nelle loro preparazioni, una per andare al lavoro, l’altro per l’appuntamento, e nel frattempo ci è permesso di capire qual è il loro modo di pensare, a che mondo appartengono e come quel loro far parte di due realtà diverse e distanti, non solo geograficamente, il Nord e il Sud globale, influisca sui loro valori, preoccupazioni e sogni.
Lo spettacolo porta la firma del regista Davide del Grosso, che insieme all’attrice Marta Mungo, è capace di evocare stati d’animo forti e tante riflessioni, con al centro due manichini di pezza, scomposti e ricomposti, che vengono manovrati e manipolati a tempo di musica. Abbiamo intervistato il regista per comprendere la genesi del progetto.
Del Grosso qual è stata l’ispirazione dietro lo sviluppo di “Fashion victims”? Che cosa ti ha spinto ad affrontare il tema dell’insostenibilità dell’industria della fast fashion attraverso il teatro? Che tipo di ricerche hai condotto per prepararti a portare in scena questa tematica?
DdG Devo ringraziare in primo luogo “Trama Plaza” un collettivo che ha per missione quella di divulgare consapevolezza rispetto all’industria tessile attraverso l’uso delle arti, con cui collaboro da quattro anni. Inizialmente mi avevano commissionato sette monologhi da portare in giro per teatri. Io stesso ero un consumatore pigro, ma loro mi hanno fornito dei materiali per sensibilizzarmi, tra questi vorrei citare “La rivoluzione comincia dal tuo armadio” di Luisa Ciuni e Marina Spadafora. Da lì ho proseguito a informarmi e mi si è aperto il pavimento sotto i piedi, leggendo i numeri e i dati che vengono riportati sull’industria fast fashion. È l’emblema di un sistema produttivo consumista e capitalista, chiaramente insostenibile da tutti i punti di vista.
Io scrivo e dirigo in teatro, ma sono anche un insegnante al Comteatro di Corsico (MI) e credo sia fondamentale ascoltare gli adolescenti: verso di loro abbiamo debito più forte, gli insegniamo il consumo cavalcando le loro fragilità, in un momento di costruzione identitaria. È lì che va ad agire quella dinamica di consumo. Perciò si crea un cortocircuito: se la nostra persona fosse un ecosistema sarebbe molto inquinato. Lo spettacolo l’ho creato insieme a Marta Mungo, io ho scritto il testo e lei mi ha aiutato a costruire la messa in scena e devo ringraziare il Teatro del Buratto per avermi dato carta bianca per la sua creazione.
Quali sono gli elementi chiave che hai voluto evidenziare sul palco per far comprendere al pubblico le implicazioni e le conseguenze dell’industria della fast fashion?
DdG Credo che le implicazioni legate all’ambito lavorativo-sociale e l’impatto ambientale siano più semplici da raccontare: visti i dati esplosivi, non è necessario ricamarci molto sopra. Ricordiamo, ad esempio, gli episodi di suicidio nei campi di cotone o del milione e mezzo di morti in India causati dal settore. L’obiettivo è quello di comunicare coraggiosamente quei dati trovando un modo efficace e un contesto narrativo ed emotivo per lo spettatore. Volevo parlare anche dell’impatto che questo sistema ha sugli adolescenti, che si trovano catapultati in una realtà iper-performativa, dove la loro insicurezza viene cavalcata e li fa cadere in un consumismo bulimico. Per me è stato facile prendere dalla mia esperienza, perché nonostante la differenza di età, tutti siamo colpiti da quella narrazione.
Abbiamo deciso di impiegare dei manichini perché erano funzionali a creare un effetto di straniamento: il personaggio è appena fuori di me. Si tratta di un dispositivo drammaturgico che ti permette di entrare nel personaggio quando vuoi, ma anche di osservarlo da fuori. Caterina Berta si è occupata della scenografia e ci ha aiutato a trovare dei manichini che si montavano e smontavano, in aggiunta a dei blocchi rettangolari fatti di abbigliamento di scarto che sono diventati, attraverso le immagini proiettate, dei cartelloni pubblicitari che ci hanno permesso di mostrare i martellanti slogan delle grandi aziende del tessile.
Come hai affrontato la narrazione dei personaggi principali, la ragazza e il ragazzo, per far emergere le loro storie e il loro ruolo?
DdG Marco è stato sicuramente più semplice perché per me c’era un’identificazione maggiore e la mia esperienza di insegnamento a contatto con tanti adolescenti è stata utile. Per quanto riguarda Mahima di dati ce n’erano tanti, ma si tratta di una realtà molto distante, si rischia di santificare la persona facendola diventare un’icona martire. Volevamo invece umanizzarla, avevamo bisogno per questo di dettagli di delicatezza che la rendessero una ragazzina di 14 anni, che deve raccontare delle cose più grandi di sé senza diventare una Giovanna d’Arco. Doveva essere una persona con la sua unicità, ma che condivide la sua esperienza con milioni di persone.
Quali sono state le sfide più significative nel tradurre un argomento così attuale e urgente come l’insostenibilità della fast fashion in uno spettacolo teatrale?
DdG Tutto parte dall’idea di fare uno spettacolo di teatro civile pensato per i ragazzi, per parlare di un disastro industriale affinché venga fruito dalle scuole. È uno spettacolo anticapitalista, ma come tutti gli altri deve essere venduto. Abbiamo aggiunto degli elementi divertenti ma portando sempre avanti una causa sociale e politica. I dibattiti post spettacolo sono molto stimolanti, spesso finiscono per durare più della rappresentazione stessa, con momenti di contestazione, del tipo “come si fa a stare al mondo allora? Con queste dinamiche non ce la facciamo a cambiare i nostri comportamenti” che ho ricevuto da alcuni ragazzi delle scuole. Loro si sentono da soli, non sanno come organizzarsi.
Quali azioni o cambiamenti speravi che lo spettacolo potesse ispirare nel pubblico riguardo alla loro percezione e comportamento nei confronti della moda e del consumo?
DdG Un singolo spettacolo non può di certo cambiare un sistema o le abitudini di consumo di ogni spettatore, ma in senso determinista è una delle cause che può portare al cambiamento. Una delle cose che mi sta a cuore è: prima di comprare, consumare chiedersi sempre “di che cosa ho bisogno davvero in questo momento?”. Prima di saturare quel bisogno, c’è un territorio di ascolto molto interessante da ispezionare. Se il pensiero viene allenato, si può indebolire l’azione consumante. Alla fine, credo che, per quanto sia comunque complesso da mettere in pratica, attraverso degli interrogativi etici e l’allenamento del bisogno, che dovrebbe essere alla base di tutto, si può col tempo uscire dalla logica del consumo sfrenato.
© riproduzione riservata