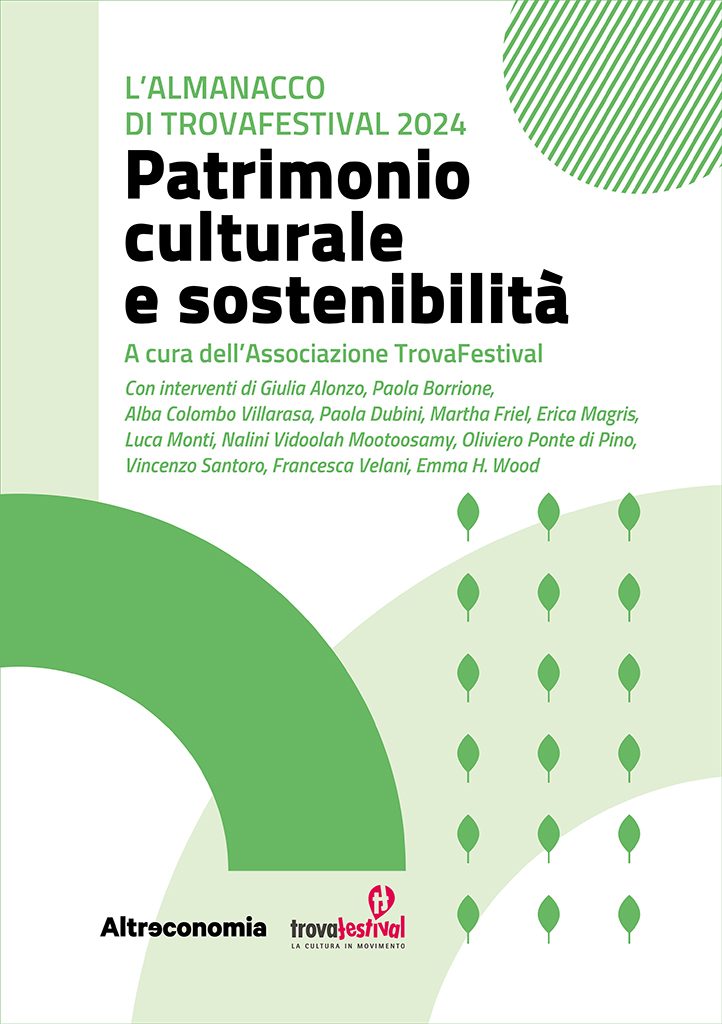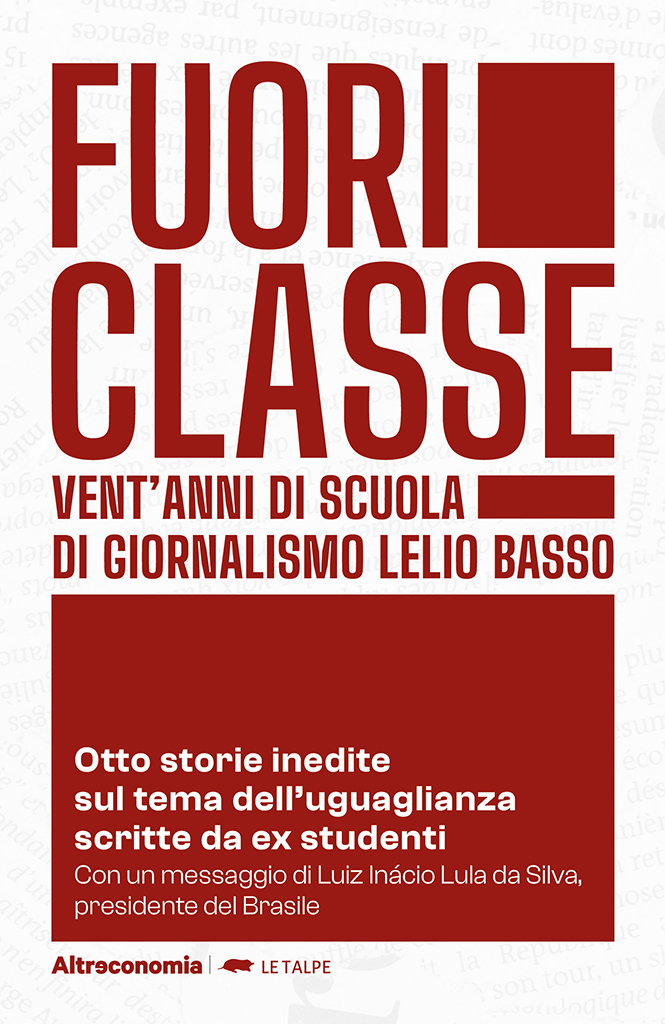Cultura e scienza / Intervista
Mimmo Sorrentino. Il teatro che nasce dall’ascolto

Da trent’anni il regista porta in scena uomini e donne che abitano contesti difficili: dal carcere alle periferie. Mettendo sempre al centro la persona e i suoi bisogni
Più che regista e drammaturgo verrebbe naturale definirlo un “sarto delle relazioni”. Il teatro partecipato di Mimmo Sorrentino ha fatto visita ai luoghi più dimenticati delle nostre città ricostruendo, attraverso gli spettacoli, un senso di comunità e vicinanza. Per rendersene conto basta sfogliare le pagine di “Che tutto sia bene” (Manni, 2021), un viaggio lungo trent’anni che ricostruisce la carriera del regista attraverso le storie dei partecipanti ai suoi gruppi di lavoro: dai detenuti ai vigili del fuoco, dagli adolescenti alle persone extracomunitarie è difficile trovare qualcuno con cui Sorrentino non abbia lavorato. Soprattutto nei contesti sociali difficili, il suo teatro è stato capace di generare cambiamento mettendo al centro la persona e i suoi bisogni più profondi.
Il libro si apre con la storia di Laura. La “principessa della metastasi” che, nonostante un tumore che la debilita, sceglie di continuare a portare in scena lo spettacolo che racconta la sua vita. Perché ha deciso di aprire con questo racconto?
MS Laura ha una storia tragica ma vuole vivere fino all’ultimo respiro. Tutte le persone che incontro, nel momento in cui riescono a esprimersi, alla fine diventano Laura. Ho scelto di cominciare con un racconto dichiaratamente struggente ma allo stesso tempo molto forte perché dimostra quante cose possiamo fare nella nostra vita fino alla fine. Un “voglio vivere” che non è una forma di narcisismo o una mascherata volontà di essere immortale, ma un opporsi alla morte non dopo la vita ma nella vita. Questo è il senso del libro.
Magistrati, vigili del fuoco, detenuti, anziani, collaboratori domestici, rom. Tra le tante storie che ha incontrato, c’è un filo rosso che lega vissuti così diversi tra loro?
MS Loro cambiano, la mia “pratica” no. Quello che mi muove è la continua ricerca della bellezza in questi luoghi: credo di trovarla perché l’armonia che abbiamo nel cuore ha origine nel dolore, nella mancanza. E quindi il filo che lega queste esperienze è la costante ricerca delle persone di una bellezza che non è estetica o dell’anima. Il senso è far vedere loro quanto sono necessarie, quanto possono ancora “dare”. In termini culturali, di esperienza. Faccio l’esempio dell’anziano: ciò che restituisce secondo me non è il suo passato ma il fatto che vuole vivere. Magari non si ricorda come si chiama ma conosce le parole future che vorrà dire.
“Il filo che lega queste esperienze è la costante ricerca delle persone di una bellezza che non è estetica o dell’anima. Il senso è far vedere loro quanto sono necessarie”
Come nascono i suoi spettacoli?
MS Io non vado mai con un testo preconfezionato, il copione nasce sempre dall’ascolto delle persone. Il teatro partecipato funziona così. Si va a vivere in un contesto per studiarne le regole, i costumi, la lingua con l’obiettivo di provare, attraverso l’arte teatrale, a determinare dei cambiamenti. Che cosa vogliamo raccontare, perché e come lo raccontiamo: questi sono i tre passaggi necessari da fare. Per questo motivo i testi sono sempre originali perché raccontano l’esperienza di quel gruppo di persone. Porto l’esempio delle detenute. Ognuna di loro sa più o meno, a grandi linee, la storia dell’altra ma soltanto lavorando insieme si conoscono “davvero”. La tecnica con cui metto in scena lo spettacolo prevede che nessuno racconti la sua storia personale e quindi ognuno deve farsi carico in qualche modo dell’esperienza altrui: il gruppo si riconosce nel lavoro che fa e quando gli attori vanno in scena sentono una forte necessità di raccontarsi. Nelle nostre rappresentazioni è raro vedere elementi di esibizione. L’ascolto dell’altro è il cuore dello spettacolo.

Un “altro” che vive in uno specifico contesto. Lei sottolinea come i suoi attori “andranno davvero in scena, se il pubblico si dimenticherà della loro condizione”. In che senso?
MS Se porto gli spettacoli degli anziani al di fuori della casa di riposo diventano i poveretti. Nel contesto in cui vivono invece è teatro. I cateteri, le flebo diventano parte integrante dello spettacolo, invece lo spettatore vedrebbe solo la carrozzina se esposta su un palco. Per questa ragione i miei spettacoli sono “veramente teatro” nell’ambito dei contesti dove lavoro. E ciò vale per tutti i gruppi perché si trasforma la necessità in arte e questa non ha nessun tipo di barriera. Ovviamente i bisogni sono diversi ma non cambia il voler prendersi degli spazi di libertà nel senso di assumersi la responsabilità della propria esistenza.
Scegliere il “cosa” raccontare ma anche il “come”. Cos’è per lei la parola? Come restituisce in termini di linguaggio quello che ascolta dai partecipanti?
MS Per me la parola è corpo. Ed è l’azione conclusiva che arriva alla fine di tutta un’azione fisica. La parola è la conclusione della recitazione, non la base. Quasi sempre scrivo in una lingua che non è la loro ma sembra la loro. Faccio l’esempio delle detenute. È evidente che non parlano in quel modo ma quel linguaggio è nella loro potenzialità. Quella “lingua” come atto teatrale deve diventare corpo nelle persone che la portano in scena. Ad esempio, sto lavorando su uno spettacolo in cui un’attrice di media-sicurezza recita una vecchia canzone di Gaber. Il testo inizia con “Oh madonnina dei dolori/quanti dolori avete voi/oh madonnina dei dolori/adesso vi racconto i miei” rivolto a un’agente di polizia penitenziaria seduta su una sedia. Quando la detenuta dice questa frase entrambe riconoscono il dolore dell’altra. Si mantiene la specularità che c’è all’interno del carcere perché una è seduta sulla sedia e l’altra per terra ma si guardano negli occhi. La detenuta ha la possibilità di rivolgersi a colei a cui deve chiedere il permesso quotidianamente per fare qualsiasi cosa. Sembra totalmente la sua storia, però è una canzone di Gaber. Durante le prove il copione continuava a non funzionare, poi una mattina ho chiesto all’agente di polizia di salire sul palco, sedersi, guardare negli occhi la detenuta e ascoltarla e la scena ha funzionato subito. Fino a quel momento stavo sbagliando io perché chiedevo qualcosa che per l’attrice non era sostenibile.
In che senso?
MS Sei tu che devi escogitare il modo con cui queste persone, che non sono attori, possano stare sul palco. Non puoi soffocare le loro difficoltà e tirare dritto ma devi riuscire a trasformarle in opportunità di crescita. Se non riescono a farlo evidentemente non hai capito i loro bisogni e non sei neanche utile, per loro, nel percorso di emancipazione. Questo aiuta anche me a non restare ingabbiato in un’ideologia: spesso quando si lavora in questi contesti si è chiusi nel perbenismo, nell’ipocrisia, nei buoni sentimenti.
Chiude il libro con un racconto su uno spettacolo per il 25 aprile nella piazza di Vigevano (PV) che coinvolge quasi 300 persone. Perché ha scelto questo episodio? Pensa che il suo teatro sia politico?
MS Sicuramente. Uno dei motivi per cui ho scelto di concludere con quello spettacolo era di raccontare il senso politico del mio teatro. Eravamo sgangherati ma avevamo la necessità di essere nella città perché sentivamo minacciati i valori del 25 aprile: era il 1994 e al governo c’erano la Lega e Berlusconi. Lo spettacolo è diventata un’azione che ha coinvolto più di 300 persone. Ma attenzione, non fa la differenza: l’impegno, il tuo modo di essere è politico a prescindere dal numero di persone che ti vengono a guardare. Quei cittadini volevano, attraverso l’arte, incidere sul tempo, non solo per le cose che dicevano ma per le relazioni che nella preparazione di quello spettacolo avevano messo in atto. Il mio teatro è politico se con questo termine si intende l’arte della polis. Lo scrive nella prefazione Massimo Recalcati, a cui sono grato. È il teatro della tragedia greca, non per i temi che tratta ma per la prassi che segue, perché è un teatro nella città che genera delle trasformazioni. Se i magistrati di sorveglianza per la prima volta permettono a delle donne in alta sicurezza, che per il loro regime non potrebbero uscire, di spostarsi dal carcere per portare in scena il loro spettacolo è un fatto politico. Perché la cultura diventa necessaria per quel gruppo di persone, anche secondo la legge.
Perché crede sia importante oggi il suo teatro?
MS La cosa positiva accaduta nella fase “post-pandemia” è che in molti luoghi in cui operiamo hanno capito l’importanza del lavoro. Si è capito che non porta beneficio solo all’utenza ma più in generale al contesto. Investire strutturalmente sulle relazioni paga e su questo le istituzioni spesso sono disattente. Questa pandemia ha lasciato molta depressione. Ovunque mi chiedono di ricucire spazi, relazioni, di dare fiducia e mettere le persone in gioco. Il teatro può aiutare a ricucire. Con le parole. E le parole.
© riproduzione riservata