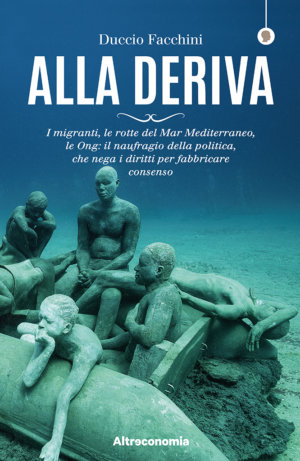Diritti / Attualità
I migranti ridotti in schiavitù nei centri in Libia. La conferma della Corte d’Assise di Agrigento

La sentenza depositata lo scorso 22 giugno dà conto delle condizioni drammatiche del centro di Sabratha e smentisce ancora una volta la finzione del “porto sicuro”. Condannato a 10 anni un membro di un’organizzazione criminale che avrebbe mantenuto “in stato di cattività” decine di persone. Intervista all’avvocato Amarilda Lici (Asgi) che ha assistito le vittime giunte a Lampedusa a metà 2017
“I centri di raccolta dei migranti in Libia sono luoghi di prigionia dove si subiscono trattamenti inumani e degradanti da parte delle organizzazioni criminali che li gestiscono”. Le parole dell’Associazione per gli studi giuridici sull’immigrazione (Asgi) giungono dopo un’importante sentenza del 22 giugno 2019 della Corte d’Assise di Agrigento che ha condannato un cittadino gambiano membro di un’organizzazione criminale che controllava e gestiva il campo di Sabratha. L’imputato -condannato in Italia a dieci anni di reclusione per il reato di riduzione in schiavitù- avrebbe infatti “minacciato, usato violenza, ridotto e mantenuto in uno stato di soggezione continuativa un gruppo di migranti in attesa del viaggio verso l’Italia”. “Tale pronuncia -spiega l’Asgi-, così come la sentenza della Corte d’Assise di Milano del 10 ottobre 2017, conferma una persistente violazione dei diritti umani nei confronti dei migranti in Libia, come di recente ribadito anche dal Consiglio d’Europa che ha raccomandato agli Stati che partecipano ai soccorsi in mare di evitare lo sbarco dei naufraghi nel territorio libico ed in altri luoghi che non possono essere considerati sicuri in base al diritto marittimo e alle normative che tutelano i diritti umani”.
Asgi è stata ammessa come parte civile insieme ad altre quattro persone migranti vittime delle violenze e dei “comportamenti dispotici” dell’imputato, tutte assistite dall’avvocato Amarilda Lici del foro di Napoli.
Avvocato Lici, proviamo a ripercorrere i fatti al centro del procedimento.
AL Una data chiave è il 26 maggio 2017, quando sbarcano a Lampedusa 140 migranti. Una parte di loro, precisamente 34 persone, è collocata in un centro di accoglienza straordinaria in provincia di Napoli. Insieme ai 34 migranti viene trasferito anche l’imputato di questo processo.
Pochi giorni dopo, il 15 giugno 2017, il direttore della struttura si accorge di alcuni atteggiamenti che l’imputato, già nei giorni precedenti e quello stesso giorno, aveva tenuto nei confronti di alcuni dei 34 migranti che già conosceva, avendoci viaggiato insieme dalla Libia. Si trattava di atteggiamenti violenti, “dispotici” scrivono i giudici. E da parte dei migranti c’era anche un certo timore nei confronti dell’interessato.
Oltre al direttore della struttura, la fattispecie viene confermata anche da altri operatori del centro. E alla luce di questi riscontrati atteggiamenti violenti e ripetuti si è deciso di fare una denuncia, anche perché le parti offese non lo avevano solamente riconosciuto come una persona che aveva condiviso il viaggio sullo stesso barcone, ma lo aveva individuato come una persona che faceva parte del gruppo di carcerieri nel campo di Sabratha in Libia, dove erano stati reclusi ancor prima della loro partenza. Si trattava di un membro di un’organizzazione composta da 10-15 persone, tutti uomini armati con fucili e pistole, una decina dei quali di varie nazionalità africane e sei arabi.
Si tratta di un “campo di raccolta”.
AL Un centro recintato che aveva la funzione di trattenere i migranti in attesa del momento di imbarco verso le coste italiane. Ognuna delle 10-15 persone dell’organizzazione aveva una propria mansione affidatagli dai capi del campo. L’imputato era addetto a mantenere l’ordine all’interno del campo in cui i migranti erano collocati in maniera forzata. Questo collaborava con gli altri membri dell’organizzazione, usava violenza, anche tramite armi (era in possesso di una pistola), picchiava le persone anche mediante un tubo metallico, abusava delle donne. Una di queste peraltro è rimasta incinta.
Che vita era quella del campo?
AL Le parti offese hanno dettagliatamente descritto sia le violenze e sia la sensazione di prigionia. Si sentivano segregati all’interno di questo campo. La violenza era perpetrata per qualsiasi motivo. Dal momento della sveglia all’atto di costrizione per uscire dal campo per andare lavorare, fino al momento del loro rientro, per prenderne i soldi con la forza, trattati da mera fonte di profitto. Tutti quanti si sentivano prigionieri in questo campo. Si trattava di un’accertata situazione di schiavitù, i migranti non erano liberi di uscire, non potevano fare altro che affidarsi ai trafficanti e quindi erano costretti a subire limitazioni di libertà, violenze, minacce. Individui vulnerabili tenuti in una soggezione continuativa.
Poi c’è il viaggio in mare verso le coste italiane, nella primavera 2017.
AL L’imputato si imbarca insieme ai migranti stessi. La sua condotta, anche durante la traversata dalla Libia all’Italia, ha messo in serio pericolo la vita dei migranti. Nel suo ruolo di controllore ha fatto lo stesso anche quando i migranti si trovavano sul gommone, intimidendoli, colpendoli con pugni e con una cinghia, minacciandoli di bucare il gommone.

Come è stato descritto il momento del viaggio?
AL Le parti offese sostengono di essere partite dalla Libia con due imbarcazioni, una più grande dove si trovavano in 140 migranti e una più piccola che accompagnava un gruppo di libici e che a un certo punto ha recuperato lo scafista, il quale presumibilmente è tornato in Libia.
Che cosa sappiamo invece dell’imputato?
AL In realtà durante il processo questi non ha dato conto del suo “percorso”. Non ne conosciamo il percorso migratorio. È nota la sua nazionalità ma non da quando e come sia arrivato in Libia o come sia diventato membro dell’organizzazione criminale.
Come si pone questa sentenza rispetto al desolante dibattito che ancora vuole dipingere la Libia quale “porto sicuro”, nonostante da ultimo la strage del centro di detenzione di Tajoura di inizio luglio? Penso anche alla verità processuale affermata da un’altra sentenza, quella della Corte d’Assise di Milano (10 ottobre 2017, confermata in appello il 20 marzo 2019) contro un cittadino somalo, identificato quale aguzzino di un campo di Bani Walid e condannato all’ergastolo.
AL Anche questa sentenza è indubbiamente importante per ribadire ancora una volta come non ci sia alcun dubbio sul fatto che la Libia non possa essere considerato un porto sicuro. Detto questo, e per evitare di dire quanto ormai è già noto rispetto alla Libia, auspico che questa sentenza, così come quella della Corte d’Assise di Milano possano essere lette in profondità, per permettere a tutti di “apprendere” e “incontrare” in prima persona il racconto e purtroppo le tragiche esperienze delle vittime, cosa che ha sicuramente un altro impatto di quanto le stesse vicissitudini possono essere raccontate da noi legali che li difendiamo.
© riproduzione riservata