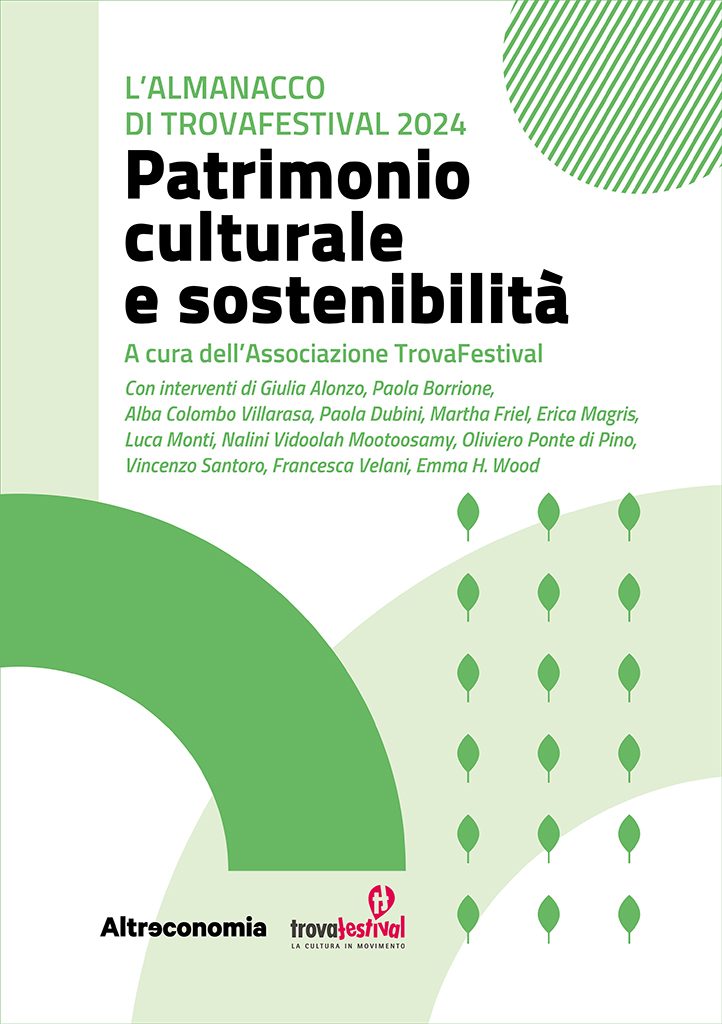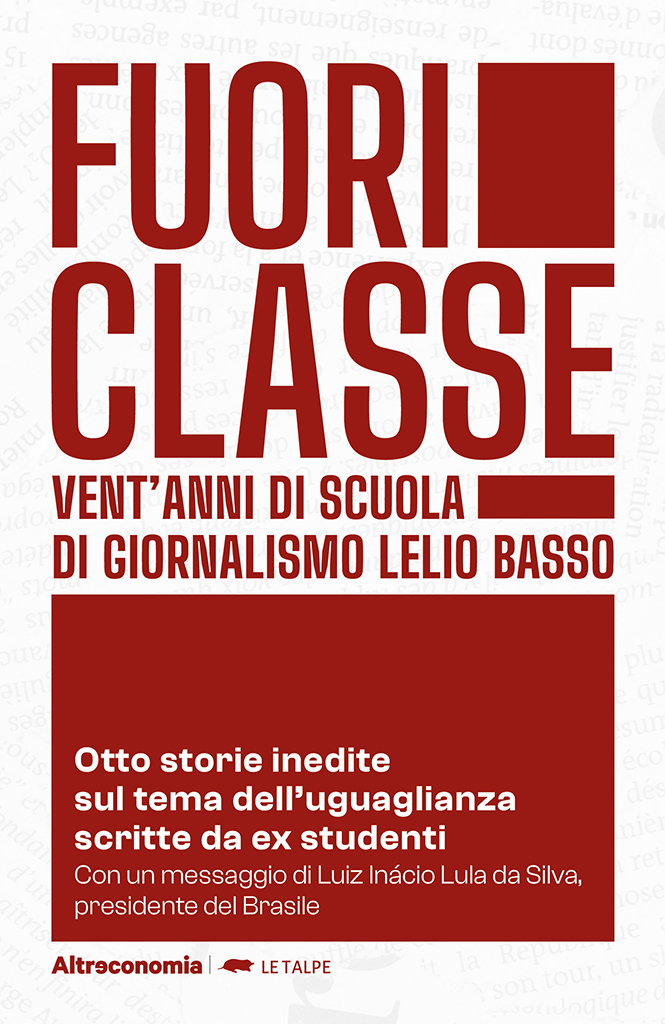Cultura e scienza / Intervista
Mario Martone. “Qualcuno cammina e io lo seguo”

Nei suoi trent’anni di carriera, il regista ha “pedinato” storie, vite, persone, scoprendo e raccontando in sala mondi ricchissimi. Napoli (e “Nostalgia”) ma non solo. Fino al teatro, con una sua interpretazione del “Romeo e Giulietta”
Il pretesto per incontrare il regista Mario Martone è il premio Robert Bresson che ha ricevuto all’ultima Mostra del Cinema di Venezia per il suo film più recente “Nostalgia”, con protagonista Pierfrancesco Favino. Il premio ha il patrocinio del Vaticano tanto che nelle motivazioni è intervenuto il prefetto del Dicastero per la cultura e l’educazione della Santa Sede, il poeta portoghese José Tolentino de Mendonça, con queste parole: “Il cinema di Martone è intessuto di una nostalgia senza passato, stratigrafia di momenti interiori, piuttosto che di tempi storici. […] È il tentativo di suturare una ferita aperta nel corpo della vita con l’ideale della rivoluzione, l’utopia, l’amore terreno, il pubblico riconoscimento, il riscatto sociale”. Il suo prossimo film sarà dedicato all’esperienza carceraria della scrittrice Goliarda Sapienza. In questa intervista Martone ha approfondito alcuni temi del suo ultimo film legati a Napoli e ha ripercorso più di trent’anni di carriera al cinema e al teatro.
Martone, perché in “Nostalgia” ha scelto di adattare al cinema il romanzo postumo di Ermanno Rea?
MM Rea è un autore composito, che coniuga la narrazione con la riflessione sociologica, antropologica e politica. In “Nostalgia” il racconto si svolge interamente nel rione Sanità a Napoli, un contesto estremamente identificato che si presta a una lettura metaforica della nostalgia. Non sono un nostalgico, perché penso che il passato sia un continuum con il presente. La nostalgia è la consapevolezza che, se non possiamo cambiare il passato, possiamo però attraversarlo, come fosse un labirinto. Forse imparare da esso. Nel racconto di Felice Lasco, il protagonista, emerge chiaramente il peso di un grande rimorso, che lo ha spinto a sacrificare la parte originaria della sua vita, fino a trascurare la madre per anni.
Perché dice che il rione Sanità è un quartiere così identificato per Napoli?
MM Il Ponte della Sanità, che fu fatto costruire dai francesi, da Gioacchino Murat, finendo per separare la città dal quartiere, ha in un certo senso segnato la fine o il destino di questa valle. Il suo abbandono e la sua malinconia sono il risultato di questo isolamento. È un’enclave lontana dal golfo, dove il mare è solo un miraggio. Il rione è dominato dalla presenza delle catacombe e degli ipogei, tutto ciò che c’è sotto la superficie. In questo quartiere si percepisce un’umanità intensa e vibrante, non ordinaria. All’interno di questo scenario nel film si stagliano personaggi che sembrano provenire direttamente dalla tragedia greca: Felice, l’amico Oreste, la madre e il sacerdote.
“La nostalgia è la consapevolezza che, se non possiamo cambiare il passato, possiamo attraversarlo come fosse un labirinto. E forse anche imparare da esso”
Quest’ultimo personaggio è ispirato a quello di don Antonio Loffredo, che è ha vissuto vent’anni nel rione. È una figura ancora poco conosciuta, puoi accennare alla sua statura?
MM Sì, quello è un esempio della spinta vitale. L’azione di un sacerdote come don Antonio Loffredo (padre Rega nel film) è stata molto incisiva, senza opporsi o sovrapporsi al quartiere. Tuttavia, ciò che ha attratto particolarmente un autore come Ermanno Rea, comunista e ateo, è stato il suo impulso originale, uno sguardo autentico rivolto agli altri. Si trattava di agire guardando negli occhi, a un livello orizzontale, senza la presunzione di avere tutte le risposte. Alcuni rioni di Napoli possono essere considerati dei purgatori, ma la cooperativa dei ragazzi di padre Loffredo, che organizza visite guidate al tesoro archeologico sotterraneo della città, offre un esempio di come reagire. Queste persone, pur guadagnando uno stipendio modesto, fanno un lavoro che significa molto di più. Sono giovani sottratti a condizioni rischiose a cui viene data l’opportunità di lavorare e vivere dignitosamente. Francesco Di Leva, che interpreta il prete nel film, tra l’altro, nel suo quartiere periferico di San Giovanni a Teduccio, e nel suo teatro che oggi è finalmente legalizzato, il Napoli Est teatro (Nest, compagniateatronest.it), realizza da anni progetti con i ragazzi e le ragazze del quartiere simili a quella di padre Loffredo.

Rispetto agli ultimi suoi tre film, si è parlato di una possibile nuova trilogia napoletana, “Il sindaco del rione Sanità”, “Qui rido io” e “Nostalgia”. Anche se molto diversi tra loro, emergono linee tematiche simili. Il “Sindaco” rappresenta un ritorno alle radici del cinema militante, come “Teatro di guerra”; “Qui rido io” prosegue lo scandaglio ottocentesco iniziato con “Noi credevamo” e “Il giovane favoloso”; mentre “Nostalgia” richiama altri suoi due film, “Morte di un matematico napoletano” e “L’amore molesto”. è d’accordo?
MM C’è un tema ricorrente nei miei film: qualcuno cammina e io lo seguo, quasi indistintamente. Questi personaggi poi si mescolano nella folla e di loro verremo a conoscere progressivamente la storia, è così nel “Matematico”, in “Amore molesto”, in “Nostalgia”, ma ho pedinato anche Leopardi nelle strade di Napoli nel “Giovane favoloso”. Nella stessa strada, a via Foria, iniziano ben due di questi film. E c’è sempre un legame con l’opera precedente. “Il sindaco del rione Sanità” è il film realizzato con Di Leva in cui evoco per la prima volta il quartiere, forse senza quella pellicola “Nostalgia” non sarebbe esistito. Il mio pedinare riguarda anche i racconti storici e i personaggi di un passato lontano. Da ragazzo non avevo alcun interesse per il Risorgimento, mi sembrava di una noia mortale. È stata la scoperta di alcuni personaggi minori, giovani cospiratori, figure che compaiono ai margini dei libri di Storia, che mi ha portato a scoprire un mondo ricchissimo di cui non avevo idea. Ho dedicato molti anni alla realizzazione di “Noi credevamo” perché il film, oltre a essere una ricostruzione storica, è un dialogo con il nostro presente e con il Paese in cui viviamo, politicamente sempre così sofferto, una democrazia malata, incompiuta. Ho affrontato il film come fosse una seduta di psicoanalisi che scavava nel passato per comprendere il presente. È stato un processo illuminante e appassionante.

Il documentario su Massimo Troisi, “Laggiù qualcuno mi ama”, realizzato trent’anni dopo la sua morte, è ricco di intuizioni, come il confronto Troisi-Truffaut. Ma è soprattutto un lavoro personale, un aspetto importante della sua formazione.
MM Non avevo mai realizzato un documentario di questo tipo, ma ho conosciuto Massimo. Purtroppo la nostra amicizia è stata breve, poco dopo lui si è ammalato, durante la lavorazione de “Il postino”. Aleggiava un’idea di lavorare insieme, Massimo sembrava apprezzare la collaborazione con altri registi. Ho condiviso con lui le mie riflessioni sul suo cinema e lui ne era contento. Realizzare questo documentario è stato come fare un film con lui e ho quindi ho dovuto mettermi in gioco personalmente per dare forma al lavoro. A Napoli saremmo tutti diversi senza Massimo Troisi: lui era un detonatore di possibilità creative. E poi mi ha interessato la sua collaborazione con Anna Pavignano, il suo confronto col femminile, un tema a me molto caro.
“Colpisce il fatto che il conflitto tra Capuleti e Montecchi sia insensato: queste due famiglie sono nemiche senza che ci venga fornita una chiara spiegazione del perché”
L’anno scorso ha portato a teatro, al Piccolo di Milano, “Romeo e Giulietta”, che ha suscitato molti apprezzamenti e discussioni soprattutto per il linguaggio e per i rimandi alla guerra che è tornata in Europa e oggi in Medio Oriente. La scelta non era casuale?
MM Ho scelto di rappresentare il dramma mantenendo intatto il testo originale ma ambientandolo su dei rami sospesi nel nulla, una grande scenografia realizzata da Margherita Palli. È una storia d’amore così intensa e universale, resa più coinvolgente dal fatto che si svolge in soli cinque giorni. Colpisce che il conflitto tra Capuleti e Montecchi sia insensato: queste due famiglie sono nemiche, senza che nel testo venga data una chiara spiegazione dell’origine del conflitto. È un conflitto attuale, in atto. Il padre di Giulietta, figura centrale, esercita una violenza verbale che finisce per sembrare fisica. Ho adattato il testo prendendomi molte libertà e ho affidato la traduzione a Chiara Lagani. In passato gli adattamenti italiani hanno attenuato gli eccessi che invece appartengono pienamente al testo di Shakespeare, il pubblico ne resta sconvolto. È stato appassionante lavorare con attori giovanissimi, vedere come si sono relazionati a queste parole in modo libero, al di fuori di ogni schema accademico.
© riproduzione riservata