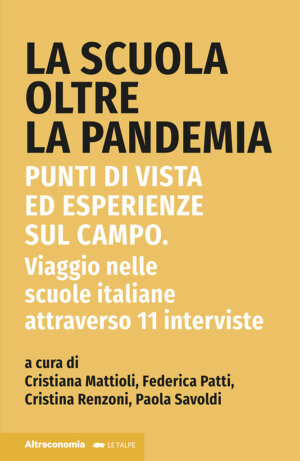Interni / Inchiesta
Così il controllo sulla didattica rafforza lo strapotere delle multinazionali

Quasi nove scuole italiane su dieci si sono affidate alla piattaforma proprietaria di Google. I dati inediti del ministero dell’Istruzione e degli Uffici scolastici regionali nella nostra inchiesta a due anni dall’avvio della Didattica a distanza
“Mi impegno a far sì che il servizio pubblico essenziale, seppur a distanza, venga fornito a tutti i nostri studenti”. Era il 4 marzo 2020 quando l’ex ministra dell’Istruzione Lucia Azzolina avviò l’epoca della didattica a distanza (Dad), mentre una comunità di oltre otto milioni di persone, tra studenti e professori delle scuole pubbliche, lasciava le aule e si chiudeva in casa per il dilagare del Covid-19. “Ricordo bene la prima lezione a distanza: fu confortante per gli studenti e per noi vedere che non eravamo isolati. Ma subito sorsero difficoltà tecniche e organizzative”. Raffaella Roviello, docente di Matematica e animatrice digitale del liceo Virgilio di Milano, rievoca l’avvio della crisi sanitaria, divenuta opportunità per i colossi della tecnologia. Oggi, trascorsi due anni, le multinazionali americane, Google e Microsoft in testa, hanno colonizzato il sistema dell’istruzione pubblica, come mostrano dati inediti trasmessi dal Miur e da alcuni Uffici scolastici regionali ad Altreconomia.
“A inizio lockdown ci siamo autorganizzati, usando gli strumenti digitali che conoscevamo o chiedendo ai colleghi -prosegue Roviello-. Professori e ragazzi impazzivano per la varietà di soluzioni impiegate, presto è diventato necessario unificarle. Così in quelle settimane ogni istituto ha cominciato a scegliere la propria piattaforma per la didattica”. Ma se la scelta veniva effettuata dalle scuole in regime di autonomia, il ministero dell’Istruzione aveva contribuito a creare il contesto della selezione. Con una call pubblica del 28 febbraio 2020 aveva invitato le realtà interessate a sostenere le iniziative per la Dad in via di allestimento. Il primo criterio esplicitato era che le piattaforme fossero “rese disponibili gratuitamente” e che nessun onere potesse gravare “sulle istituzioni scolastiche e sull’Amministrazione”.
Poco dopo, nel marzo 2020, il ministero pubblica sul proprio sito un elenco di risorse consigliate alle scuole in vista della didattica a distanza. Nella sezione dedicata alle piattaforme c’erano solo due nomi: G-Suite for Education di Google e Office 365 Education di Microsoft, cui poi si è aggiunta Weschool di Tim. Quest’indicazione è rimasta sul sito per oltre un anno, nonostante alcune contestazioni. “In pratica il ministero proponeva solo strumenti commerciali, invitando le scuole in maniera neanche troppo mascherata a usarli”, spiega Giuseppe Attardi, docente di Informatica all’Università di Pisa. “Non si presentavano alternative, solo i servizi di questi colossi tecnologici, senza tenere conto dei rischi sociali di cui spesso i cittadini sono poco consapevoli”. Proprio in quei mesi la diffusione delle piattaforme delle big tech nella scuola italiana ha preso slancio. “La decisione di usare la suite di Google nella nostra scuola l’ha presa il collegio docenti”, prosegue Roviello. “È una piattaforma che ritengo pratica: in parte la usavamo già, ma è stato con la Dad che l’abbiamo pienamente attivata. Ci siamo anche fatti delle domande, ma la risposta doveva essere rapida e assecondare tutti, tanto più che nel corpo docente c’è chi, anche per ragioni d’età, è restio ai cambiamenti. E, dai confronti che ho avuto con i colleghi, credo sia andata spesso così”.
L’osmosi tra scuola e piattaforme digitali è stata eletta a sistema dal ministero nell’agosto 2020 con il passaggio dalla fase emergenziale della Dad alla didattica digitale integrata (Ddi), linea poi confermata anche dall’attuale ministro Patrizio Bianchi, ma numeri che descrivano il fenomeno se ne trovano pochi.
Altreconomia ha così inoltrato al Miur e a 18 Uffici scolastici regionali (Usr) delle istanze di accesso civico per fare luce. I dati ottenuti dal ministero confermano uno sviluppo prevedibile. Le scuole che hanno fornito elementi (quasi 7.700 su poco più di 8.000 istituti pubblici italiani) hanno scelto in larga prevalenza Google Suite for Education (6.614, circa l’86,3%), seguita da Microsoft (1.381, il 18%) e Weschool (473, il 6,2%), mentre la voce “altro” (1.126, il 14,7%) raggruppa tutte le altre piattaforme scelte in aggiunta o in alternativa. Anche tra gli ulteriori sistemi per videocall o strumenti digitali utilizzati emerge la forte prevalenza di soluzioni commerciali (quali Whatsapp, Skype e Zoom) a discapito di quelle con licenza open source (come Jitsi o Moodle).

150 milioni di utenti sono stati raggiunti nel 2020 con il software Classroom di Google contro i 40 milioni dei dodici mesi precedenti
Evidenze simili sulla diffusione delle big tech si colgono dai risultati regionali. Dati relativi al Veneto fotografano le soluzioni adottate dalle scuole pubbliche nel marzo 2020, prima fase della pandemia: quasi due su tre (circa il 63%) avevano già adottato software proposti da Google o erano sul punto di farlo. L’Usr dell’Abruzzo ha risposto ai nostri quesiti con dati del 2021 che mostrano come quasi l’83% delle scuole abbia scelto Google, seguita da Microsoft poco oltre il 10%. In Calabria Google è poco sopra al 75%, Microsoft oltre il 10%. Al di là di qualche mancata risposta, gli altri Usr interpellati hanno scritto di non avere informazioni.
L’osmosi tra scuola e piattaforme digitali è stata eletta a sistema dal Miur nell’agosto 2020 con il passaggio dalla “emergenziale” Dad alla didattica digitale integrata (Ddi)
Dati sulla diffusione della piattaforma educativa di Google ne abbiamo chiesti anche all’azienda, insieme a un’intervista, senza ottenere risposte. Tuttavia un’idea dell’enorme opportunità che la pandemia ha rappresentato per Google la dà una nota della corporation del febbraio 2021, in cui affermava di avere raggiunto su scala globale i 150 milioni di utenti del software Classroom contro i 40 milioni di dodici mesi prima. Anche in Italia la pandemia sembra essere stata uno spartiacque per le big tech. Prima del Covid-19 la digitalizzazione delle scuole si sostanziava soprattutto nei registri elettronici e nelle lavagne interattive multimediali. L’avvento del virus ha sorpreso anche Google e Microsoft, che nel primo periodo hanno messo a disposizione di scuole e università italiane “piattaforme per la teledidattica frettolosamente adattate dai propri prodotti pensati per la gestione aziendale -spiega Giacomo Tesio, programmatore e hacker-. Hanno aggiunto l’alzata di mano nelle videocall e poco altro, ma si tratta di strumenti aziendali, non educativi. Invece esistono tante alternative libere e open source, nate per scopi didattici, che sono state ignorate, perché politica e società non comprendono quanto sta accadendo. Certo, le piattaforme private perseguono i propri interessi economici, non sempre allineati con quelli di scuole, studenti e professori. Ma il tema va oltre il fatto che siano ‘private’, questione seria ma dai termini troppo novecenteschi: queste sono piattaforme ‘di sorveglianza’ di massa, che basano i propri business model sui dati personali. La loro enorme capacità di acquisirli e sfruttarli per il profitto, condizionando anche gli utenti, impone un cambio di paradigma”.

Uno dei temi più delicati riguarda la tutela della privacy dei ragazzi, oltre che dei professori. “Su queste piattaforme girano dati di natura molto sensibile: non solo sull’uso dei software e su tempi, modi e risultati dello studio, ma anche sulle opinioni personali, religiose, o sullo status socio-economico di chi le usa”, dice Giulia Schneider, docente di Diritto dell’economia all’Università Cattolica di Milano e coautrice di uno studio europeo che, nel primo anno della pandemia, ha esaminato privacy policy e condizioni di servizio delle piattaforme. “Il focus era sulle università, ma le conclusioni sono estensibili alle scuole: il framework regolatorio (centrato sul Gdpr, il regolamento europeo sulla protezione dei dati) è lo stesso, ma si pongono problemi aggiuntivi visto che si parla anche di bambini e minorenni. Tutte le piattaforme analizzate si dimostrano molto vaghe, anche ambigue, sulle modalità di gestione dei dati che raccolgono, nonché sulle finalità. Per i possibili usi secondari parlano del miglioramento del servizio, ma così aprono a una varietà di usi commerciali. Il rischio è che Google e gli altri sfruttino i dati raccolti per la profilazione con finalità pubblicitarie o di marketing nei vari settori di mercato in cui operano”. Oltre alle questioni di diritto, Schneider ravvisa altre problematiche di scenario: “Innanzitutto manca consapevolezza su questi temi e quasi nessuno legge davvero le condizioni di questi servizi. Inoltre se Google egemonizza la didattica digitale, saranno sempre più i loro codici tecnologici a stabilire come si fa lezione, con quali modalità e tempi, quali contenuti è possibile caricare, con il rischio di un serio condizionamento culturale nel tempo. Infine questa enorme raccolta di dati rafforza le posizioni dominanti dei giganti della tecnologia: sia nel vero e proprio mercato dell’educazione digitale che sta nascendo, sia favorendoli in altri segmenti di mercato nei quali i dati raccolti a scuola possono essere trasposti”.
In pratica il controllo sulla scuola rafforza lo strapotere economico delle big tech. Tesio spiega la dinamica di fondo: “L’acquisizione di ciascun dato nuovo accresce anche il valore dei dati di cui si dispone già. Ogni informazione aggiuntiva su un utente, incrociata con le precedenti, ne rende più accurata la profilazione. Così i colossi digitali possono generare prodotti e servizi, basati su previsioni sempre più precise dei nostri comportamenti, che vendono agli inserzionisti pubblicitari o in altri ambiti di marketing”. Dunque l’esperienza scolastica di uno studente diventa monetizzabile. Una dinamica sempre possibile, non solo per le ambivalenze negli aspetti di diritto, ma anche per una ragione tecnica: “La copia dei dati non lascia tracce”, spiega Tesio. Dunque, anche qualora fosse possibile accedere ai server delle corporation, “non si può materialmente verificarne l’effettivo uso o la cancellazione, perché potrebbe sempre esisterne una copia nascosta”.
“I dati sul minorenne che ha difficoltà negli studi […] e che potrebbero venire analizzati dall’intelligenza artificiale di Google, sono strategici” – Paolo Monella
La potenza economica dei colossi tecnologici si fonda anche sulla gratuità dei servizi offerti, “perché -come spiega Attardi- è anche grazie a questa strategia che Google e le altre hanno potuto raccogliere così tanti dati e, facendosi pagare dal mercato pubblicitario, costruire un oligopolio di fatto”. La stessa gratuità dei servizi digitali che il ministero dell’Istruzione ha richiesto per la scuola in pandemia: un modello congeniale a Google e Microsoft. Oltre alla raccolta dei dati, “l’obiettivo delle big tech è la fidelizzazione”, prosegue Attardi. “Le persone nel tempo si abituano a un certo servizio, alle sue logiche, all’interfaccia, poi non possono più farne a meno. Si chiama ‘vendor lock-in’, e rischia di condizionare studenti e docenti, che in futuro potrebbero arrendersi di fronte alla fatica di cambiare una piattaforma cui si sono abituati e spostare una mole di file che vi sono memorizzati. Insomma, i servizi possono essere gratuiti e magari comodi, ma il costo nascosto è che gli stiamo appaltando un pezzo della nostra testa. Inoltre a un certo punto Google potrebbe anche cambiare idea e chiedere dei soldi. Ha già iniziato a farlo con le versioni premium della propria piattaforma, che oggi ha cambiato nome in Google Workspace for Education”. Ricorda la professoressa Roviello che “oltre alla versione gratis, c’è la proposta base sui quattro euro al mese a studente, quella business sui 10, e la enterprise intorno ai 23, anche se poi propongono pure abbonamenti modulati sulle singole scuole. In effetti sono offerte di taglio più aziendale che scolastico”, che preludono alla possibile formazione di un vero mercato.
Oltre alle problematiche giuridiche ed economiche, c’è un altro tema che rende discutibile l’uso delle piattaforme proprietarie nelle scuole italiane. “I dati sul minorenne che ha difficoltà negli studi, su quello dislessico, o quello che magari rivela in un tema di essere stato abusato in famiglia, e che potrebbero venire analizzati dall’intelligenza artificiale di Google, sono strategici”, dice Paolo Monella, ricercatore in Latino e Informatica umanistica presso La Sapienza di Roma. “Sono dati sensibili di cittadini europei e hanno una rilevanza strategica paragonabile ad altri dati digitalizzati, come quelli sulla salute delle persone o sulla posizione di un certo armamento. Nel mondo di oggi controllare i propri dati è importante come controllare i propri armamenti o le acque territoriali. Se non lo fai, la tua sovranità è limitata”. Un nodo che è geopolitico e legale assieme. “Negli Stati Uniti vige il ‘Cloud Act’ -continua Attardi-, una norma che consente alle agenzie governative di ottenere dalle aziende americane l’accesso a qualunque dato in loro possesso”. In pratica ogni dato raccolto nelle scuole italiane e salvato su un server di Google o Microsoft (o anche di Amazon, che gestisce server per altri operatori di piattaforme scolastiche) è potenzialmente accessibile al governo americano, anche qualora si trovi su suolo europeo: un’altra ragione per ritenere almeno dubbio il rispetto del Gdpr da parte delle big tech.

C’è chi prova a sciogliere questo intreccio tra aule scolastiche, corporation e governi stranieri. “La Francia ha preso molto sul serio la questione della sovranità digitale -riprende Monella-. Già a inizio pandemia il loro ministero dell’Istruzione ha proposto alle scuole un insieme di servizi open source e controllati dallo Stato: una piattaforma educativa, una di teleconferenza, un servizio di cloud. Tutto basato su software con licenza aperta, che girano su server mantenuti dallo Stato e da sistemisti francesi. Difficile poi dire come si siano orientate le scuole, ma lo Stato si è fatto trovare pronto, perché ha sempre avuto volontà e mezzi per costruire una propria strategia sul tema dei dati”. Anche in Spagna e in Germania, dove vigono forme di autonomia territoriale sulla scuola, diverse regioni hanno optato per l’open source.
“Per ogni tipo di software privato per la didattica digitale esistono numerose soluzioni a codice sorgente aperto, che, a differenza di quello proprietario, garantisce trasparenza sui meccanismi di funzionamento del programma -spiega Tesio- E molti di questi software sono più funzionali per l’istruzione, perché sono progettati per questa finalità”. Attardi aggiunge poi che “l’open source mette capo a un modello economico diverso, non concentrato. Anche per questo è un’ottima leva per un’alternativa”.
“I dati sul minorenne che ha difficoltà negli studi […] e che potrebbero venire analizzati dall’intelligenza artificiale di Google, sono strategici” – Paolo Monella
In Italia la soluzione è stata adottata solo in casi rari, anche se “il Codice dell’amministrazione digitale imporrebbe agli enti pubblici di attivare nuovi software solo in seguito a valutazione comparativa che includa soluzioni open source e, a parità di altre condizioni, di privilegiare queste ultime”, spiega Schneider. Pare che la norma resti lettera morta. I consigli d’istituto scolastici, spesso privi delle competenze necessarie, sembrano optare per soluzioni più note e comode, trascurando una legge che, invece, rappresenterebbe “una prima via d’uscita dall’attuale situazione. Il ministero dovrebbe controllare che venga applicata, e ancor di più il Garante per la protezione dei dati personali”. Eppure nel nostro Paese c’è un caso in cui si sono scelte risorse per la didattica open source, e gestite in autonomia. Siamo al Politecnico di Torino, e ne racconta Enrico Venuto, responsabile reti e infrastrutture. “Noi per fortuna avevamo le forze in casa, già da tempo lavoravamo su programmi open per la didattica. Quando è arrivato il lockdown in pochi giorni siamo riusciti ad attivare un sistema basato su BigBlueButton, un software di videoconferenze open source con finalità educativa. Già nei primi mesi gestivamo anche 7mila connessioni simultanee. Lezioni, lauree, laboratori: tutto viaggiava su data-center italiani, del Politecnico, il che fa un enorme differenza per la tutela della privacy”.
“Le scuole non devono poter utilizzare piattaforme che non controllano, benché gratuite, e tanto più quando diventano a pagamento” – Massimo Carboni
La rete fisica a banda ultralarga su cui gira il sistema è messa a disposizione da Garr, un’associazione di enti pubblici che fornisce connettività alle comunità della ricerca e dell’istruzione. La sinergia tra Politecnico e Garr ha così reso possibile in Italia un sistema su larga scala per la Dad efficiente, vocato all’istruzione, svincolato da logiche commerciali e rispettoso della privacy. “Molte scuole non potrebbero adottare oggi questo modello -spiega Venuto-, occorrono macchine e un know-how non banale, ma si possono cercare strade per adattarlo alla comunità scolastica”. Concorda Massimo Carboni, responsabile Infrastrutture Garr: “L’Italia non è messa così male, né nella produzione software né nella capacità di installare calcolatori e reti. Servono investimenti, ma non è detto che siano così gravosi, specie se confrontati con quello che stiamo pagando, e pagheremo, ai provider multinazionali. La gratuità di fatto non esiste: c’è sempre almeno un costo nascosto, perché nel tempo il Paese arretra. Con Google è cominciata nel 2008, quando hanno iniziato a fornire la mail gratis. Gli sono andati dietro in molti, utenti comuni e amministratori, lieti di eliminare una voce di spesa dai bilanci. E lo stesso vale per tanti servizi successivi, che trovavamo già pronti e convenienti. Questo però comporta una perdita di competenze”. Per Carboni il problema in Italia ha anche un’origine politica: “Credo che, nell’emergenza di inizio pandemia, si sia fatto un errore strategico con la richiesta della gratuità dei servizi e la visibilità data alle corporation dal ministero. Questo modello dovrebbe essere ora scoraggiato: le scuole non devono poter utilizzare piattaforme che non controllano, benché gratuite, e tanto più quando diventano a pagamento, contribuendo ad arricchire soggetti che ci rendono ignoranti”.
L’anno scorso in Parlamento è stato stanziato un fondo per un disegno di legge che vuole istituire Unire, una nuova rete unica di interconnessione delle scuole italiane, che potrebbe contare anche su server in cloud in grado di gestire e mantenere in Italia i dati generati con la didattica digitale. Sono gli albori di un progetto che avrebbe delle affinità con quello operativo in Francia e coerente con gli indirizzi del Piano nazionale di ripresa e resilienza, anche se il buon esito e molti dettagli concreti saranno da verificare. “Abbiamo atteso troppo -riprende Carboni-, ma siamo ancora in tempo per investire. Quando lo si è fatto per la rete Garr, 30 anni fa, ha funzionato e i benefici si continuano a vedere. Ne gioverebbero il comparto informatico e la nostra cultura digitale. E recupereremmo spazi di libertà.
© riproduzione riservata