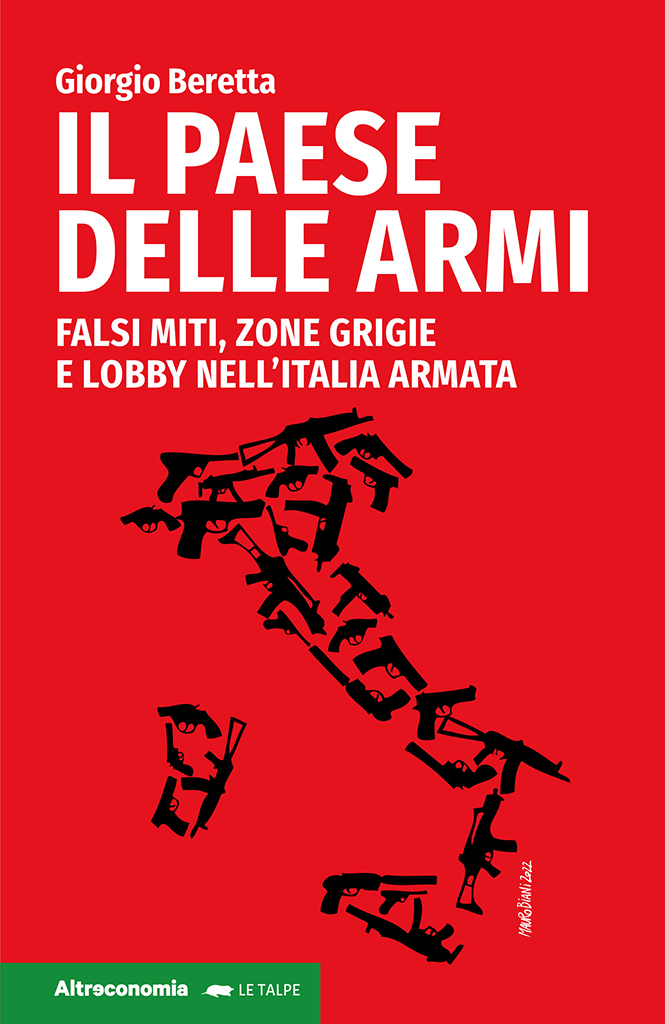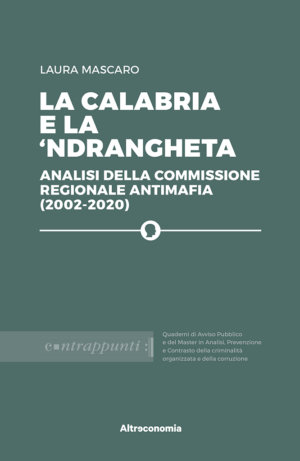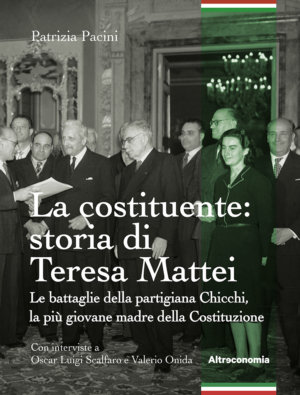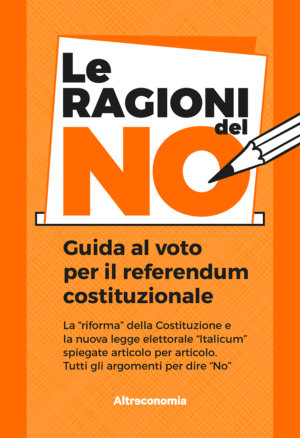Interni / Intervista
“Il mio nome è Rosa Parks”, una battaglia rivoluzionaria tra le nubi nere di Monfalcone

Nel suo ultimo romanzo, l’attivista e scrittore Michele Guerra racconta la realtà della città costiera del Friuli-Venezia Giulia, dove quasi un terzo della popolazione è straniera -in larga maggioranza proveniente dal Bangladesh-, richiamata dal lavoro nei siti navali di Fincantieri. Un microcosmo duro, fatto di esperimenti di “differenziazione etnica” e tentativi di resistenza
A Monfalcone, città sulla costa del Friuli-Venezia Giulia, circa il 30% della popolazione è straniera -in larga maggioranza proveniente dal Bangladesh-, richiamata dalle possibilità di lavoro nei cantieri navali di Fincantieri. Ma non si può dire che questo luogo sia un faro per percorsi di convivenza e inclusione. Anzi: la città è diventata tristemente famosa, persino sulla stampa estera, per l’atteggiamento intollerante dell’amministrazione comunale, che a novembre del 2023 ha anche chiuso due centri culturali islamici con un’ordinanza sugli abusi edilizi. Qualche anno prima, nel 2019, era scoppiato anche un importante caso giudiziario, con 19 lavoratori bengalesi costituiti parte civile in un processo per caporalato.
È il contesto in cui si sviluppa il romanzo di Michele Guerra “Il mio nome è Rosa Parks” (MdS editore), un racconto che unisce realtà e finzione per dipingere un ritratto vivido della situazione monfalconese e delle sue contraddizioni.
Guerra, da dove nasce questo libro?
MG Dalla realtà di Monfacone degli ultimi sei o sette anni, diventata sostanzialmente un laboratorio per esperimenti di “differenziazione etnica”, che la destra sta portando avanti a livello europeo, calato nel municipalismo. Il libro nasce da tutte le proposte, le idee, ma soprattutto dalle ordinanze che sono state eseguite dalla Giunta comunale. In particolare, sono state discriminate le comunità migranti, come quella bengalese, che è maggioritaria proprio perché rappresenta la fetta più grande delle maestranze all’interno dei cantieri navali di Fincantieri.
Il romanzo unisce fatti realmente accaduti e parti inventate, tanto che sono riportate notizie di cronaca e nomi di persone veramente coinvolte. Qual è il confine tra realtà e finzione?
MG Ho inventato tutto ciò che riguarda le vicende più familiari e domestiche, così come quelle di relazione e affettività dei tre protagonisti diciassettenni e degli altri personaggi. Ovviamente mi sono basato sulle condizioni reali dei migranti a Monfalcone; per quanto riguarda Ahmed, il ragazzo marocchino, ho parlato dell’impossibilità di vedere riconosciuti i propri titoli sportivi in quanto ancora minorenne, quindi ancora non cittadino. È comunissimo in Italia: durante ogni competizione sportiva vediamo i figli delle seconde generazioni che raccontano che fino all’anno prima non potevano gareggiare. Quindi, riassumendo, di vero nel romanzo c’è la cornice in cui è inserito. Ho mantenuto anche i nomi delle due avvocate -Manuela e Sara- che stanno seguendo il processo per caporalato che è davvero in corso a Monfalcone; ho riportato i veri titoli dei giornali su questi fatti. Sono reali anche tutte le vicende storiche legate alla Resistenza in Friuli-Venezia Giulia.
Nel libro, appunto, una larga parte è dedicata al racconto della Resistenza. Perché accostare la storia di Monfalcone degli ultimi anni e quella delle stesse zone alla fine della Seconda guerra mondiale?
MG Per mettere in rilievo quella che è la contraddizione principale che vivono luoghi e città come Monfalcone, che hanno una lunga tradizione operaia di sinistra e sono fortemente connotati dal loro passato resistenziale e dalla natura antifascista che a lungo hanno avuto le loro amministrazioni. Negli ultimi anni molte di queste zone si trovano ad avere giunte di destra -alcune le definirei di estrema destra-, quindi la mia intenzione era quella di usare Monfalcone come metafora di una serie di sconvolgimenti municipali, che rischiano di diventare traumi e terremoti a livello nazionale e anche europeo: quello che succede in questa città sta avvenendo con tutti i partiti sovranisti nel continente.
Nel libro ci sono personaggi, come Bulldog, dipinti inizialmente come “cattivi”, che poi rilevano una “doppia identità” e mettono quindi in luce il peso delle circostanze in cui ci si trova sui comportamenti.
MG È così. Anche nei miei libri precedenti ho sempre utilizzato questo tipo di prospettiva e di approccio: il male è determinato dal capitalismo. Sono le condizioni economiche che portano le persone ad agire in un certo modo, al netto di tutte le scelte etiche e morali che noi possiamo e dobbiamo fare. Quando c’è di mezzo il ricatto economico, alcuni possono permettersi delle scelte, altri no. E Bulldog, nel mio libro, è una maschera della necessità del capitalismo di trasformare gli uomini in strumenti a proprio uso e consumo. Lui alla fine si ribella, in un certo senso, non regge più il sistema criminale in cui è coinvolto, rivela di aver fatto quello che ha fatto per la famiglia. Soprattutto dice una cosa che è discriminante di quello che è il mondo del caporalato e di molte realtà legato allo sfruttamento; confida che non voleva restare un morto di fame, rimanere l’immigrato sfruttato. Ma questo processo riguarda chiunque, non solo i migranti, su cui sicuramente il ricatto economico pesa in maniera maggiore.
Parlando del titolo del libro, invece, Rosa “Parks” è una ragazza monfalconese che fa proprie le lotte degli afroamericani, ma che nel corso del romanzo compie un’evoluzione importante.
MG Lei rappresenta la parabola delle nuove generazioni di attivisti, che -esattamente come è capitato ai miei coetanei che ora hanno attorno ai 40 anni- alla fine dell’adolescenza e alle soglie dell’età adulta vivono in una sorta di mondo mitico, in cui qualsiasi tipo di lotta, di radicalità e di anticonformismo spinge forte sulla coscienza e sulla realtà e tende a essere totalizzante. Rosa è una persona che vive di miti, parla con il poster di Angela Devis e Nina Simone. Poi, grazie all’incontro con un partigiano della brigata proletaria, capirà -lui glielo dice esplicitamente- che non ha bisogno di miti o di mondi lontani. La sua vita può essere legata a una realtà come quella della Resistenza. Alla fine, lei unirà le due tradizioni, cantando una canzone di Nina Simone al funerale del partigiano. La ragazza viene meno al suo essere Rosa Parks semplicemente perché capisce che quella cultura e quella mitologia le è meno vicina rispetto a quella dell’antifascismo.
Ci sono ragazzi che davvero si impegnano per i diritti dei migranti a Monfalcone?
MG La città può essere considerata un microcosmo di quelli che sono i movimenti e le tendenze dei giovani in Italia e nel mondo. Ci sono i gruppi anarchici e quelli studenteschi e naturalmente moltissimi movimenti legati alle comunità migranti. Ci sono bengalesi che hanno pagine Facebook dedicate alla loro relazione con l’Italia. Io non conosco una ragazza che possa incarnare integralmente il personaggio di Rosa, però penso che ci siano tante giovani impegnate nelle diverse realtà di Monfalcone.
Per concludere, qual è la realtà di Monfalcone oggi, dopo le inchieste e i processi? È cambiato qualcosa?
MG Purtroppo no. Innanzitutto perché i processi devono ancora arrivare a una conclusione. Se sono arrivate delle condanne, sono state molto irrisorie, di primo grado. E a essere colpiti sono i pesci piccoli. Dal 2020 sono state più fatte operazioni riguardanti la yaba, la droga che viene nominata nel libro perché utilizzata per sopportare la stanchezza dei turni, ma questo non significa che non ci sia circolazione di stupefacenti: possono aver semplicemente cambiato sostanza o modalità di somministrazione.
© riproduzione riservata