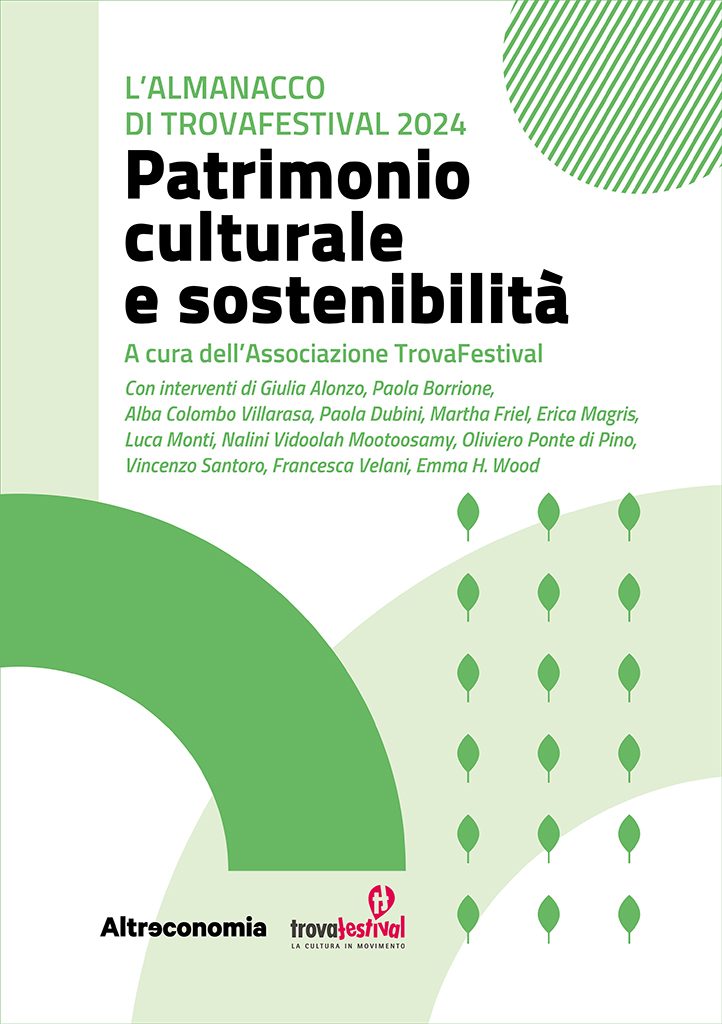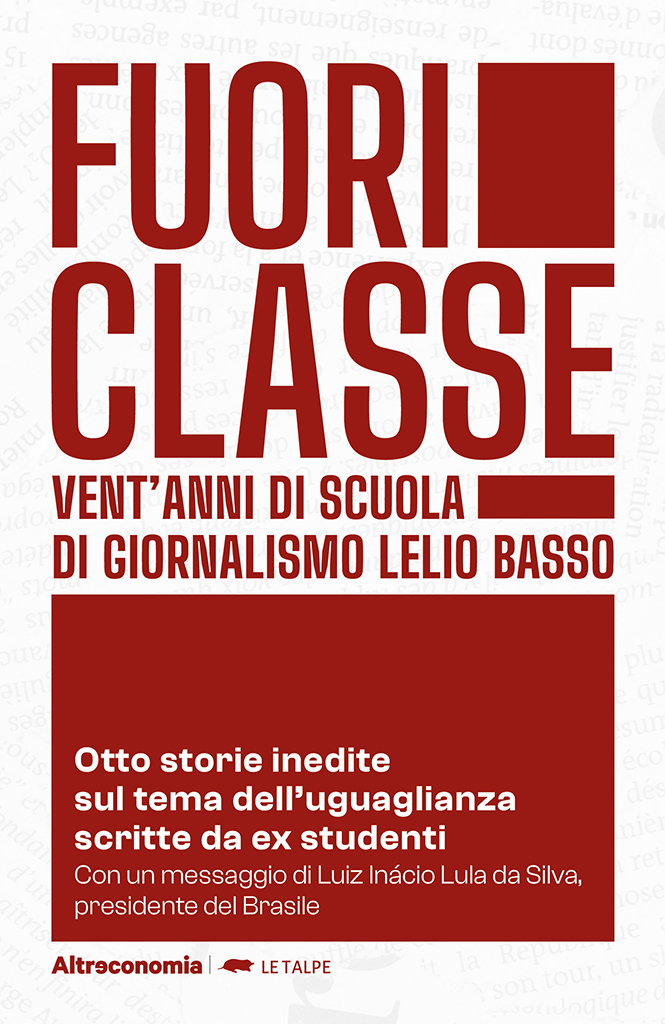Cultura e scienza / Opinioni
Casa loro, casa nostra. Il Seicento è ancora qui

La globalizzazione è stata costruita dall’Europa, che ha sradicato persone e incatenato gli schiavi. Imbarcandoli a forza. Ce ne siamo dimenticati. La rubrica di Tomaso Montanari
“Aiutiamoli a casa loro”, “Rimandiamoli a casa loro”: due espressioni apparentemente antitetiche. La prima cara a Matteo Renzi, la seconda a Matteo Salvini. Come i due Matteo, anche queste espressioni sono in realtà più simili di quanto non si pensi. In comune hanno l’espressione chiave: “a casa loro”. Gravida di conseguenze sul piano morale, e su quello politico: perché contrappone un “noi” a un “loro”, oppone una “casa” ad un’altra “casa”. Ma prima ancora di guardare in faccia la retorica identitaria di cui si nutre questa antinomia, è forse bene chiedersi quanto essa sia fondata sul piano dei fatti: della storia del mondo. Della realtà.
Guardiamo questo quadro. Si trova al Detroit Institute of Art, e fu dipinto intorno al 1660 da Hendrik Van der Burch, un pittore nato a poche miglia da Delft, la città olandese per tutti noi ormai indistinguibile dall’arte di Vermeer. Hendrik era forse cognato di un altro pittore allora assai celebre, Pieter de Hooch: ma dipingeva in modo assai meno memorabile sia di quest’ultimo che, ovviamente, di Vermeer. Eppure questo suo quadro è istruttivo. Un uomo e una donna giocano a carte, mentre una bimba accarezza il suo cagnolino. Siamo in un tipico interno olandese: siamo in una casa, nel cuore dell’Europa.
Siamo “in casa nostra”. Ebbene, in casa nostra c’è un nero. Un piccolo nero: un bambino di circa dieci anni, proveniente dal cuore dell’Africa. È un servo: probabilmente uno schiavo. Ci guarda con i suoi grandi occhi tristi, mentre mesce il vino da una lussuosa caraffa di porcellana cinese. Quel piccolo schiavo è un migrante: non volontario, beninteso. È uno dei tanti africani che i soldati olandesi del Seicento caricavano a forza sulle loro navi, e trasportavano, attraversando l’Atlantico, sulle coste americane. Qua gli schiavi neri avevano due destinazioni principali: le piantagioni di tabacco e le miniere d’argento. Sia il tabacco sia l’argento erano in buona parte destinati al mercato cinese: e quel piccolo schiavo africano è il simbolo della globalizzazione che l’Europa costruisce nel Seicento.
È l’inizio della modernità: ed è l’inizio di un’epoca in cui non c’è più “casa nostra” e “casa loro”. Il mondo è diventato una casa sola: e l’abbiamo fatto noi europei. Si calcola che tra il Cinquecento e l’abolizione della schiavitù (negli anni sessanta dell’Ottocento) un numero oscillante tra i dieci e i dodici milioni di neri sia stato imbarcato sulle navi occidentali. Migranti per forza, il 15% dei quali moriva nella marcia forzata, in catene, per raggiungere la costa africana, e poi nelle stive in fondo alle quali si affrontava la traversata. In fondo, al nostro schiavetto vestito a festa era andata perfino bene: e solo a doverlo pensare vengono i brividi.
Ma nel tempo lungo della storia, il Seicento è ieri. Siamo ancora nell’economia e nell’assetto politico che allora presero forma: e sappiamo che tra il Seicento ed oggi abbiamo inventato mille forme di imperialismo occidentale sull’Africa, moltissime ancora in corso. Quel tempo terribile è la radice del nostro tempo: a quei rapporti di forza dobbiamo la nostra fortuna di occidentali ricchi e sicuri. Come si fa anche solo a pensare che dopo aver caricato a forza milioni di africani sulle nostre navi, possiamo ora dire di no agli africani che sulle loro povere barche sfuggono alle conseguenze della nostra devastazione della loro terra per venire a casa nostra che è anche casa loro, da secoli e per scelta nostra?
Tomaso Montanari è professore ordinario di Storia dell’arte moderna all’Università di Napoli. Da marzo 2017 è presidente di Libertà e Giustizia.
© riproduzione riservata