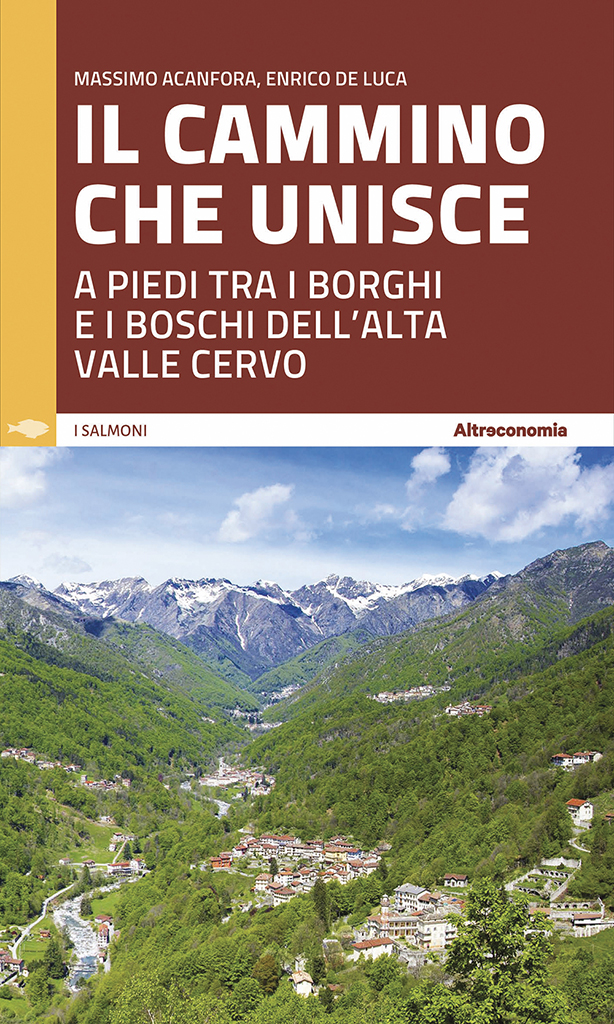Cultura e scienza / Opinioni
La storia di Sanremo, l’intervento di Zelensky e il trionfo dell’artificialità

Portare il presidente ucraino al Festival per pochissimi minuti nel bel mezzo di uno show sembra essere solo una trovata pubblicitaria, osserva Alessandro Volpi. “Si compie così una confusione di linguaggi che stravolge la narrazione reale della tragedia della guerra”, ingoiando le vite e annullando gli aspetti più crudi e disumani
Il Festival di Sanremo è stato a lungo una manifestazione politica. Nato nel 1951, per circa vent’anni non ha mai affrontato temi politici nei contenuti delle canzoni presentate, fatte salve rarissime eccezioni, ma ha costituito un vero e proprio modello di racconto popolare con cui il principale partito al governo, la Democrazia cristiana, intendeva veicolare verso il pubblico italiano i propri valori di riferimento e i simboli di appartenenza a un’Italia moderata e cattolica, peraltro senza incontrare troppe resistenze nel Partito comunista togliattiano che, sul piano della morale e del senso comune, non si distingueva molto dagli eredi di De Gasperi.
Si trattava di un modello efficace e funzionale in un Paese dove, nella prima metà degli anni Sessanta, si vendevano 25 milioni di dischi, tutti rigorosamente in lingua italiana e tutti altrettanto rigorosamente dedicati all’amore. Non è certo un caso, in tal senso, lo straordinario successo delle cover di pezzi d’Oltreoceano tradotti in italiano e stravolti nei contenuti. Solo per citare un esempio eloquente di un simile fenomeno si può ricordare la cover di un pezzo decisamente politico di Pete Seeger, “If I had a hammer”, che narrava di un’ingiusta sentenza contro un militante, trasformato da Rita Pavone nel fortunatissimo 45 giri “Datemi un martello”, dove il martello sarebbe stato utilizzato da un’innamorata per colpire “la smorfiosa” che le intendeva sedurre il fidanzato.
Questo “modello sanremese” centrato su amore, famiglia e italianità, cominciò a scricchiolare alla fine degli anni Sessanta, prima con il suicidio, proprio nella città dei fiori, di Luigi Tenco, espressione di un malessere esistenziale non più contenibile dalle “canzonette felici”, e poi con la contestazione giovanile del 1968, ostile a ogni conformismo, compreso quello canoro. Ma furono gli anni Settanta a travolgere il modello Sanremo e a privarlo della sua forza “politica”; di fronte alla durezza dello scontro ideologico, alla violenza, alle battaglie per le libertà civili e alla rapida trasformazione dei costumi, le canzoni del Festival non avevano più alcuna presa e, così, la Rai, sotto la regia della Democrazia cristiana, decise di abbandonarlo fino al 1980.
In quell’anno si avvertì che il vento stava cambiando, la tesissima stagione della crudezza politica si era largamente esaurita con la morte di Aldo Moro, e a presentare Sanremo venne chiamato un giovanissimo disc jockey, Claudio Cecchetto, affiancato da un funambolico Roberto Benigni. Fu un’edizione tormentata, per l’utilizzo del playback e per le battutacce dissacranti del comico toscano che portò per la prima volta la satira politica nel Festival, scatenando persino interrogazioni parlamentari. Ma gli ascolti della Rai, che aveva ripreso la diretta delle serate finali, furono ottimi dando il segno che si apriva una stagione nuova, quella in cui Sanremo diventava la “grande evasione”, secondo quanto recitava il titolo di un libro importante dedicato al Festival da un comunista di rilievo come Gianni Borgna.
La vocazione di Sanremo a essere il vero grande evento televisivo dell’anno trovò il suo interprete migliore in Pippo Baudo che confezionò l’idea della televisione nazional-popolare, diversa da quella degli anni Cinquanta perché meno tradizionale e meno chiusa, più castamente trasgressiva, capace di nuovo di essere un modello politico in quanto tale, destinato a dare l’impressione che i partiti di governo lasciassero ampio spazio alla critica; da Beppe Grillo fino a Maurizio Crozza. In un simile contesto, i richiami alla politica internazionale erano rari e sempre e comunque caratterizzati dall’effetto della testimonianza “postuma” come avvenne per la presenza di Michail Gorbačëv e consorte nell’edizione del 1999. L’ordito del Festival inseriva la politica nello spettacolo anche con alcune canzoni, impegnate o ironiche, ma non confondeva mai i due piani.
Rispetto a questa lunga storia portare il presidente ucraino a Sanremo per pochissimi minuti nel bel mezzo di uno show sembra essere solo una trovata pubblicitaria; Volodymyr Zelensky diventa la star per attirare la pubblicità commerciale, per fare audience dentro un contenitore rispetto al quale l’intervento del presidente ucraino intende restare estraneo, utilizzandone però il vasto pubblico. Si compie così una confusione di linguaggi che stravolge la narrazione reale della tragedia della guerra. Declinare ogni cosa nella forma dell’intrattenimento appartiene allo sforzo in atto di spettacolarizzazione anche degli aspetti più crudi e disumani in nome del successo degli ascolti, secondo un modello a cui Sanremo, in verità, non si era mai affidato. La guerra diventa una finzione scenica e, in un simile racconto, l’aspetto più deteriore del mercato ingoia le vite umane; la tradizione “politica” di Sanremo, dove non si operava mai la confusione di lessici diversi, non è questa e non può essere citata per giustificare una simile scelta che è il prodotto invece del trionfo dell’artificialità e della irrealtà, del resto come avviene nel mondo della finanza, impegnata a demolire l’economia.
Alessandro Volpi è docente di Storia contemporanea presso il dipartimento di Scienze politiche dell’Università di Pisa. Si occupa di temi relativi ai processi di trasformazione culturale ed economica nell’Ottocento e nel Novecento
© riproduzione riservata