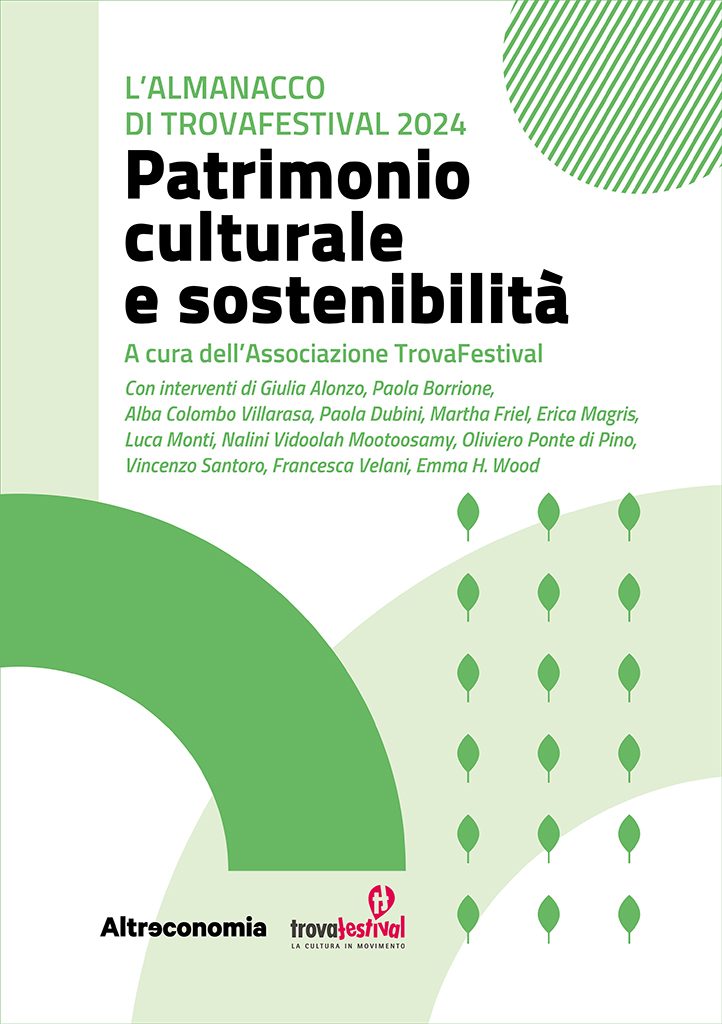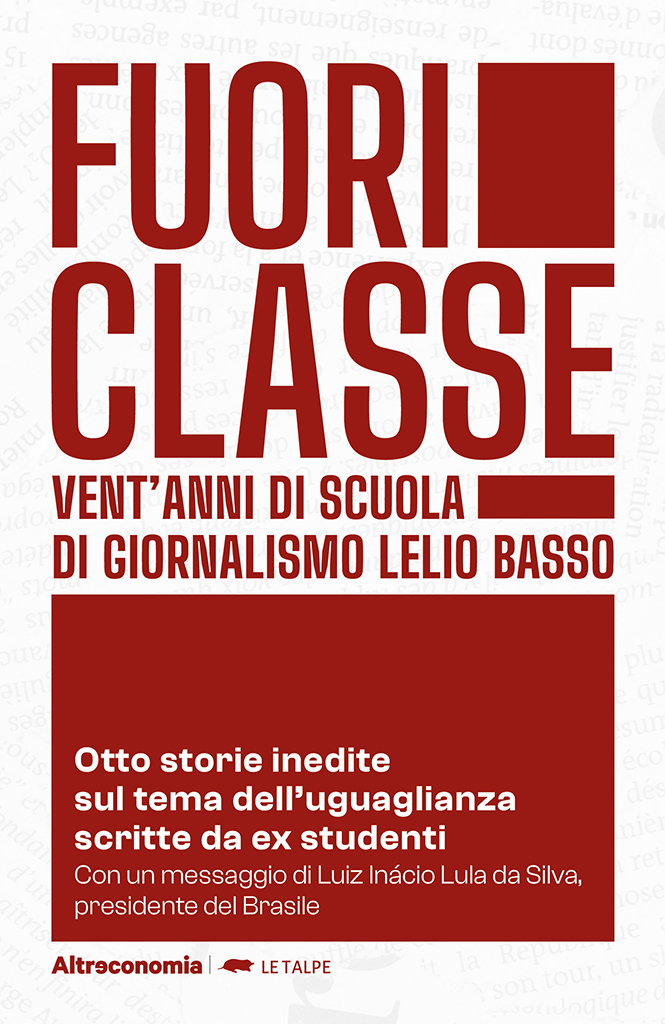Cultura e scienza / Opinioni
Simone Weil e la “sua” Firenze, intima e di tutti

Nella Cappella Medicea e in città la filosofa si lascia attraversare dall’arte. Coglie lo spirito delle opere e “anticipa” il progetto della Costituzione. La rubrica di Tomaso Montanari
Un altro aprile in zona rossa, qua a Firenze. E dunque cerchiamo compagni immateriali con cui assembrarsi nella fantasia. “La primaverile pioggia fiorentina è deliziosa, non c’è bisogno del sole per indugiare nella Cappella Medicea, e non vedo alcun motivo per non passarci delle giornate. Vi ho già passato delle ore. Ero ben lontana dall’attendermi ciò che vi ho provato. Quest’arte è troppo commovente, come la Terza Sinfonia. Come è dolorosa quest’Alba! È il risveglio a una vita amara, a una giornata troppo dura, un risveglio di schiava; il risveglio di Elettra. Vi si potrebbero scolpire questi versi, tanto belli: ‘Sola non ho più la forza di reggere/il peso della tristezza che mi trascina a terra’. […] L’Alba mi ha rievocato con forza i miei risvegli di operaia, in Rue Lecourbe”.
Sono parole di Simone Weil, scritte da Firenze nel maggio 1937: a leggerle oggi, par quasi di rivivere quell’esperienza avvenuta ottant’anni fa nella Sagrestia Nuova di San Lorenzo. Simone cerca di tradurre in parole le sue emozioni, le sue sensazioni, i suoi pensieri di fronte ai marmi di Michelangelo. Per farlo evoca la musica: l’Eroica di Beethoven. E quando lo sguardo si posa su una singola statua, l’Alba che si stira nell’atto di ridestarsi, è solo grazie alla poesia che Simone riesce a “parlarla”: pronunciando, anzi facendole pronunciare, due versi dell’Elettra di Sofocle. Ecco la chiave: l’Alba è una donna dalla vita troppo dura. È una schiava: e il parallelo è esistenziale, stringente. La minuta Simone si specchia in quella donna erculea: e ripensa ai suoi risvegli da operaia, quando un lavoro durissimo la lacerava. Da una parte un celeberrimo corpo femminile, scolpito: dall’altra il corpo della donna che è stata forse il maggior filosofo del Novecento.
E il corpo reagisce soprattutto ai luoghi in cui si trova. La Sagrestia Nuova: non solo la statua dell’Alba. E poi la pioggia fuori, in un giorno di maggio. Ma non solo. Nelle stesse lettere, Simone Weil parla della “fiaschetteria” in cui mangia “un piatto di pasta al sugo, formaggio, fave crude, vino, il tutto per quattro lire, in un’atmosfera molto simpatica e tra conversazioni appassionate ma difficili da seguire”, e ancora del “Viale dei Colli, reso inebriante dal profumo dei fiori e dal gran numero di ulivi”, o di San Miniato, “che è davvero bella, al tramonto”.
Lettere punteggiate di versi: Omero, Orazio, Lucrezio, Dante, Michelangelo siedono con Simone in trattoria, con lei passeggiano, guardano, respirano. È una comunione personalissima: intima, ma vissuta in pubblico e condivisa con una collettività. Un sentimento di Firenze: una intimità collettiva. “Firenze è la mia città -scrive ancora Weil-. Di sicuro ho vissuto una vita precedente tra i suoi uliveti. Quando ho visto i suoi bei ponti sull’Arno, mi sono chiesta che cosa avessi fatto, lontano da lei per così tanto tempo. Deve esserselo chiesto anche lei, perché alle città piace essere amate. Qui c’è ancora una quantità di cose belle che non ho visto, perché io non visito le città, lascio che entrino dentro di me, per osmosi”.
“Chi non sa apprezzare un albero/non può apprezzare un quadro”, ha scritto Franco Marcoaldi: quanta storia dell’arte accademica, ignara dei contesti e dello spirito che vivifica gli oggetti altrimenti inerti che studiamo, è spazzata via da questa aurea sentenza che volge in programma di vita il progetto della Costituzione. Quello che Simone Weil già sentiva, nella pioggia primaverile fiorentina.
Tomaso Montanari è professore ordinario presso l’Università per stranieri di Siena. Ha vinto il Premio Giorgio Bassani di Italia Nostra
© riproduzione riservata