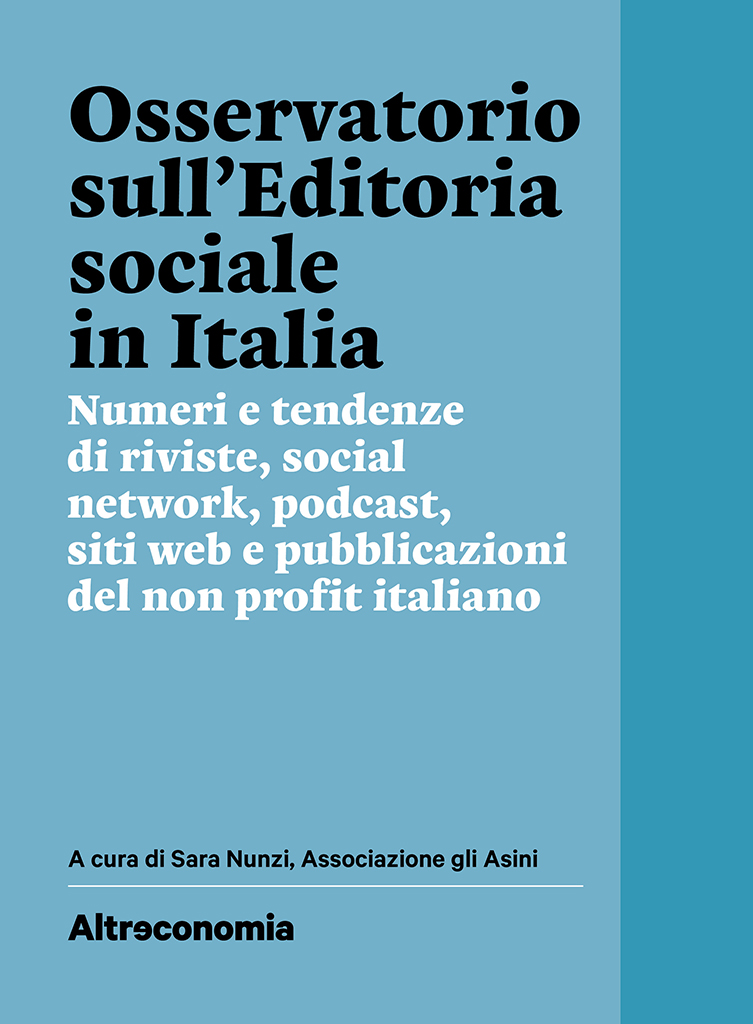Altre Economie / Approfondimento
La rigenerazione partecipata delle “chiese non più chiese”

Il riuso dei beni ecclesiastici abbandonati è un fenomeno in crescita, anche in Italia. Il nostro viaggio tra i percorsi di coinvolgimento delle comunità locali e dei desideri della società civile, da Trapani a Venezia
“A un certo punto della sua storia, questa chiesa portava notizie, belle o meno. Le persone venivano e stavano in attesa, per spedire o ricevere pacchi, lettere, cartoline”. Don Liborio Palmeri, 56 anni, ha iniziato la sua attività di parroco nel 1987, “in bicicletta, nelle campagne trapanesi”. Quando nel 2012 ha visto quello che oggi è l’oratorio-museo san Rocco, a Trapani, non avrebbe detto che un tempo lì ci fosse stata una chiesa. “Sapevo la sua origine, ma era un vissuto di secoli, sepolto da un’altra storia”, racconta. Con l’Unità d’Italia, infatti, la chiesa era stata incamerata tra i beni dello Stato e poi trasformata nell’ufficio postale della Provincia.
Dopo la seconda guerra mondiale l’edificio ha ospitato l’ufficio igiene, l’archivio comunale e una scuola di ragioneria, per poi essere abbandonato. “Non sapevo bene cosa fare, allora ho deciso di fondare il recupero di san Rocco sul coinvolgimento dei giovani e sulla valorizzazione delle arti”. Ha ristabilito il culto e oggi qui si trova una chiesa, uno spazio espositivo, una libreria e delle sale comuni. La grande sfida è ora farlo sopravvivere nel tempo: per don Liborio la soluzione sta nel “trinomio che unisce culto, cultura ed economia, grazie al coinvolgimento degli abitanti e dei visitatori”.
Quello di san Rocco è solo un esempio di riuso di un bene ecclesiastico abbandonato, un fenomeno in crescita a cui la Conferenza Episcopale Italiana ha dedicato a fine novembre il convegno internazionale “Dio non abita più qui? Dismissione di luoghi culto e gestione integrata dei beni culturali ecclesiastici”. Riflessioni che hanno portato il Pontificio consiglio della Cultura, un dicastero della curia, con i delegati delle conferenze episcopali d’Europa, Canada, Stati Uniti d’America e Australia, a pubblicare le linee guida “La dismissione e il riuso ecclesiale di chiese”. Si tratta di un documento valido per tutta la Chiesa, ma che avrà prossimamente “una traduzione italiana, specifica per il nostro contesto”, spiega don Valerio Pennasso, direttore dell’ufficio nazionale per i Beni culturali ecclesiastici e l’edilizia di culto della Cei. Nelle linee guida “si raccomanda che ogni ente ecclesiastico rediga un inventario dei propri beni”, con “particolare cura nel censire e monitorare il patrimonio religioso non più utilizzato”.
Oggi, la banca dati “Beni ecclesiastici in web”, raccoglie il censimento del patrimonio storico e artistico, architettonico, archivistico e librario di proprietà di 224 diocesi italiane e di 1.682 istituti culturali ecclesiastici. Ha censito finora 65.225 edifici di culto, “una prima analisi non ancora consolidata, perché l’indicazione della proprietà non è sempre certa”, spiega don Pennasso. Un’altra fonte è il censimento delle chiese delle diocesi italiane, che comprende 66.930 edifici. “Queste non sono tutte le chiese italiane, ma solo quelle di proprietà di 219 diocesi. Sono esclusi gli ordini religiosi e le oltre 800 chiese del Fondo edifici di culto (Fec) del ministero degli Interni”, sottolinea Luigi Bartolomei, del dipartimento di Architettura dell’Università di Bologna e presidente del Centro studi Cherubino Ghirardacci. Secondo don Valerio Pennasso, infatti, per avvicinarsi a una stima delle chiese in Italia “bisognerebbe moltiplicare per due o tre volte gli oltre 65mila edifici censiti”. Ma se conoscere l’entità di questo patrimonio è problematico, “ancora più difficile è sapere in che condizioni si trovino questi beni”, aggiunge. Qual è, d’altronde, il discrimine tra le chiese non più utilizzate per il culto e quelle usate saltuariamente o per altri scopi? “Pensiamo a una chiesa inutilizzata stabilmente, che si trova in una frazione di montagna e viene aperta due volte l’anno per la festa patronale: per la sua comunità ha forse più valore della chiesa parrocchiale aperta quotidianamente”, osserva. Spazi da valorizzare “rimettendo al centro le persone” a cui questo patrimonio serve.
Quando nel 2012 don Liborio Palmeri ha visto quello che oggi è l’oratorio-museo san Rocco, a Trapani, non avrebbe detto che un tempo lì ci fosse stata una chiesa
La maggior parte delle chiese in disuso sono collocate nei “borghi abbandonati sugli Appennini o le Prealpi, dove sono vissuti i fratelli”: Luigi Bartolomei usa questa citazione di Pier Paolo Pasolini per spiegare come questi luoghi di culto diffusi nelle periferie abbiano perso “non solo il prete, ma la comunità -che è scomparsa o è diventata stagionale, di passaggio durante le vacanze”. Le chiese restano però “l’infrastruttura territoriale più ricorrente che troviamo nel paesaggio”. Bartolomei porta l’esempio della diocesi di Bologna: “601 edifici di culto: uno ogni cinque chilometri”. Ma solo il 20% si trova a Bologna città; gli altri sono nelle campagne e in montagna, presìdi che assicuravano il servizio liturgico nelle periferie. Quando gli abitanti si sono spostati verso le città, i sacerdoti -che “sono al servizio delle comunità e non degli edifici”, sottolinea- li hanno seguiti.
Secondo Bartolomei, i processi di rigenerazione di questi spazi abbandonati dovrebbero basarsi sulla partecipazione delle comunità locali e sulla considerazione dei desideri della società civile. “In questo processo, per il quale manca ancora un dialogo tra le istituzioni, le chiese potrebbero condensare nuove economie in una società in trasformazione”. Sara Marini, professoressa presso il dipartimento di Culture del progetto dello Iuav di Venezia e autrice di un libro sulle chiese chiuse veneziane in uscita in primavera, aggiunge a questa riflessione la relazione tra abitanti e turisti.

“In una città abitata da 50mila persone e attraversata ogni anno da 30 milioni di turisti, occorre riflettere sulla condizione del visitatore come cittadino temporaneo, per costruire insieme il futuro della città”. Venezia è “un caso rilevante” secondo Marini per la sua densità di chiese in disuso. “Il fatto che questo patrimonio sia in centro storico, visibile a tutti, in alcuni casi ha reso la rigenerazione più semplice”. L’autrice definisce il suo testo “una guida paradossale” attraverso trenta chiese prevalentemente “chiuse”, dove non si pratica più il culto, diverse per dimensione, stato di conservazione, proprietà (della Curia, del Comune o di privati) e uso. “Non tutte hanno sempre la porta chiusa: possono avere degli usi saltuari, ad esempio come magazzini, o permettere l’accesso pubblico molto limitatamente. Quando però gli abitanti ne vedono la porta socchiusa, provano a entrare, incuriositi o perché hanno una memoria di quei luoghi”.
Secondo don Valerio Pennasso, per avvicinarsi a una stima delle chiese in Italia “bisognerebbe moltiplicare per due o tre volte gli oltre 65mila edifici censiti”
L’uso di questi beni, secondo Marini, è il grande tema: “Questi monumenti sfidano l’eternità: come possiamo noi proporne un uso virtuoso, a tempo determinato?”. Alcuni dei casi veneziani ospitano mostre temporanee: chi nel 2015 ha visitato la chiesa di sant’Andrea della Zirada, rimasta chiusa per vent’anni, sarà rimasto sorpreso nel trovare l’interno allestito con dei frigoriferi, in occasione di Expo. Nella chiesa di san Barnaba, di proprietà della Curia, è invece allestita un’esposizione permanente di modelli delle macchine di Leonardo Da Vinci, riprodotte dall’azienda fiorentina Matart. “San Barnaba è molto vicina alle Gallerie dell’Accademia, dove possiamo vedere le opere originali di Da Vinci -osserva Marini-. In una città dove tutto è museo, i cittadini perdono spazi comuni e manca una progettualità condivisa e partecipata”.

L’ex convento dei santi Cosma e Damiano, alla Giudecca, è stato ristrutturato dal Comune per ospitare attività di artigianato artistico, residenze teatrali e l’archivio dedicato al compositore Luigi Nono, nella chiesa, che in passato ha ospitato anche un opificio, è stato insediato un incubatore d’imprese oggi vuoto. La chiesa di san Fantin, di fronte al Gran Teatro La Fenice, è in ristrutturazione con un progetto di riutilizzo in chiave culturale, funzionale al Teatro; e la chiesa sconsacrata di san Lorenzo -che è stata sede del padiglione del Messico durante la Biennale- è stata data in convenzione dal Comune alla fondazione Thyssen-Bornemisza, che la sta restaurando per dedicarla poi a usi culturali ed espositivi. “Le chiese custodiscono ovunque usi stratificati e il caso veneziano è solo un pretesto per guardarsi attorno nelle proprie città e accorgersi che questi spazi, per essere ritrovati davvero, hanno bisogno della sinergia tra molti soggetti. Per farli vivere, dobbiamo ricostruire l’assemblea, riaprendo le porte per una condivisione con gli abitanti”.
Anche Fabiana Susini, storica dell’arte, condivide questo approccio. Con il suo libro “Chiese non più chiese. Inediti itinerari pisani tra sacro e profano” (uscito per i tipi di Aracne lo scorso dicembre), propone un percorso attraverso la città di Pisa, lungo le tracce dei monumenti religiosi che oggi sono dedicati ad altri usi. “Dobbiamo avere coscienza di questo immenso patrimonio culturale: a Pisa ci sono oltre 100 chiese; alcune oggi sono obsolete, altre sono state riutilizzate -dice-. In molti casi sono diventati spazi comuni: ospitano attività che accolgono e coinvolgono la comunità, tornando -in un certo senso- alle origini”. È il caso della chiesa sconsacrata di sant’Andrea fuoriporta, che ospita il teatro omonimo; o di alcune chiese convertite a nuovi usi dall’Università di Pisa, come san Paolo all’orto, dove si trova la gipsoteca di arte antica, o l’ex chiesa di sant’Eufrasia, dove c’è una biblioteca. “Purtroppo gli studenti non si rendono conto di dove si trovano. Un coinvolgimento dei cittadini potrebbe partire anche dalla condivisione del racconto della storia di questi luoghi. Un aspetto che ancora manca, ma fondamentale per restituire questi spazi alle comunità”.
© riproduzione riservata