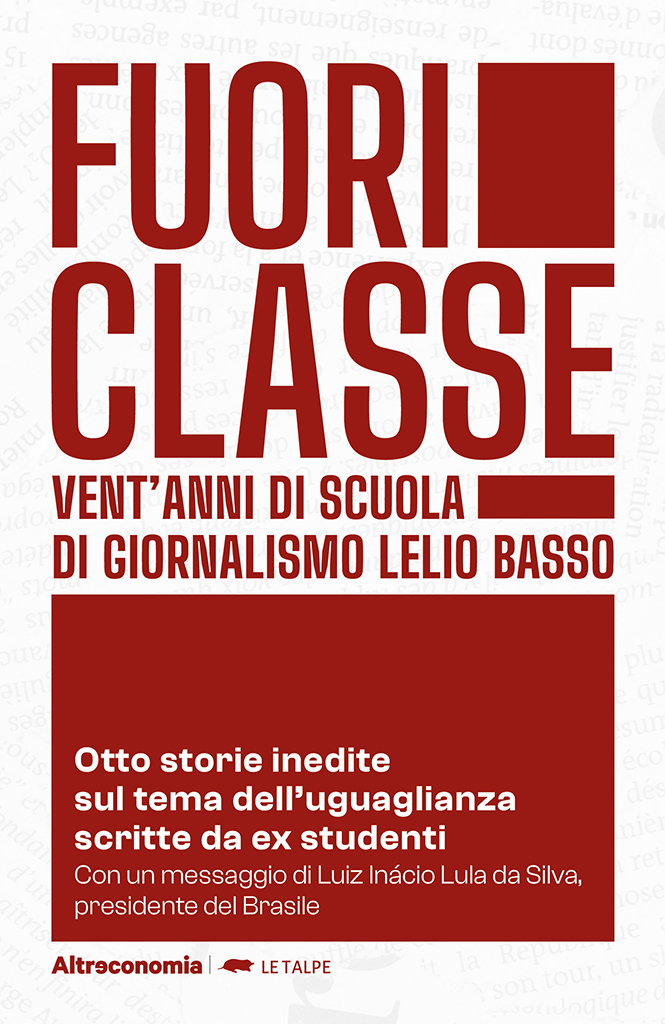Cultura e scienza / Opinioni
Il patrimonio culturale non è una macchina da soldi

Serve invece a ritrovare la nostra umanità, il rapporto con la natura e le città. Per capirlo, può bastare una passeggiata a Piazza Navona. La rubrica di Tomaso Montanari
In un articolo apparso sul Corriere della Sera il 5 settembre 1968, Cesare Brandi descrive la sua esperienza di una sera in Piazza Navona, a Roma. Una Piazza Navona appena liberata dalle automobili, che gli risveglia la memoria del Campo della sua Siena. Solo in qualche passaggio di un grande scrittore dell’Italia del Novecento, Carlo Levi, ho trovato una risposta tanto profonda, empatica e risolutiva alla domanda che gli addetti ai lavori (giuristi, soprintendenti, storici dell’arte, politici…) evitano accuratamente di porsi: “A cosa serve davvero il patrimonio culturale?”.
Rispondere a questa domanda sarebbe la necessaria premessa per costruire una qualsivoglia politica del patrimonio culturale e del turismo. Come tutti sappiamo, oggi questa politica consiste sostanzialmente in quella che si chiama, con retorica ipocrisia, la “valorizzazione”. Che sostanzialmente significa che siamo noi a dover trovare senso, funzione, valore al patrimonio. E che questa funzione è quasi sempre commerciale, estrattiva: economica. Cito una fonte recente, e autorevole: il Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) del governo Draghi: “Il nostro Paese ha un patrimonio unico da proteggere: un ecosistema naturale e culturale di valore inestimabile, che rappresenta un elemento distintivo dello sviluppo economico presente e futuro”.
Ecco, la risposta di Brandi è all’opposto. Ed è straordinariamente liberatoria, rispetto a tutto questo. Perché vede nel patrimonio -inteso come spazio pubblico monumentale in cui vivere- un’apertura di senso radicalmente alternativa, e contrapposta, a quella della cieca concitazione della vita moderna: “Piazza Navona ieri sera, ed era lunedì, come un lago d’ombra, come quando nei secoli passati la facevano divenire un lago: ma ora non c’erano navi, c’era gente e tanta: gente seduta, gente in piedi. E conversavano […] Ci si poteva fermare, guardare, discorrere: ecco Sant’Agnese, così sfalsata rispetto alla Fontana dei Fiumi, si vedeva arrivare fino in fondo alla scalinata senza quella barriera d’automobili. […] Vedere e recuperare, mirando, il tempo remoto e quello nuovo, ricomporre il proprio essere avulso e sminuzzato dalle ore quotidiane, dal fracasso tecnologico. Né vale solo la campagna o la montagna o il mare per questo. La città, che è l’espressione stessa dell’uomo in quanto vive con l’uomo e fa civiltà e crea la cultura, la città deve anche poter sospendere l’uomo dal suo flusso ininterrotto di affanni e di lavori forzati. […] Ecco la mia giornata, arrivata a sera col vestito grinzoso, le scarpe impolverate, la camicia sudata: giungo qua e mi siedo, guardo la piazza e quasi non la vedo è come se fossi in un’infusione di riposo. Questo riposo mi penetra e il silenzio mi fascia di bende invisibili. Torno a vedere, e vedo Sant’Agnese del Borromini o la Torre del Mangia: vedo quello che sopravvive dell’uomo che vive nell’uomo, senza corrompersi e senza tradimento. […] Ritrovo l’unisono con una natura che è passata attraverso l’uomo e attraverso la storia, odo il respiro di questa natura perché non odo nulla, e non vedo che l’aria limpida e serena. Eppure, odo e vedo, ed è come se fosse una festività ignota qualcosa come un indulto, una sospensione, un miracoloso arresto: né il tempo trascorresse, né la vecchiaia, avanzasse, anzi ritornasse il passato come una giovinetta”.
Ritrovare la propria umanità, recuperare la comunione con la città e con la natura, contestare la dittatura del presente e della morte. Ecco a cosa serve il patrimonio culturale.
Tomaso Montanari è storico dell’arte e saggista. Dal 2021 è rettore presso l’Università per stranieri di Siena. Ha vinto il Premio Giorgio Bassani di Italia Nostra
© riproduzione riservata