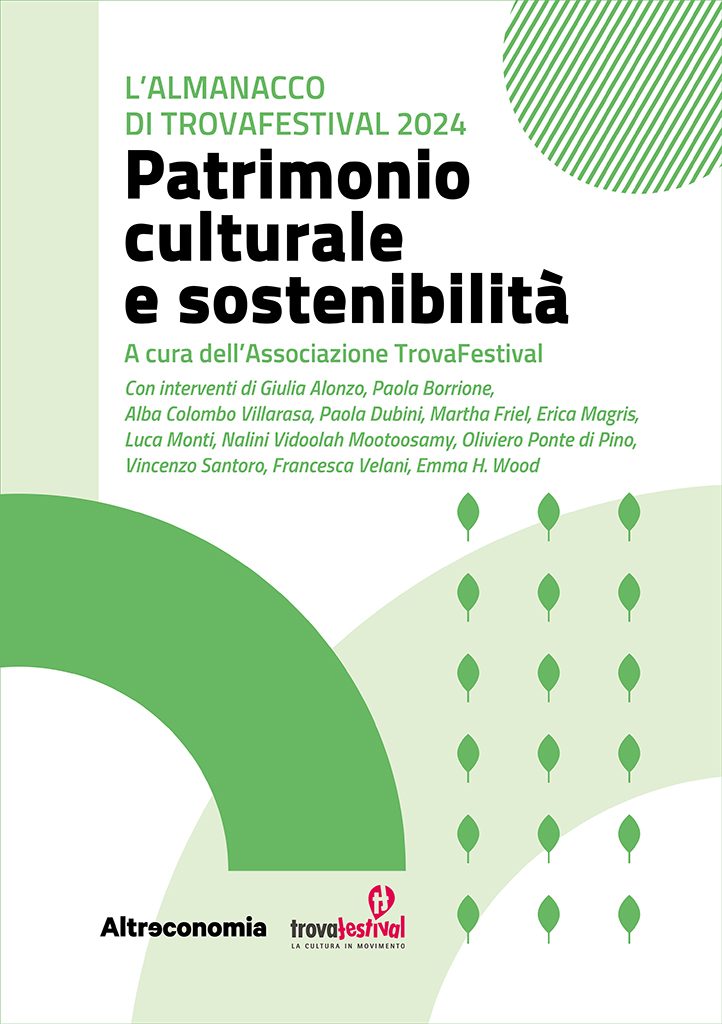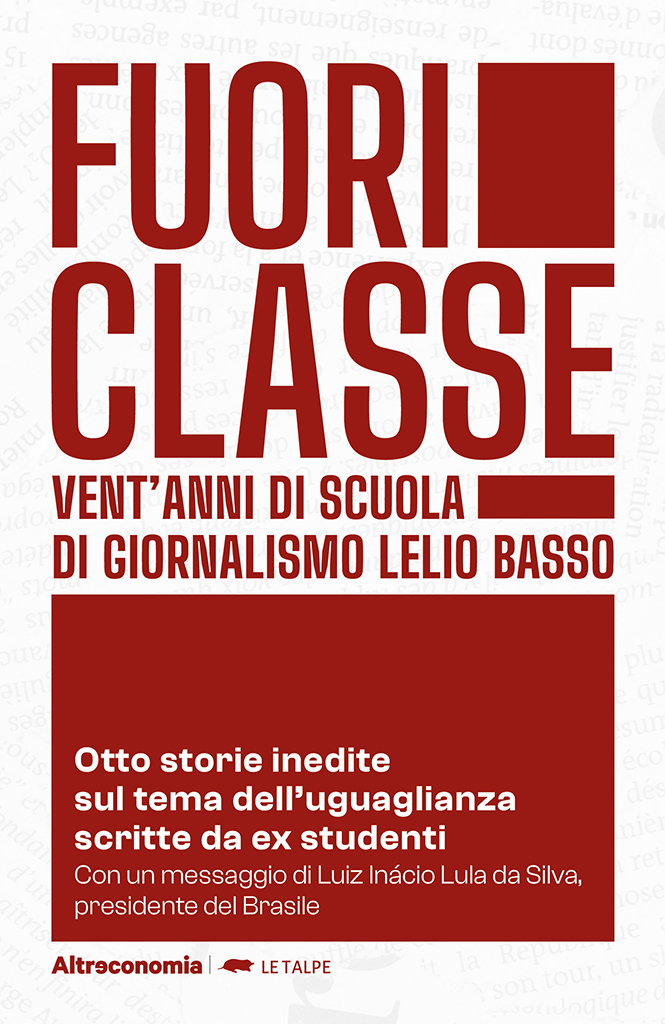Cultura e scienza / Intervista
Alice Rohrwacher. Un cinema irresponsabile

Tratta da una lettera di Elsa Morante a Goffredo Fofi, l’ultima opera di una delle nostre principali registe è un inno alla disobbedienza delle “bambine cattive”. In alcuni tra i suoi film più riusciti ha affrontato la fine della cultura contadina
Ci si lamenta spesso dello stato del cinema italiano -da un punto di vista artistico e produttivo, per non parlare della sua fruizione in sala- tanto da non saper riconoscere una grande interprete, quando ce l’abbiamo sotto gli occhi. È il caso di Alice Rohrwacher, una delle artiste più interessanti e originali a livello internazionale e precoci, avendo all’attivo appena tre film, due dei quali (“Le meraviglie” e “Lazzaro felice”) hanno vinto rispettivamente il Gran premio della giuria e quello della sceneggiatura a Cannes. Per capirci Nanni Moretti, Matteo Garrone e Paolo Sorrentino possono vantare gli stessi riconoscimenti e qualche Oscar, ma in più anni di cinema e molti più film dalle mega produzioni.
Rohrwacher sconta, soprattutto per i media mainstream, il fatto di essere una donna, di essere originaria di una piccola Regione (l’Umbria), di avere un cognome straniero (il padre è un apicoltore trasferitosi da giovane in Italia dalla Germania) e di essere sorella di un’attrice affermata, Alba, con la quale lavora spesso. Dopo l’esordio nel 2011 con “Corpo celeste”, Rohrwacher ha realizzato diversi cortometraggi e documentari tra cui “Futura” con Pietro Marcello e Francesco Munzi. Quest’anno il suo corto “Le pupille” è stato candidato all’Oscar. Vede nel cast Valeria Bruni Tedeschi, Alba Rohrwacher e un notevole gruppo di attrici e attori non professionisti. Il cortometraggio -un’apologia della disobbedienza che ricorda “La ricotta” di Pasolini- è ispirato a una lettera che la scrittrice Elsa Morante spedì nel 1971 al suo amico Goffredo Fofi, raccolta in “L’amata. Lettere di e a Elsa Morante” (Einaudi, 2012). Racconta un aneddoto vero di guerra avvenuto in un orfanotrofio; una storia di Natale, di fame, di disobbedienza e provvidenza allo stesso tempo.
La corrispondenza tra la grande scrittrice e l’intellettuale militante dei “Quaderni piacentini” ci restituisce il Sessantotto, i suoi conflitti, il suo carico ideologico. Un’epoca lontana e molto più utopistica della nostra. Perché hai voluto rappresentarla?
AR Elsa Morante scrisse questa lettera ispirata dalla ribellione del ‘68, la ribellione dei “cattivi ragazzi”. Ho deciso di ambientare la storia al femminile perché mi sembra che se ci può essere una ribellione nella nostra epoca, è rappresentata dalle “cattive ragazze” che ovunque nel mondo stanno lottando. La mia speranza è che possano essere anche loro “irresponsabili”, per rompere un sistema in cui la responsabilità frena ogni possibilità di scompigliare le carte, ridefinire i valori, ridistribuire la ricchezza. Nel film la protagonista, la bambina Serafina, dice: “Io sono cattiva”. Ma la cattiveria è qualcosa che le è stato affibbiato dal potere: è la madre superiora a definirla tale. Questo è un altro elemento che ho aggiunto al bellissimo racconto di Elsa Morante: la bambina non è “cattiva” per natura, ma viene definita tale dall’alto. Quindi che altro deve fare se non essere coerente con la qualità che le è stata affidata e distruggere i piani utilitaristici della madre superiora? Vedo quindi una possibilità nella coerenza, nell’irresponsabilità che stranamente ne deriva. Oggi, le “cattive ragazze” non vogliono esserlo, ma si riconoscono come tali per come vengono trattate dalla società, e non possono fare altro se non comportarsi davvero da “cattive ragazze”.
Nel racconto di Morante e nel film si parla di una torta spropositata: una zuppa inglese bellissima, desiderata da tutti, che può essere paragonata a tante cose nel mondo contemporaneo. Che cosa è la torta oggi? Le nostre risorse ad esempio, il futuro del nostro Pianeta. Tutti vogliono tenerlo per sé, proprio come la religiosa: dicono che in nome di “alte” motivazioni (per lei le ingiustizie sociali e il pensiero di Gesù) hanno il sacro diritto di tenerlo tutto per sé e gestirlo dall’alto. Le bambine invece vorrebbero consumarlo, mangiarlo: anche loro sono preda di un desiderio scomposto, ma tuttavia più vitale. Mentre fuori dal collegio ci sono gli esclusi, i vagabondi e gli spazzacamini, i cagnacci che neanche sanno dell’esistenza di questa torta: ma è a loro che la storia l’ha destinata. Elsa Morante dice, come se fosse una morale: “Le vie del Signore sono infinite”. Ho sostituito “Signore” con “destino”, più adatto al mio spirito. In ogni caso, il destino fa sì che questa torta venga spezzata e finisca nelle mani dei più miseri e poveri. Ma qualche briciola anche nelle bocche delle bambine.
Che discorso avresti fatto se avessi vinto l’Oscar?
AR Non so più che cosa avrei detto o fatto, avevo delle idee ma ho paura che nel momento avrei anche potuto dire qualcosa di irresponsabile. Quindi meglio così. Tutti i discorsi di ringraziamento che ho sentito hanno celebrato il privato, la famiglia, i genitori, i figli. Ecco, se avessi ringraziato mio padre avrei detto: “Al primo femminista della mia vita, mio padre”. In ogni caso mi sarebbe piaciuto dedicare la vittoria alle ragazze in lotta in questo momento nel mondo, che stanno soffrendo delle violenze inaudite sotto i nostri occhi occidentali. In ogni caso, mi sembra che gli artisti siano diventati troppo responsabili, persino la controcultura è responsabile. Tutti attenti a quello che bisogna o non bisogna dire, forse più attenti alle parole che alle azioni.
Viviamo in un’epoca dove c’è un controllo totale sui termini che scegliamo, su come ci mostriamo. E forse la nostra maggiore difficoltà è proprio questa, la stessa che mette in crisi la madre superiora nella mia storia: perdere il controllo. Oramai anche i film guardati in streaming, sono oggetto del nostro controllo: possiamo interrompere quando vogliamo, andare avanti, indietro. Ci sembra di avere tutto in mano. L’immagine che diamo di noi stessi, è totalmente controllata. Ma in agricoltura si insegna che proprio quando si sente di avere il controllo su tutto, arriva la catastrofe. E gli artisti hanno iniziato a controllarsi troppo, hanno smesso di essere irresponsabili. Questo piccolo film che ho diretto è un inno all’irresponsabilità, è un inno alla cattiveria scanzonata, è un inno, appunto, alle torte che si fanno in mille pezzi.

Tu vivi nell’Altopiano dell’Alfina, in Umbria al confine con Lazio e Toscana. In questi anni, oltre a dedicare due film a questo territorio (“Le meraviglie” e “Lazzaro felice”), ti sei impegnata contro la monocoltura delle nocciole e nei comitati territoriali contro le multinazionali, tra cui Ferrero. Come è andata avanti la lotta?
AR Da persona nata negli anni Ottanta, ho assistito con i miei occhi a un grande cambiamento della campagna, probabilmente perché vengo da un’area marginale. Grazie al vuoto che ha lasciato la fine dell’agricoltura tradizionale, poche multinazionali o grandi aziende si sono accaparrate la maggior parte dei terreni per portare avanti progetti agricoli per niente legati alla vera vocazione di un territorio e al benessere di chi lo abita. Alcuni progetti portano anche delle ricchezze, ma quando parlo di benessere penso a qualcosa di più grande: ad avere una buona vita, una comunità di riferimento, potersi scambiare delle cose, poter appartenere ancora a qualcosa e accogliere gli altri.
Questi progetti calano dall’alto e in qualche modo ci rendono “cattivi”: si tratta di colture intensive dei magnati dell’agroindustria, da noi ad esempio noccioleti intensivi, oppure progetti di sfruttamento energetico che non nascono localmente ma che vengono imposti. Ma non si può vedere nella terra e nell’ecosistema una cava da cui estrarre soldi e denaro. Fino a che non si sviluppa una coscienza della complessità degli ecosistemi, fino a che la progettualità di un territorio non viene condivisa con chi lo abita, si farà sempre il bene di pochi e il male di molti.
Adesso ad esempio si specula anche sulle energie rinnovabili, che dovrebbero essere una cosa bella per tutti, ma si sono trasformate in un sinistro campo di battaglia per branchi di speculatori e imprenditori perché adesso i soldi sono lì. Di nuovo, non si aiutano i piccoli a rendersi autonomi da un punto di vista energetico, ma si finanziano i grandi magnati per distruggere un territorio riempiendo ettari di terra fertile di centinaia di pannelli solari o mega-impianti eolici che forse neanche entreranno mai in funzione. Mi si spezza il cuore. Purtroppo, parole come “resilienza” e “green economy” vengono usate in una maniera del tutto utilitaristica. Il fine ultimo è sempre il guadagno di pochi e l’impoverimento di tanti.
“Mi sembra che se ci può essere una ribellione in questa nostra epoca, è rappresentata dalle ‘cattive ragazze’ che ovunque nel mondo stanno lottando”
L’economia, la ricchezza e la povertà, sono temi ricorrenti nei tuoi film. Visto che siamo partiti dall’utopia del Sessantotto, che cosa faresti oggi?
AR Basterebbe mettere un limite alla ricchezza e alla povertà. Una soglia anche alta, come un vaso quando è troppo pieno, a un certo punto è colmo. Poi basta. Non possiamo vivere in un mondo dove un uomo solo, se vuole, può arricchirsi all’infinito. Dobbiamo riuscire a spezzare questa torta. E probabilmente ridefinire delle scale di valori quando usiamo parole come “successo” o “sviluppo”. Ricordo che durante un viaggio in Calabria, sull’Aspromonte, la prima domanda che mi facevano gli anziani era: “A chi appartieni?”. Inizialmente mi offendevo, mi sembrava che a loro non interessasse chi fossi, ma solo di chi ero, fraintendevo questa domanda per un’eredità patriarcale: “A chi appartieni come donna?”. In realtà solo molti anni dopo ne ho capito il vero significato, ovvero: “Chi sono le tue genti?”.
Una domanda bellissima, perché nell’altro io non vedo un individuo, ma un gruppo che lo ha formato, un insieme di educazione, somiglianze, sangui, nature. Rapidamente si è prima passati a relazionarsi al prossimo con un’altra domanda, quella forse a cui siamo da sempre abituati: “Che cosa fai?”. Perché il tuo sapere, la tua abilità, la tua professione a un certo punto ha definito l’individuo più delle sue genti. E adesso sembra che questa domanda si sia evoluta in: “Quanto guadagni?”. Quindi non importa più neanche il tuo sapere né le tue qualità o quello che sai fare. Ecco, forse dobbiamo iniziare a cambiare questa domanda e trovarne una nuova, che ci definisca sia come individui sia come gruppo umano, che ci permetta di esistere ma anche accogliere l’altro, di offrire sempre una fetta di torta a chi viene inaspettatamente a trovarci.
© riproduzione riservata