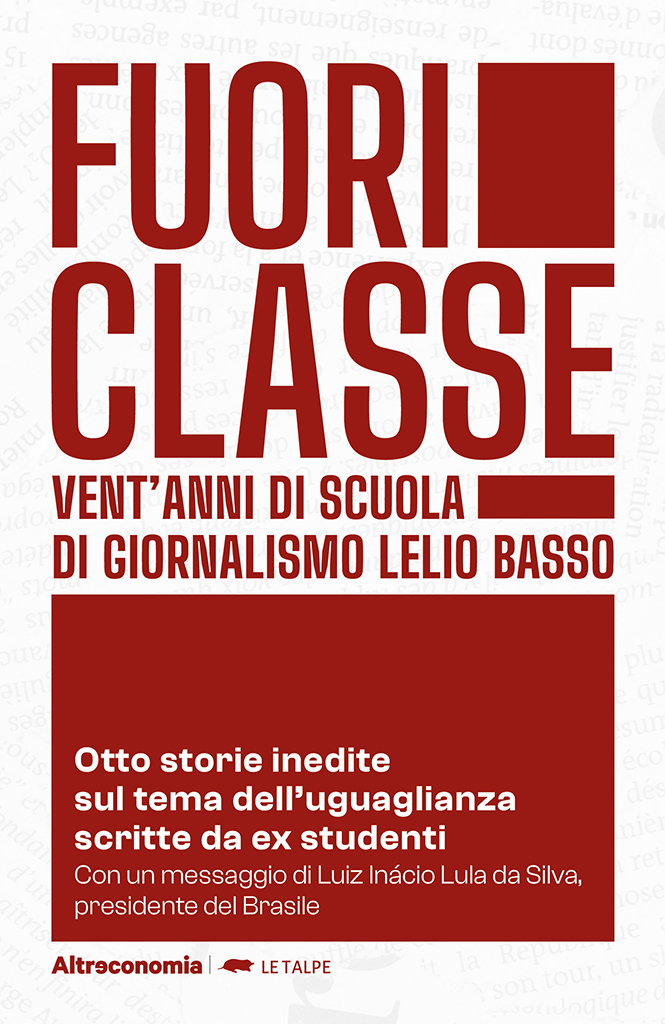Cultura e scienza / Attualità
Massimo Rossi. Il confine è una faccenda umana

La geografia si occupa di relazioni sociali, raccontando la memoria storica dei luoghi e le comunità. Ma nella storia dell’uomo è stata piegata da interessi militari o desideri di potenza
“La geografia si occupa di capire le relazioni tra le comunità insediate e i luoghi che abitano, e rappresenta una grande opportunità per mettere in contatto la memoria storica, le caratteristiche peculiari di una determinata area, e il segno dei progettisti di oggi, coloro che immaginano nuovi interventi”. Il professor Massimo Rossi insegna Geografie del territorio contemporaneo all’Università IUAV di Venezia, e da vent’anni è il responsabile della cartoteca della Fondazione Benetton Studi Ricerche di Treviso. “Non credo che il geografo sia uno scienziato -spiega-: il nostro lavoro è sempre influenzato dal contesto storico in cui siamo chiamati a lavorare. Tutte le cartografie -forme di rappresentazione e ‘traduzione’ della superficie terrestre- sono costruzioni sociali”.
In che modo l’idea dell’esistenza di “confini naturali” è un esempio di processo sociale?
MR C’è un grande equivoco: la natura non può essere consapevole di rappresentare un confine. Non c’è discontinuità in natura: nella mostra che ho curato per la Fondazione (“La geografia serve a fare la guerra?”) ho inserito una fotografia del “confine” tra lo Stato di Washington, nel Nord-ovest degli Stati Uniti, e la provincia di Manitoba, nel Canada occidentale, per mostrare come esso tagli a metà una foresta. Anche il confine tra Libia ed Egitto è un bel bidone in mezzo al deserto. Se pensiamo ai confini Nord americani, che si appoggiano a latitudine e longitudine, o a quelli africani, disegnati a tavolino, ci rendiamo conto che il confine è sempre una faccenda umana. La cartografia è responsabile di tracciare una linea, e far vedere il confine: l’idea che esista una linea che divide due civiltà, due culture, però, può diventare rischiosa. Perché se la natura è neutrale, e innocua, essa non può aver assegnato ad alcun popolo il compito di espandersi fino ad occupare un determinato ambito geografico, come ha immaginato di fare l’Italia ai tempi della Prima Guerra mondiale. Nel programma di Vittorio Emanuele III era precisata la richiesta ai soldati di arrivare “a piantare il tricolore d’Italia sui termini sacri che la natura pose ai confini della patria nostra”, e cioè sulle Alpi: un’idea basata sulla teoria geografia del displuvio, per cui tutti quei versanti che alimentavano fiumi il cui bacino idrografico li portasse a sfociare nel Mar Mediterraneo fossero di pertinenza italiana.
La Grande Guerra c’insegna qualcosa anche in merito all’importanza di “nominare” i luoghi. Che cosa raccontano i toponimi?
MR Il potere. La capacità di nominare i luoghi è spesso l’esito di processi violenti, e “battezzare” un luogo è la prima cosa che fa chi vuole manifestare la propria supremazia. Pensiamo a New York: è il toponimo scelto dagli inglesi dopo aver allontanato gli olandesi, ovvero coloro che avevano fondato la città di New Amsterdam, mentre il nome indigeno di quell’area è scomparso. In Italia, invece, tra il 1917 e il 1918 “la Piave” ha cambiato sesso: non si poteva opporre all’avanzata del nemico qualcosa di muliebre, poco virile, e così da allora il fiume è “il Piave”. Nel lavoro del cartografo, oltre ai “nomi” sono importanti anche altre scelte, quelle relative al corpo del carattere, alle scale, ai colori. Credo che il geografo, cioè colui che ha la capacità grafica di inserire i toponimi sulle carte, debba saper dialogare con esperti di altre discipline, afferenti alle scienze sociali -come l’antropologia, la sociologia, la storia- e alle scienze pure, come la matematica: tutto ciò che aiuta a raccontare il rapporto tra comunità e luoghi. Le prime dovrebbero nominare i secondi.
Qual è stata una fase nella Storia contemporanea in cui l’assenza di un contributo da parte dei geografi ha pesato sul risultato finale di un processo politico in corso?
MR Senz’altro la Conferenza di pace di Parigi, che si tenne nel 1919 alla fine della Prima Guerra mondiale. Le delegazioni degli Stati Uniti, della Francia e dell’Inghilterra arrivarono accompagnate da grandi geografi, mentre nella delegazione italiana non ce n’era nemmeno uno. Sarebbe stata una presenza estremamente utile, di fronte al piano del presidente degli Stati Uniti, Thomas Woodrow Wilson, di creare le Nazioni a partire dall’identificazione di comunità etnico-linguistiche. Per quanto riguarda l’Italia, in quel contesto prevalsero invece gli interessi dello Stato Maggiore dell’Esercito, e in una logica militare il confine venne fissato al Brennero, anche se dal punto di vista di un’analisi di tipo etnico-linguistica quella scelta si prestò ad ambiguità. Un geografo poco studiato e riconosciuto, Cesare Battisti (ucciso nel 1916, ndr), aveva individuato nel territorio che oggi conosciamo come Alto Adige ben sei possibili confini: quello dato dallo spartiacque; quello etnografico; quello politico; quello individuato dall’organizzazione delle Diocesi; quello definito dal Dipartimento dell’Alto Adige di Napoleone; quello amministrativo con il Trentino. Ognuno tra questi ha una valenza storica, ma prevale la visione militare: dobbiamo porci un obiettivo da raggiungere, il Brennero, senza se e senza ma. Vincono i nazionalisti, e da lì a poco si passa al fascismo. Ancora oggi, l’Ufficio cartografico della Provincia autonoma di Bolzano invia una carta tecnica priva di toponimi, perché la toponomastica è un problema politico. Tutt’al più, in seguito a una ulteriore richiesta, mandano due file: uno contenente tutti i toponimi in italiano, e l’altro in tedesco.
Architetti, urbanisti, scienziati del territorio partecipano alle discussione sulla trasformazione del paesaggio. E i geografi?
MR In altri Paesi, come ad esempio in Francia e in Olanda, quando ci sono progetti per la costruzione di nuove infrastrutture un geografo fa parte delle commissioni che ne analizzano i possibili impatti. Il geografo, infatti, si occupa anche della memoria storica dei luoghi, dialogando con i paesaggisti: in Europa siamo in grado di documentare un luogo dal Quattrocento, quando se ne fecero le prime rappresentazioni cartografiche, fino a ieri, quando abbiamo scattato l’ultima foto grazie a un drone, a un aereo o a un satellite; possediamo una stratificazione di mappe, foto, narrazioni, che devono arrivare anche sul tavolo della progettazione futura. L’inclusione della geografia offrirebbe questa opportunità di dialogo.
Ciò permetterebbe anche di evitare errori.
MR Interventi che portano all’irriconoscibilità del luogo stesso generano difficoltà di continuare a capire dove abito e chi sono. Dopo gli Accordi di Dayton, che nel 1995 posero fine alla guerra in Bosnia ed Erzegovina, dividendola in tre comunità etnico-religiose, bosgnacchi (bosniaci musulmani), cristiani ed ortodossi utilizzano tre cartografie e tre narrazioni storiche diverse. Questo è uno dei motivi che spiegano perché quella vicenda non sia affatto chiusa.
“La geografia serve a fare la guerra?” è il titolo della la mostra curata da Massimo Rossi per la Fondazione Benetton Studi e Ricerche (fbsr.it). Fino al 17 febbraio 2017 a Treviso, in via Cornarotta 7-9
La mostra che ha curato per la Fondazione Benetton s’interroga se la geografia serva a fare la guerra. Perché?
MR Sappiamo che è l’uomo che fa la guerra, usando tutti i saperi a sua disposizione: la chimica, la fisica, la storia, la linguistica, la matematica e anche la geografia, che attraverso la griglia di latitudini e longitudini offre l’opportunità di colpire obiettivi. Il titolo riprende quello di un pamphlet del 1976, di Yves Lacoste, un geografo marxista francese: “La geografia serve, principalmente, a far la guerra”. Lacoste era riuscito a scoprire la strategia dei bombardamenti americani in Vietnam, che minavano la stabilità delle dighe senza abbatterle, lasciando che ciò accadesse durante la stagione dei monsoni, allagando villaggi e distruggendo risaie. Oggi non abbracciamo la visione marxista del mondo, e abbiamo inserito un punto interrogativo: la risposta alla domanda, infatti, è ambivalente, perché è sempre l’uomo a scegliere come usare i saperi, geografia compresa. Per questo abbiamo voluto inserire in mostra alcune opere d’arte che avessero una funzione taumaturgica, per cambiare “scala”: se guardiamo la prima foto del Pianeta Terra scattata dall’Apollo 17, nel 1972, possiamo riflettere sul rapporto tra l’uomo e il mondo, visto da lontano. È un esercizio geografico.
© riproduzione riservata