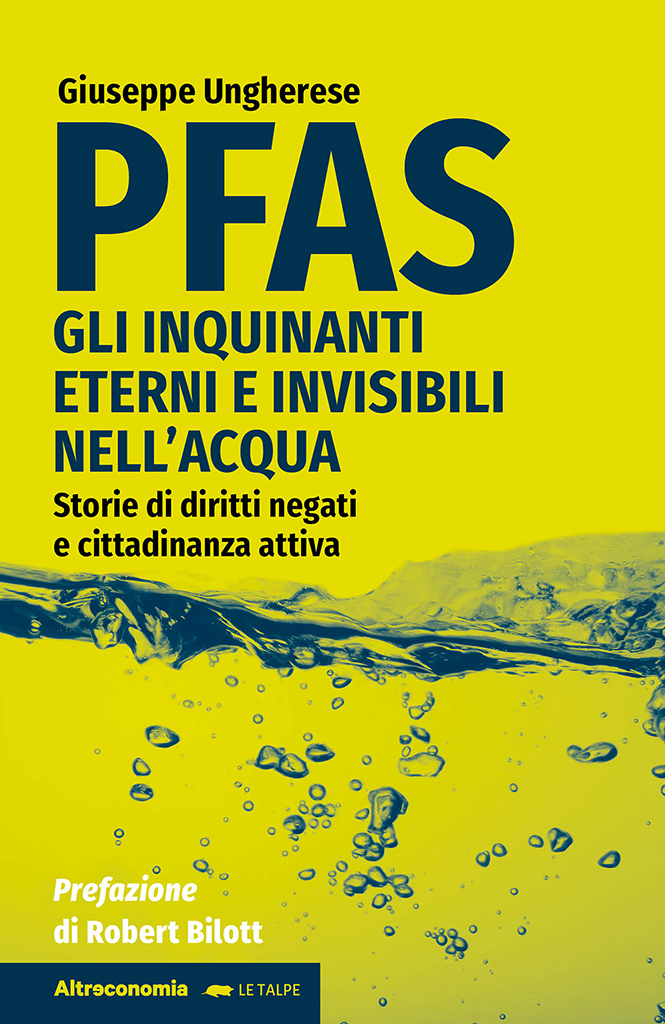Ambiente / Attualità
Gli sfollati interni e quegli eventi estremi che minacciano l’abitabilità dei territori

Da qui al 2100 potrebbero esserci 50 milioni di sfollati ogni anno solo a causa delle inondazioni. “Miglioramento delle infrastrutture, pianificazione urbana, riforme agrarie, riduzione del rischio di disastri e adattamento al cambiamento climatico sono solo alcuni degli ambiti in cui si può intervenire”, spiega Alexandra Bilak, direttrice dell’Internal Displacement Monitoring Centre
Entro la fine del secolo 50 milioni di persone potrebbero essere sfollate ogni anno solo a causa delle inondazioni. È quanto emerge da un recente studio dell’Internal Displacement Monitoring Centre (IDMC), centro di ricerca e monitoraggio che studia il fenomeno degli spostamenti interni ai Paesi dovuti a conflitti e disastri naturali, pubblicato nel dicembre 2019. L’esito sarebbe certo se non si intervenisse per ridurre le emissioni di gas a effetto serra. Anche se, come spiega ad Altreconomia Alexandra Bilak, direttrice del centro di ricerca IDMC, “qualora fosse implementato l’Accordo di Parigi del 2015”, e si riuscisse quindi a mantenere l’aumento della temperatura media globale entro 1,5°C, “il numero di profughi attualmente sfollati a causa delle alluvioni raddoppierebbe comunque”.
Già parte della Taskforce on displacement della Conferenza delle parti dell’ONU (COP) sui cambiamenti climatici, a partire dal 2020 l’IDMC è stato chiamato a partecipare all’UN High-Level Panel on Internal Displacement dal Segretario Generale delle Nazioni Unite António Guterres, per elaborare entro un anno un piano realistico per prevenire le migrazioni interne e mitigarne gli effetti.
L’ultimo documento pubblicato dall’IDMC costituisce il primo studio degli impatti dei cambiamenti climatici sugli spostamenti delle popolazioni. La ricerca si focalizza sulle alluvioni perché sono la causa prevalente di sfollamenti interni dovuti a disastri nel mondo. Oggi, infatti, “gli sconvolgimenti del clima costringono decine di milioni di persone a scappare dalle loro case ogni anno. La metà dei casi riguarda alluvioni, per un terzo si tratta di tempeste”, riporta lo studio dell’IDMC. Secondo le mappature dell’organismo di ricerca, l’Africa sub-sahariana, il Sud-Est asiatico, l’Oceania e l’America Latina sono le zone più vulnerabili agli eventi climatici estremi e registrano la più alta concentrazione di persone esposte alle inondazioni. I cinque Paesi con il maggior rischio di sfollamento sono l’India, la Cina, il Bangladesh, il Vietnam e le Filippine.
Il centro di monitoraggio ogni anno pubblica il Global Report of Internal Displacement. Secondo l’ultimo rapporto, nel 2018 ci sarebbero stati 28 milioni di nuovi sfollati interni, il più alto numero mai registrato. Il 60% di queste migrazioni forzate è causato da fenomeni ambientali: eventi geofisici, come terremoti ed eruzioni vulcaniche per il 13% e, molto più frequentemente, fenomeni meteorologici come alluvioni e siccità (87%).
“Alla fine del 2018 -continua Alexandra Bilak- gli sfollati interni a causa di conflitti e disastri erano 41,3 milioni, 25,9 milioni i rifugiati. Ciò significa che tra coloro che sono costretti a abbandonare la propria casa circa sei persone su dieci rimangono all’interno del proprio Paese. Gli sfollati interni spesso perdono la totalità o quasi dei loro beni prima di spostarsi e sono quindi tra le persone più vulnerabili dei Paesi più poveri”.
Un esempio è quello somalo-etiope. “Le migliaia di sfollati a causa della siccità del 2015-2017 nella regione somala erano pastori, i cui beni più preziosi erano i loro animali. Perdendo il loro bestiame a causa della siccità, hanno perso tutto”.

Il Comitato per i Diritti Umani dell’ONU si è pronunciato il 21 gennaio scorso affermando che i profughi che rischiano la vita a causa degli effetti del cambiamento climatico non possono essere respinti. Questa decisione apre le porte a un possibile futuro riconoscimento giuridico dei profughi ambientali. Ma ci sono diversi nodi da sciogliere.
A oggi, la persona costretta a spostarsi per motivi climatici non è protetta dalla Convenzione di Ginevra sui rifugiati, che tutela solo coloro che temono di essere perseguitati “per ragioni di razza, religione, cittadinanza, appartenenza a un determinato gruppo sociale o per opinioni politiche”. Inoltre, il rifugiato per definizione “si trova fuori dello Stato di cui possiede la cittadinanza”.
“Considerando che la maggior parte delle persone sfollate a causa di disastri a lenta insorgenza resta all’interno del Paese di origine, abbiamo bisogno di strumenti diversi. Creare un’altra categoria legale non necessariamente aiuterà”, sostiene Alexandra Bilak. Il lavoro di ricerca dell’Internal Displacement Monitoring Center è anche diretto a contribuire alla Nansen Initiative, progetto intergovernativo fondato nel 2012 dai governi di Norvegia e Svizzera e finalizzato non tanto a costruire nuovi standard legali, ma a fornire agli Stati degli strumenti utili a ridurre i rischi di sfollamento. “Miglioramento delle infrastrutture, pianificazione urbana, riforma agraria, riduzione del rischio di disastri e adattamento al cambiamento climatico sono solo alcuni degli ambiti in cui dobbiamo intervenire” conclude Bilak, invitando a consultare le numerose ricerche dell’IDMC.
Se la questione sui territori continentali è già piuttosto complessa, il caso delle isole del Pacifico è un problema ancora più grande. Secondo il rapporto intergovernativo delle Nazioni Unite sul rapporto speciale sui cambiamenti climatici sull’oceano e la criosfera in un clima che cambia dell’Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), è molto probabile che numerosi piccoli Stati insulari possano diventare inabitabili entro alcuni decenni a causa dell’innalzamento dei mari. Per diversi arcipelaghi del Pacifico, come Kiribati, Tuvalu e le isole Marshall, la situazione completamente inedita che si prospetta è quella di intere popolazioni che diventano apolidi perché il loro territorio non esiste più.
“Ad agosto 2019 il Pacific Islands Forum (PIF), il più importante raduno politico dei governi del Pacifico, si è focalizzato sul tema del cambiamento climatico”, racconta Nicola Manghi, dottorando all’Università di Torino che studia migrazioni e cambiamenti climatici a Tuvalu, arcipelago polinesiano e sede della 50esima edizione del PIF. Del forum fa parte anche l’Australia, “che nel contesto del Pacifico è ragionevolmente vista come la grande nemica della lotta ai cambiamenti climatici e quindi dei Paesi più vulnerabili”, a causa delle politiche energetiche sul carbone e del negazionismo climatico della sua classe politica. Tuvalu è uno degli arcipelaghi più a rischio perché è formato da atolli molto bassi, a massimo cinque metri dal livello del mare. Che cosa succederà quando questo arcipelago verrà sommerso?
“L’espressione ‘rifugiati climatici’ è molto problematica per il caso dei tuvaluani, perché deresponsabilizza i Paesi occidentali che più pesantemente hanno contribuito al riscaldamento globale”, continua Nicola Manghi. “Inoltre, la categoria di rifugiato nasce per definire una condizione transitoria e sarebbe quindi inadatta per questa situazione priva di precedenti storici”. “I cambiamenti climatici -continua Manghi- minacciando l’abitabilità dei territori, mettono in crisi l’intera concezione della sovranità e della cittadinanza occidentale, che si basa sulla corrispondenza tra popolazione e territorio sovrano”.
Manghi cita il sociologo francese Bruno Latour -di cui ha curato una raccolta di articoli pubblicata nel novembre scorso dal titolo Essere di questa terra (Rosenberg&Sellier)- secondo il quale ci troviamo di fronte a una “crisi migratoria generalizzata”, perché non sono più solo le persone a migrare ma la terra che ci viene a mancare sotto i piedi.
© riproduzione riservata