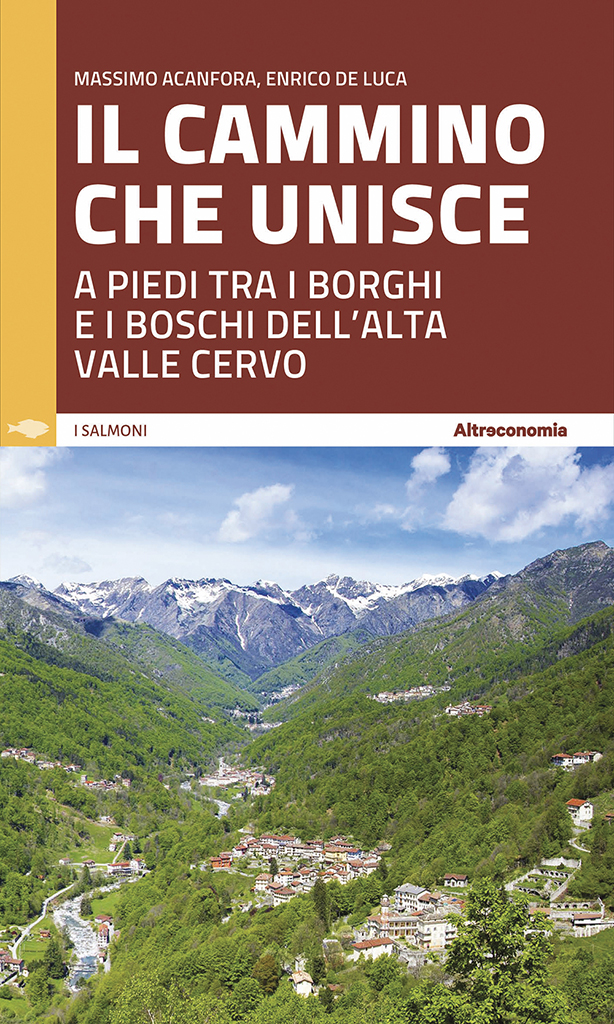Cultura e scienza / Opinioni
La seduzione della Rete che prevarica le prerogative della democrazia

Le multinazionali del web, sottratte a ogni forma di controllo, hanno costruito imperi plurimiliardari. Gli utenti incendiano emozioni trasformate in merce mentre gli Stati reagiscono blandamente allo strapotere di big tech. L’allarme di Roberto Settembre
Purtroppo dire a uno stupido che è uno stupido non lo farà diventare intelligente, ma mostrare il pericolo a chi rischia di diventarlo serve, perché la stupidità non è innata nella natura umana, essendo una pulsione che può venir contrastata.
La stupidità tuttavia ha un fondamento allettante, che allevia lo spaventoso fardello delle responsabilità quotidiane, una delle quali, mutuandola dalla “Vita activa” della filosofa politica Hanna Arendt, è la trasformazione dell’individuo da mero consumatore di opinioni indiscusse camuffate da notizia, in costruttore del pensiero critico.
Su tale assunto si innesta l’oggetto di queste righe incentrate sulla differenza di senso della comunicazione informativa, dove per senso si intendono la causa, la ragione, la direzione e il modo stesso del suo agire, e un’operazione peggiore della menzogna, l’inganno. Perché l’inganno, sotteso all’uso delle parole di per sé polisemiche, privo di spessore, attiva le parti superficiali delle capacità cognitive, cioè lo spazio della mente dove dilaga e impera la stupidità.
Ma fermiamoci: la parola stupido non è di per sé un’ingiuria; letteralmente significa stupefatto, sbalordito. La radice è “stupire”. Allarmano le sue conseguenze. Lo sbalordimento per la notizia e la stupidità accesa da un suo callido uso. Callido, non sapiente (per non offendere la sapienza), al fine di catturare non l’attenzione ma l’emozione, antitesi della riflessione strumento dell’analisi. Il punto è lo iato tra la notizia e il giudizio, che dev’essere colmato dall’analisi razionale, di per sé ardua da sviluppare e da penetrare.
Così entrano in conflitto la necessità della competenza e le ragioni della sua demonizzazione, che non sono innocenti, ma hanno uno scopo, soprattutto quando la notizia è impastata di una finta analisi che porta a un finto giudizio, tanto più tranchant quanto più lontano dall’analisi. Per questo motivo, oggetto del nostro discorso sarà una breve indagine su come la comunicazione agisca sui due mondi della conoscenza: quella destinata a innescarne altra, e quella finalizzata a esaltare se stessa, serva di manovre nemiche della democrazia razionale. Ciò non assolve l’informazione professionale che recentemente (ma accade sempre quand’è serva del potere) ha inseguito quell’altra.
Partendo da lontano, sta affiorando un legame tra il mondo greco antico e una possibile rinascita della funzione del linguaggio, parlato e scritto, come luogo della ragione. Nel V secolo a.c., al tramonto dell’oralità, Platone disse che nessun sapiente avrebbe dovuto ridurre la conoscenza alla parola scritta, che, essendo muta, impediva la ricerca della verità possibile solo nel dialogo.
Dopo quasi 2.400 anni questo pensiero si riaffaccia, ma per 24 secoli il trionfo della parola scritta ha accompagnato quello di istituzioni basate sul pensiero di pochi che domineranno la mente dei molti.
Attraverso milioni di pagine scritte la società umana vedrà totali sconvolgimenti. Ma ogni volta che un ristretto numero di parole sarà determinante per modellare la società, è seguito un dibattito, tanto più approfondito quanto più circoscritto agli specialisti del settore, e tanto più utile o nemico del potere, che sempre ha cercato di semplificarlo, per esaltarne o cancellarne la rilevanza, su ogni piano, politico, culturale, scientifico, religioso.
Galileo pubblica il dialogo sui massimi sistemi, e il Cardinale Bellarmino si rifiuta di guardare nel cannocchiale riducendo le sue tesi scientifiche a menzogna, quindi minaccia la tortura e il rogo, consapevole di un consenso collettivo carpito con la massima semplificazione dei concetti religiosi e scientifici.
Viceversa, ai sette articoli della Costituzione degli Stati Uniti d’America (1776) segue la pubblicazione dei “The Federal papers”, 85 saggi di profonda scienza politica, scritti per convincere l’assemblea degli USA a ratificarla. I giornali di New York li diffondono, poi vengono raccolti in volumi per offrire una visione lucida del nuovo sistema di governo e consentire le interpretazioni e i 27 emendamenti nei successivi 200 anni.
L’illuminismo ha fornito la chiave interpretativa del pensiero oggettivato nello scritto per costruire nella mente il terreno della riflessione. L’elaborazione delle idee, pur ridotta a semplificazioni e a esemplificazioni per renderla comprensibile ai più, non intendeva demolirne l’edificio. Lo fecero invece i nemici della riflessione critica cercando il consenso per raggiungere i loro scopi. Condorcet venne ghigliottinato per questo.
Ma fu il Novecento a imboccare più di ogni altro secolo la strada della semplificazione del messaggio come veicolo per allontanare la riflessione critica.
Valgano come esempio “Il dizionario mussoliniano” con “1.500 affermazioni e motti del Duce” e “Il libretto rosso” di Mao Tze Dong, l’antologia delle sue citazioni, obbligatoria in tutti i gradi d’istruzione in tutti i luoghi di lavoro e nell’esercito. Entrambi impasto di idee e giudizi superficiali, perfettamente twittabili. Finché sulla scena mondiale della comunicazione compare la Rete.

Senza farne la storia, è bene vedere come abbia sedotto gli utenti, diventando altresì un micidiale polo di attrazione per l’informazione mainstream, tanto da causarne una trasformazione epocale.
Si sa che il sedotto acconsente in vista del suo tornaconto, ma se talvolta smaschera la menzogna, cade spesso vittima dell’inganno.
Il nuovo pubblico, con tempi di fruizione più veloci di un tempo e una soglia di concentrazione minore, ha abbracciato entusiasta l’offerta della Rete e ha sceso il primo gradino. Poi l’avvento dei social network ha reso fluidi lo scambio e la condivisione di notizie e contenuti, mescolando le sfere del pubblico e del privato, talché il sedotto ha sceso il secondo gradino, convinto di costituire una sfera pubblica attiva con una propria opinione, dove poter diffondere e condividere contenuti privati e viceversa. Ma big tech ha rimodulato il contesto dove gli individui credevano di scegliere cosa proporre pubblicamente e cosa no, usando i luoghi della propria vita come spazi dove chiunque potesse fruire di un gran numero di contenuti. Erano inconsapevoli che i social media stavano approfittando del fatto che il pubblico percepiva quei luoghi con significati diversi, aperti a decodifiche aberranti, magari a favore di chi offriva coscientemente di tutto a un’audience in grado di comprenderne solo una parte, a causa delle variabili cognitive soggettive di persone sedotte dall’immediata fruibilità di contenuti a cui potevano partecipare.
Poi la seduzione ha colto i vecchi media ancorati alle loro autorevoli informazioni complesse e già costruite, inducendoli a reagire alla TV in streaming trasmessa dalla Rete con versioni online in continuo aggiornamento arricchite dai commenti dei lettori. Col moltiplicarsi delle voci dei blogger o sedicenti tali, all’autorevolezza si è sostituita la credibilità coincidente col numero dei follower, ma a discapito della qualità.
Oggi il potere mainstream dei media di massa si è spostato sul web dove i singoli, coi loro post, commenti e tweet animano dal basso la discussione, mentre il sistema mainstream include le dinamiche dei social network ibridando mass media e reti di comunicazione orizzontali.
Questa eccessiva varietà di fonti pone un grave problema di veridicità, poiché in questa commistione, che causa una distorta costruzione dell’idea di mondo, ognuno cerca spazi di autoreferenzialità sempre più estesi e annichilenti la capacità critica. D’altronde i social forniscono un miele cognitivo irresistibile con effetti perversi.
Uno, la perduta capacità di approfondimento, ha fornito lo schermo dietro al quale gli oligopolisti del web hanno costruito i loro imperi con guadagni plurimiliardari, senza sfiorare col dubbio gli utenti ubriacati dalla pulsione all’uso sistematico delle piattaforme dove si consuma il rito dell’uso fuggevole delle emozioni, tanto più veloce, quanto più estetizzante, per dirla col filosofo Byung Churl Han, giocato attraverso l’invito all’azione, il click, e non alla riflessione. Le emozioni, divenute merce, perdono la loro funzione primaria che stabilizza la vita umana sul piano dei legami di affetto. Il trionfo dell’hate speech ne è un esempio. Ma il senso delle parole non viene approfondito, anzi, quanto più capaci di risvegliare figure profonde dell’immaginario (si pensi a parole come “memoria collettiva”, “lingua”, “insieme dei valori”, “territorio”, “sangue” “differenze di genere” “Solidarietà” “sacrificio” “popolo” “democrazia” “patria” che saltellano tra la destra e la sinistra con disinvoltura) tanto più vengono ingoiate e ritrasmesse come portatrici di valori, mentre i colossi del web lucrano immani profitti facendosi beffe degli Stati, una volta acquisito il consenso di miliardi di utenti, sedotti dall’inganno dell’apparente gratuità, divenuti essi stessi merce con la miriade di dati personali forniti al loro seduttore, autorizzato a incamerarne e processarne terabyte usati per fagocitare il mercato pubblicitario e distruggere le risorse dei media tradizionali (nel 2020 Google ne ha il 50%, Facebook il 25%). Frattanto gli utenti felici aumentano un narcisistico rispetto di sé palleggiando parole polisemiche da un like all’altro, spesso a corredo di aforismi travestiti da valori che non si riferiscono alla comunità, ma all’ego schiavo della pulsione irrefrenabile di postare di tutto. Così le fake news volano tra persone incapaci di cogliervi il significato sotteso, cioè il presupposto implicito: ognuno incendia le sue emozioni sotto l’effetto del riconoscimento implicito di quel che vuole riconoscere. È l’esaltazione del bias.

Ma c’è di più. Da Twitter come finestra sul mondo viene l’effetto feedback sul giornalismo professionale che, per ricavare profitti sempre più scarsi a causa del drenaggio del big tech, è spinto a divulgare notizie sensazionalistiche, talvolta false o non verificate sui suoi siti web e sulla carta stampata, per aumentare le vendite in calo. Questa grave distorsione nell’uso delle piattaforme inquina l’informazione seria. Ne è prova la critica montante dal suo stesso ambito circa l’uso distorto delle notizie sulla stampa di opposizione al trumpismo, i cui i destinatari sono spesso persone sprovvedute. E figuriamoci nell’altra.
Intanto il potere del big tech è cresciuto tanto da censurare un personaggio come Trump (ma non decine di altri), decidere come usare le fake news, truffare gli inserzionisti, appropriarsi delle notizie sui link altrui. E queste non sono azioni marginali di Google, Twitter e Facebook, separate dall’area narcisistica dei loro follower: sono l’espressione di un potere immenso, sottratto a ogni forma di controllo, che prevarica le prerogative della democrazia rappresentativa e che opera su un’infrastruttura essenziale della comunicazione.
Gli Stati reagiscono blandamente. L’Unione europea ha varato una direttiva copyright. L’Australia ha imposto per legge a Google e Facebook di pagare per pubblicare i link del giornalismo professionale. Eppure è scontro.
Tuttavia, come si è visto per l’elezione di Biden, decine di milioni di persone (non solo negli USA) si abbeverano alle fonti delle piattaforme attribuendo loro il valore della verità, come hanno mostrato le teorie complottiste amplificate sui social da milioni di utenti.
Forse gli entusiasti delle piattaforme credono di esercitarvi il loro controllo. Ma quale? A marzo Nayib Bukele ha stravinto le elezioni in El Salvador carpendo a suon di Twitter il consenso dei giovani, stragrande maggioranza, e si è fatto sovrano assoluto col proposito di distruggere il sistema rappresentativo. Ancora una piattaforma usata come arma su persone prive della capacità di sviluppare risorse cognitive proprie, forse inconsapevoli, “opinioni pubbliche fragili, incapaci di formulare autonomamente un pensiero critico, di riconoscere cause ed effetti di un disastro sociale” sotto la spinta di opinion maker incontrollabilmente veritieri, come dice Mario Banti in “La democrazia dei followers”.
E qui da noi? In questo senso gridiamo il nostro allarme contro la stupidità crescente.
C’è rimedio? Forse nel recuperare l’utopia platonica: il linguaggio parlato come piattaforma per il dialogo. Forse l’horror che alle persone dotate di un sistema cognitivo funzionante suscita la sua negazione col ping pong dei like sui social, proprio dai social potrebbe venir sconfitto.
È dallo scorso gennaio che funziona Club House, un social network ancora piuttosto esclusivo, dove si può letteralmente conversare sui temi più disparati. Ne riparleremo, ma forse questa è la via per uscire da quella che porta alla stupidità, e, chissà, forse per tornare al trionfo dell’illuminismo anche nel pensiero scritto.
Roberto Settembre, magistrato dal 1979 al 2012, ha redatto la sentenza di appello sui fatti del G8 di Genova a Bolzaneto, a riposo come presidente di sezione di Cassazione.
© riproduzione riservata