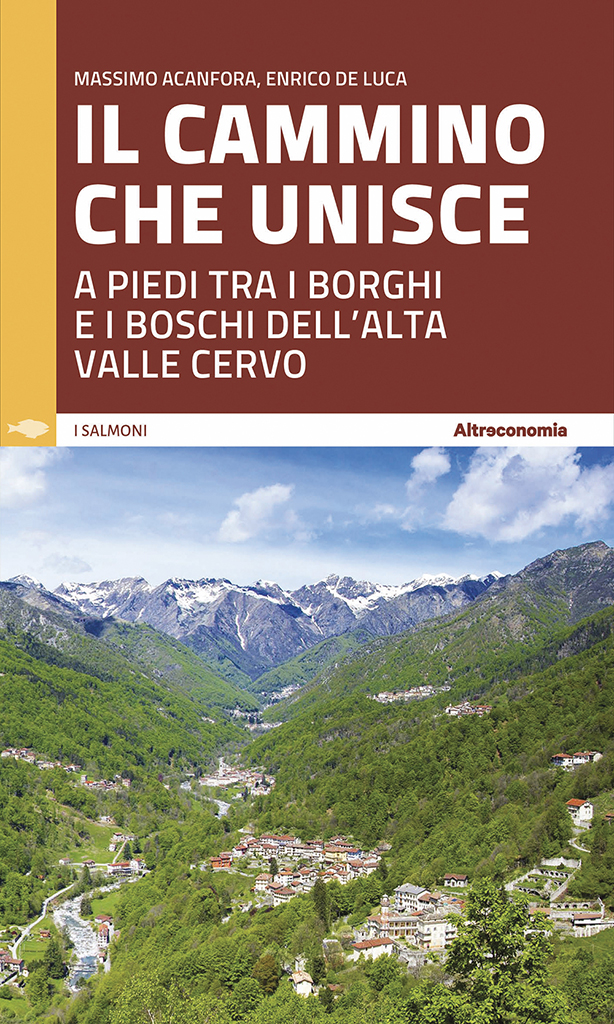Cultura e scienza / Opinioni
La secolare retorica della “valorizzazione”

Nella Firenze del 1600, un ricco mercante provò ad acquistare la Cappella Brancacci per celebrare il suo potere. Fu fermato. Una lezione attualissima. “Un volto che ci somiglia”, l’editoriale di Tomaso Montanari
Intorno al 1690 i frati del Carmine, a Firenze, provarono a “mettere a reddito” il loro patrimonio storico e artistico.
L’occasione era ghiotta: uno degli uomini più ricchi della città voleva costruirsi una cappella gentilizia, e aveva messo gli occhi sulla loro chiesa. Francesco Feroni era un nuovo ricco: da buon fiorentino aveva scelto di fare il mercante, trasferendosi ad Amsterdam e mettendo insieme una fortuna.
Nel 1673 si era sentito abbastanza ricco da poter tornare in patria, dove il denaro gli valse il titolo di marchese e un ruolo di spicco sulla scena pubblica del granducato di Toscana, che, sotto Cosimo III, si avviava ad un quieto, irreversibile tramonto.
In questa storia di successo non poteva mancare una cappella familiare, un luogo in teoria dedicato al riposo eterno, ma in verità assai più utile per rafforzare, legittimare e perpetuare il potere e il prestigio terreni. Il neomarchese Feroni era così lanciato verso questo traguardo che aveva pensato di comprarsi nientemeno che la Cappella Brancacci, dove era pronto a distruggere gli affreschi di Masaccio, Masolino, e Filippino Lippi.
Da parte loro, i frati non avevano obiezioni: “Per acquistarsi un benefattore di quella portata -racconta un loro confratello vissuto qualche decennio più tardi- nulla sarìa calso più non veder quei mostacci, con zimarre e mantelloni all’antica abbigliati”. Era la valorizzazione, bellezza!
Mentre già si pensava di demolire la culla della pittura rinascimentale, sorse spontanea quella che le fonti definiscono “una lega di difesa contro il minacciato vandalismo”, una sorta di Italia Nostra del tardo Seicento, che coinvolse l’Accademia del Disegno e quindi convinse la granduchessa madre Vittoria della Rovere a dare “ordine espresso che non si toccassero tali dipinture”. Con l’appoggio di altri esperti, decisamente più malleabili, Feroni provò a replicare che egli “avria fatte segare con ogni diligenza le mura del primo ordine, ove sono le pitture più insigni, e gli artefici assicuravano di poterne venire a capo senza il minimo detrimento di cotali pitture”. “Ma tant’è -continua il frate- la granduchessa, ferma qual salidissima colonna nel suo impegno, non volle a verun patto che le mura e le pitture della cappella fosser toccate”. A quel punto, il Feroni e il suo denaro si arresero: egli scelse di costruirsi il mausoleo di famiglia nella chiesa della Santissima Annunziata (sulla sua tomba naviga ancora una nave carica di merci e, chissà, di schiavi), e noi oggi abbiamo ancora la Cappella Brancacci.
È una lezione terribilmente attuale: l’eterna lotta per la salvezza del patrimonio culturale (e oggi anche dell’ambiente) si può vincere solo grazie ad un’alleanza tra una diffusa volontà popolare e quella parte (minoritaria, oggi come ieri) del mondo intellettuale che non è in vendita. Perché quest’alleanza abbia qualche speranza di realizzarsi c’è vitale necessità di luoghi di incontro: giornali, associazioni, partiti. E perché questa battaglia abbia qualche chance di successo c’è anche bisogno che tutto questo conquisti una rappresentanza parlamentare (ed è anche per questo che una legge proporzionale appare la più compatibile con le ragioni della democrazia).
Se nel 1690 si trattava di raggiungere e convincere il sovrano, oggi la sfida – perfino più ardua – è rimettere il sovrano sul trono. Perché oggi il sovrano siamo noi.
© riproduzione riservata