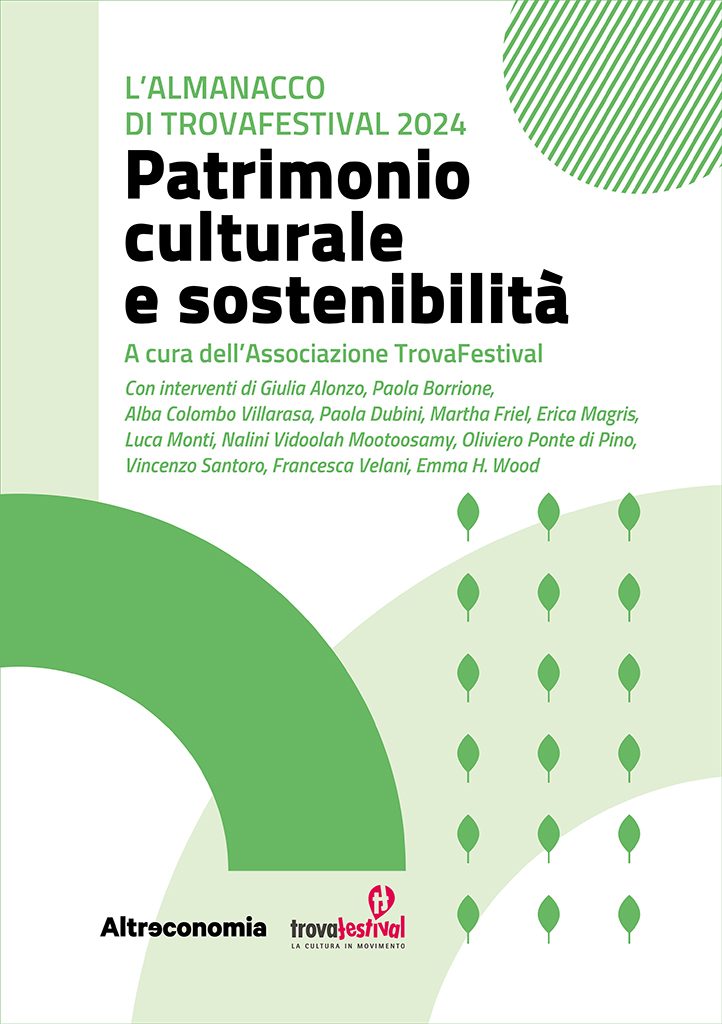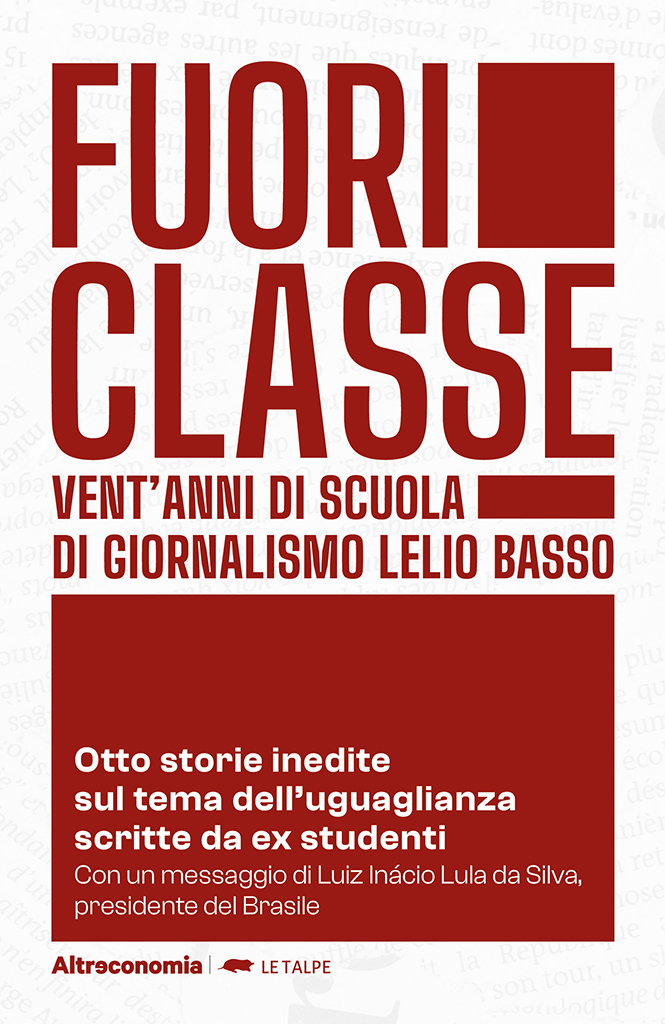Cultura e scienza / Intervista
Ken Loach. Forza, solidarietà, lotta di classe: la strada maestra per riprendersi la vita

Il regista ha chiuso la sua lunga carriera con il profetico “The Old Oak”. Intervistato al “Festival dei Matti” di Venezia, fotografa con lucidità ciò che oggi accade nel mondo. Raccontando la sua vita, i suoi film e provando a indicare la via per costruire un futuro diverso. Senza dubbi su quale parte prendere nel conflitto contemporaneo tra chi vende il proprio lavoro per sopravvivere e chi ne trae brutalmente profitto
Il biglietto d’addio che Ken Loach ha scelto per congedare la sua decennale e strabiliante carriera è un lungo corteo che sfila per le vie di un piccolo paese ex-minerario vicino a Durham, nel Nord-Est dell’Inghilterra, che nel suo procedere viene accompagnato da uno stendardo che recita “Forza, solidarietà, resistenza”.
Si chiude così “The Old Oak”, quella che il regista ha dichiarato essere la sua ultima pellicola, con “gli ultimi” -i rifugiati di origine siriana arrivati nella cittadina, chi ha deciso di aiutarli e chi li ha respinti- che decidono di stare al fianco l’uno dell’altro, riconoscendosi reciprocamente, unendo le forze.
“La lotta di classe”, questa per Loach rimane l’unica ricetta possibile per uscire da questi tempi bui. Una visione lucida sui nostri giorni restituita dal regista nell’ambito del “Festival dei Matti”, che si è svolto a Venezia a fine maggio 2024.
Ken, i protagonisti dei tuoi film sono a volte totalmente invischiati in un sistema oppressivo, come nel caso di “In questo mondo libero”, ma più spesso trovano la forza di opporsi alla sua logica, anche se non sempre sopravvivono alla loro ribellione. Pensiamo per esempio a Daniel Blake, che si trova ad affrontare lo Stato e la burocrazia che lo rappresenta e finisce in una situazione kafkiana, senza via d’uscita. Queste circostanze particolari sono i semi di una sofferenza mentale che poi si esprime nei molti modi che conosciamo. Tuttavia la cura, sembri dire nei tuoi film, non è quella che siamo abituati a pensare. Allora, come ci curiamo in questo mondo libero?
KL Credo che quello che abbiamo cercato di fare sia stato mostrare le contraddizioni della società. Per dirla in modo molto semplice, al centro della nostra società c’è il conflitto tra chi vende il proprio lavoro per sopravvivere e chi ne trae profitto. Ci raccontano la grande bugia che abbiamo un interesse comune, che tutti abbiamo gli stessi problemi e naturalmente non è così. Perché l’interesse di coloro che sfruttano il lavoro, possiedono e controllano le finanze, le industrie, che fanno profitto in un sistema fondato sulla concorrenza è questo: vince chi fornisce i migliori prodotti e servizi al costo più basso sfruttando la forza lavoro. Invece l’interesse della gente comune è rappresentato dall’avere un lavoro sicuro, un reddito sicuro, una casa sicura, cibo sicuro per la propria famiglia. E questi due interessi sono apertamente in conflitto, non possono essere riconciliati, e questo è il conflitto inevitabile che abbiamo. E finché non ne prendiamo atto restano inconciliabili perché è il sistema a richiederlo.
Siamo ormai in una fase in cui le conquiste come la giornata di otto ore, il posto fisso, il licenziamento per giusta causa, il salario minimo, sono sparite, finite in quella che chiamiamo la gig economy. Il datore può aprire e chiudere il lavoro come un rubinetto. Ovviamente, questo porta grande povertà. E il sistema ti dice che se sei povero è colpa tua. C’è la povertà, ma ti dicono che tutti possono lavorare, che se ti impegni abbastanza c’è un impiego per tutti. Sappiamo che è una bugia, ma loro sono costretti a insistere su questo per evitare che venga messo in discussione il sistema. E quindi è colpa tua e devi essere punito se sei povero. Così ti tagliano il salario e se hai bisogno di soldi dallo Stato ti renderanno difficilissimo averli, rischierai di morire di fame. È quello che abbiamo cercato di far vedere in “Io, Daniel Blake”. Se invece lavori, la lotta per mettere insieme abbastanza soldi per andare avanti con la gig economy e l’insicurezza del lavoro creano una pressione psicologica enorme. Non puoi mai rilassarti. Sappiamo che c’è chi fa due o tre lavori insieme, lavora giorno e notte. Quindi è una pressione psicologica enorme.
E questo aumenta la sofferenza delle persone.
KL Stiamo assistendo a una crisi colossale della salute mentale in Gran Bretagna, una crisi enorme. Non ne capiscono le cause perché non vogliono mettere in discussione il sistema. Dalla destra ai socialdemocratici, che sono i più pericolosi di tutti, perché dicono di rappresentare i lavoratori ma per loro conta solo il profitto. Quindi, il capitalismo deve funzionare, e funzionerà solo se otterranno profitti. Una concorrenza sfrenata significa sempre più sfruttamento. E così la salute mentale, anzi la non-salute mentale è in forte aumento. Le persone crollano, i legami e i matrimoni si rompono, perché non si può vivere sempre sotto pressione dal punto di vista economico. È molto, molto difficile.
“I lavoratori, se uniti, possono fermare tutto: non siamo noi a dipendere da loro. E la menzogna che accettiamo, che questo sia l’unico modo di organizzare la nostra vita, è disastrosa”
Qual è la soluzione secondo te?
KL La vecchia ricetta della lotta di classe: riconoscere che questa società si basa sulla lotta di classe e organizzarsi nei sindacati, sul lavoro e difendere le scuole, i servizi e unirsi, perché finché siamo isolati all’interno di questa comunità, di quel sindacato, di quel Paese e non creiamo dei legami non succede nulla. È quello che abbiamo cercato di mostrare nel nostro ultimo film, “The Old Oak”: la nostra forza è la solidarietà. I lavoratori, se uniti, possono fermare tutto: non siamo noi a dipendere da loro. E la menzogna che accettiamo, che questo sia l’unico modo di organizzare la nostra vita, è disastrosa. Gli Stati Uniti, la Cina, la Russia o altri, lottano per il controllo delle sfere di influenza, le zone di cui possono controllare i mercati e, soprattutto in Occidente, la classe dirigente ha bisogno di mercati per le proprie merci per fare profitti.
Che cosa implica tutto questo?
KL La necessità di avere Paesi che accettino i loro investimenti per la manodopera a basso costo, per i mercati, per vendere i loro prodotti. Si tratta quindi di una politica estera aggressiva, come in Ucraina. Penso alle cose terribili che stanno accadendo a Gaza e in Israele, e mi riferisco alla crudeltà, all’assenza di diritti umani. La ricerca di profitto genera la necessità di dover lottare per la pace e i diritti umani e per fermare il disastro climatico in corso, la distruzione delle nostre risorse naturali. Noi non possiamo pianificare come usare le risorse del Pianeta a causa degli interessi delle grandi aziende: i profitti dell’anno prossimo dipendono dall’uso del petrolio, o di qualsiasi altro combustibile fossile, e loro non lo pianificheranno perché significa rinunciare ai ricavi. Se rinunciano al profitto, il loro sistema crolla.

Vorrei passare da un contesto globale a uno individuale. “Il mio amico Eric” è un film su una condizione di infelicità e disperazione in cui, a un certo punto, entra in gioco una sorta di follia. Éric Cantona, idolo del protagonista, esce dal manifesto e inizia a sostenerlo nella sua rivolta, nella sua lotta. Pensi che la follia non sia così fosca come viene comunemente rappresentata e che offra ancora qualche vantaggio?
KL Non direi esattamente così, non prendetelo troppo sul serio. È uno scherzo e non voleva essere uno studio psicologico. Éric Cantona è molto modesto, ma lo dipingono come questo calciatore filosofo. E, naturalmente, è solo un uomo che si diverte. Il nocciolo serio è che c’è una persona che sta lottando per avere il controllo della propria vita e intrattiene queste conversazioni immaginarie con Éric Cantona. Il calciatore gli dice: “puoi dire di no quando serve”. E poi c’è il sostegno degli amici. Ancora una volta, è una questione di solidarietà. Molto di quello che abbiamo fatto riguarda la solidarietà, l’amicizia e l’unione, la forza che si ricava dagli altri.
A proposito di delirio e di questioni psicologiche e psichiatriche, nel 1967 hai diretto “In two minds”, che racconta la storia di una ragazza che riceve una diagnosi di schizofrenia. Oggi, è cambiato il modo di considerare la sofferenza mentale e la responsabilità collettiva a essa collegata?
KL Sì, da quello nacque un altro film intitolato “Family Life”. Negli anni Sessanta ci fu uno psichiatra che divenne celebre, si chiamava R. D. Laing, era scozzese e scrisse molti libri famosi, uno dei quali si intitolava “Normalità e follia nella famiglia”. Lavorai al film con il produttore Tony Garnett, molto esperto sul tema. Anche io ho poi incontrato Laing e il nucleo della sua idea, credo, era che i sintomi di quella che veniva chiamata schizofrenia potevano spesso illustrare un’allegoria o una metafora di una situazione famigliare opprimente. Un esempio tipico: quando una madre dice alla figlia “Sei proprio come me”, da un certo punto di vista è un’osservazione casuale, ma se presa troppo sul serio significa che si nega all’altra persona la sua personalità. E allora l’altra persona, se non è molto stabile, sente di non esistere se non nella mente della madre o del padre, o di chiunque sia. Questo porta alla disgregazione ed è l’idea di Laing, secondo cui la famiglia era disfunzionale in quanto non permetteva a tutti di essere un sé individuale. Un’unica persona mostra i segni della rottura, ma il problema è della famiglia intera. Laing stava sempre attento a dire che le persone soffrivano della diagnosi di schizofrenia piuttosto che di schizofrenia. Le sue opinioni gli attirarono molte critiche. Oggi ovviamente c’è un equilibrio tra la predisposizione delle persone che non sono in grado di gestire o di affrontare questa situazione con genitori oppressivi, e altre che non riescono gestirla e a esprimerla, ma non sono così esperto da parlarne ora.
“Noi non accettiamo le nostre responsabilità e i governi alimentano l’ostilità contro i rifugiati generando razzismo. Questo va a favore della classe dirigente perché viene usato per dividerci”
Prima hai accennato al tuo ultimo film “The Old Oak” che racconta l’arrivo di alcune famiglie siriane in una cittadina che da subito li respinge. Nel film la questione dell’identità emerge in tutta la sua crudeltà, ma allo stesso tempo il film ci mostra la via di una possibile redenzione nell’abbraccio insperato tra gli ultimi e nella costruzione di legami dentro le differenze. Oltre a questo, che cosa serve secondo te per una nuova primavera?
KL Credo che ci siano diversi fattori. Dovremmo innanzitutto vedere che cosa abbiamo in comune. Le persone sono state incoraggiate dalla stampa di destra a essere razziste cadendo nella trappola secondo cui il motivo per cui non hanno un buon lavoro è che ci sono gli immigrati che glielo portano via. Ma ovviamente non è affatto vero. Sono senza lavoro perché le miniere di carbone sono state chiuse, noi come società non abbiamo costruito nuove industrie dove ci sarebbe stato un buon lavoro qualificato, buoni salari, un’occupazione sicura, per produrre cose di cui la gente ha bisogno. E ci sono molte cose di cui abbiamo bisogno. C’erano buone comunità, avevano solo bisogno di lavoro. Si sarebbe potuto fare, ma è mancato l’investimento pubblico. Nella mente dei socialdemocratici e della destra, gli investimenti sono possibili solo se qualcuno può trarne profitto, non si possono fare “collettivamente”. Dall’altro lato ci sono le persone che arrivano. Gente comune, che spesso soffre per le guerre che noi, certamente in Gran Bretagna, abbiamo creato, come quella in Iraq e nell’intera area che noi chiamiamo Medio Oriente. E il modo in cui usiamo il linguaggio racconta la nostra storia coloniale: per un cittadino iracheno o palestinese è il centro, altro che Medio Oriente. Noi non accettiamo le nostre responsabilità e i governi alimentano l’ostilità contro i rifugiati generando razzismo. Questo va a favore della classe dirigente perché viene usato per dividerci. Se le persone nel nostro Paese dicono: non vogliamo i profughi, non ci piace la loro cucina, non ci piace il colore diverso della loro pelle, non ci piace il loro modo di vestire, in un certo senso ci impedisce di guardare chi veramente sta causando i nostri problemi. Non vogliamo che alla gente sfugga questo aspetto e abbiamo deciso di raccontarlo nel film. E non vogliamo che sfugga il fatto che le ultime immagini mostrano la classe operaia militante dietro quegli striscioni, perché, di nuovo, questa è la nostra forza. Un’altra cosa che volevamo sottolineare è che noi siamo fatti così.
Cioè?
KL Se ti vedo cadere per strada, corro ad aiutarti e tu farai lo stesso per me. Questo è ciò che siamo. Sono la classe dirigente e la stampa di destra che vogliono farci perdere la nostra umanità. Guardate a che cosa sta succedendo a Gaza: eppure nel nostro Paese, e non so se è lo stesso per voi, stanno cercando di fermare persino le manifestazioni di solidarietà ai palestinesi. Ed entrambi i partiti politici sostengono l’invio di armi a Israele per continuare i massacri. È vergognoso. Vergognoso e incredibile. E ci dicono: “Dimenticate la sofferenza, non guardatela. Queste sono le nostre decisioni”. Se mai qualcosa ha fatto vedere come il loro sistema calpesti la nostra comune umanità dovete guardare Gaza.
In “Jimmy’s hall” il protagonista vuole smettere di fare politica ma poi ricomincia, diciamo che ha una ricaduta. Ora, dopo il tuo ultimo bellissimo film, ci dici che smetterai di fare film. Possiamo sperare in una ricaduta?
KL Mi piacerebbe più di ogni altra cosa, ma al momento ho qualche problema di salute e credo che sarà davvero difficile. Se iniziassi a fare un film adesso, lo finirei a più di novant’anni.
I tuoi film ci mancheranno.
KL Sei molto gentile. Fare film è un privilegio. Io ho sempre lavorato con uno scrittore al mio fianco, Paul Laverty, e sono stato molto fortunato. Da trent’anni parliamo di tutto, dall’idea iniziale della pellicola fino alla realizzazione. Ma Paul ha carta bianca, scrive i personaggi e la storia così come i dialoghi, ovvero la parte più creativa del film. Ho lavorato con bravissimi sceneggiatori in passato, ma Paul è uno scrittore assolutamente meraviglioso e un eccezionale compagno con cui condivido anche la visione del mondo. Ma è tutto il gruppo di lavoro a essere speciale: la produttrice, Rebecca O’Brien, con cui collaboro da 35 anni. E lo stesso montatore per quarant’anni, gli stessi scenografi. In un certo senso io potrei andarmene e loro farebbero lo stesso un buon film, perché abbiamo trovato un modo di lavorare insieme, una sorta di estetica e un obiettivo comune: un po’ come quando un direttore d’orchestra è stato a lungo con un’orchestra, basta che dia il tempo e può andare a prendersi un caffè mentre loro finiscono la sinfonia senza di lui. L’altra fortuna enorme è che abbiamo guardato all’Europa e non al di là dell’Atlantico, non agli americani. Loro stanno distruggendo la nostra cultura cinematografica, perché gli americani devono dominare, non sono interessati alle collaborazioni. Noi invece abbiamo sempre lavorato con coproduttori europei, che sono spiriti generosi, con loro si lavora alla pari. Nessuno guadagna una fortuna, ma è sufficiente per andare avanti, lo facciamo da più di sessant’anni ormai. Quindi sono stato immensamente fortunato, un grande privilegio.
Ancora una volta, nel caso del cinema americano, è una questione di profitto e di affari, è la solita storia.
KL Ovviamente ci sono registi bravissimi anche là, ovviamente, e c’è anche un settore indipendente, ma è difficile scovarlo e penso debba affrontare molte difficoltà. E le nuove tecnologie hanno cambiato tante cose. I film che mi sono serviti da modello sono soprattutto le pellicole europee del primo Dopoguerra, anche quelle dei neorealisti italiani. Ci sono così tante tradizioni diverse nel cinema europeo, molte delle quali stanno scomparendo ma io spero torneranno a rivivere. Spero che la gente le preservi, perché si tratta di un grande patrimonio artistico cinematografico.
Stefano Galeazzi, autore di questa intervista, ha studiato Antropologia a Venezia e a Lione, effettuando diversi periodi di ricerca sul campo tra i migranti originari di diversi Paesi africani sfruttati lavorativamente nella Piana di Gioia Tauro. Ora sta svolgendo un dottorato di ricerca in Antropologia presso le Università di Padova e Ca’ Foscari Venezia sul tema delle relazioni complesse fra migranti cinesi e popolazione locale nel Senegal contemporaneo.
Il Festival dei Matti si è svolto dal 30 maggio al 2 giugno a Venezia. È un’iniziativa culturale indipendente che dal 2009 si interroga e interroga la cittadinanza sulla questione del rapporto tra follia e normalità, tra salute e sofferenza mentale. Al di là dei discorsi e dei gesti tecnici che contrappongono queste dimensioni rendendole drammaticamente disgiunte e diseguali, il Festival dei Matti interpella i versi dei poeti, le immagini di fotografi, registi, artisti, le parole delle scienze umane, la musica, la voce di chi ha attraversato esperienze di sofferenza psichica riaprendo giochi e prospettive su temi che riguardano la vita di ciascuno di noi. Come singoli e come comunità.
© riproduzione riservata