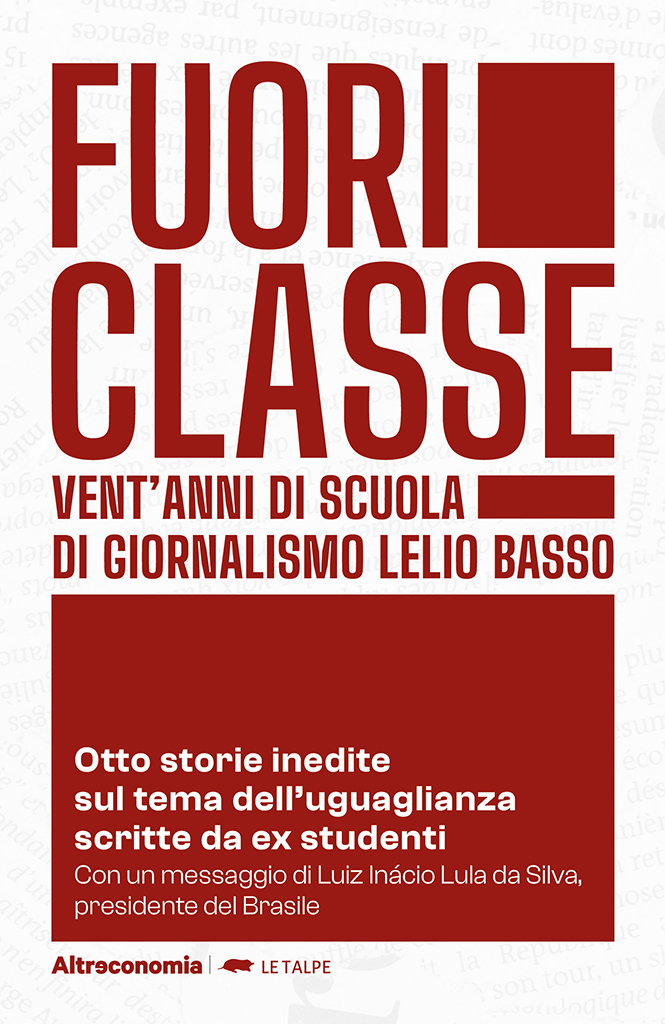Cultura e scienza / Intervista
Christophe Boltanski. La notte del museo coloniale

“King Kasai” racconta la visita notturna dello scrittore all’AfricaMuseum di Tervuren, poco distante da Bruxelles, denso di simboli dell’occupazione belga in Congo. Un’occasione per riflettere sul passato e sulle colpe dell’Occidente
“Se c’è qualcosa in comune tra i libri che ho scritto è il fatto che trattano la questione della memoria, del ricordo, e hanno a che fare con la nozione di traccia e di ciò che è rimasto”. Inizia così l’intervista a Christophe Boltanski, scrittore e giornalista francese, a lungo inviato in Medio Oriente e in Africa. A febbraio è uscito “King Kasai. Una notte coloniale nel cuore dell’Europa”, pubblicato da add editore: un testo che affronta il tema del colonialismo europeo, di ciò che ne è rimasto e ci è stato trasmesso fino a oggi. Al suo interno, Boltanski descrive la visita all’AfricaMuseum, il vecchio museo coloniale belga di Tervuren, cittadina a pochi chilometri da Bruxelles. Dopo essere restato a lungo immutato, l’edificio ha riaperto nel 2018 in seguito a una riorganizzazione che aveva lo scopo di “presentare una visione contemporanea e decolonizzata dell’Africa”, come spiega il museo stesso. Dopo la seconda inaugurazione a Christophe Boltanski è stato proposto di partecipare all’iniziativa “La mia notte al museo”. Lo scrittore ha accettato con entusiasmo scegliendo proprio l’AfricaMuseum. “Tutti i miei libri sono ambientati in un luogo limitato. Ecco perché ero incuriosito dall’idea di passare una notte in un posto chiuso come un museo. E poi sapevo che quello era un luogo pieno di fantasmi: provare a stabilire un dialogo con loro era una delle sfide di questa esperienza”.
Boltanski, perché ha deciso di passare una notte proprio all’interno dell’AfricaMuseum di Tervuren?
CB Ho scelto questo luogo perché l’avevo visitato dieci anni fa per scrivere un altro mio libro che si intitola “Minerais de sang: Les esclaves du monde moderne” (“Minerali di sangue: gli schiavi del mondo moderno”, non pubblicato in italiano, ndr). Si tratta di un lavoro giornalistico ambientato nella provincia del Nord Kivu nella Repubblica Democratica del Congo. In quell’area ci sono numerosi conflitti che sono però raccontati in maniera molto limitata, si è convinti che lì le persone si combattono da sempre e continueranno a farlo. Io volevo connettere questi eventi con la nostra vita di tutti i giorni, perché la maggior parte dei gruppi armati in Nord Kivu sfrutta quei minerali che sono essenziali per la nostra modernità, per i nostri computer.
E così sono andato anche in questo museo a Bruxelles che contiene tutto ciò che il Belgio possedeva riguardo alla propria ex colonia: archivi, documenti, foto e campioni di minerali. Ci sono andato e ho scoperto un posto eccezionale, un museo che non era cambiato dalla sua apertura nel 1910 e che era puramente un museo coloniale. Perciò, quando ho sentito che era chiuso per essere rinnovato e decolonizzato, ho pensato che sarebbe stato interessante tornarci. È successo nell’agosto 2020, poco dopo la morte di George Floyd a Minneapolis: in tutto il mondo c’erano dimostrazioni contro i simboli del colonialismo, numerose statue venivano vandalizzate e ho pensato che fosse interessante visitare un posto pieno di questi simboli, come se fosse un campo di battaglia di quello che stava accadendo.
Tutto il libro si concentra su questo processo di riorganizzazione e di decolonizzazione, come è stata chiamata dalle autorità dell’AfricaMuseum. In che cosa consiste la decolonizzazione di un simile museo?
CB I musei coloniali si trovano in molti luoghi, in Francia, in Belgio, in Inghilterra e anche in Italia. E la maggior parte di questi ha seguito tre fasi: sono nati come musei coloniali, poi sono stati trasformati in esposizioni etnografiche e infine sono diventati in qualche modo dei musei delle belle arti. All’inizio erano quindi dei veri e propri strumenti di propaganda. In seguito sono stati ripensati con scopi scientifici. E alla fine sono stati trasformati secondo dei canoni estetici. Si potrebbe dire che c’è stato un processo di pulizia, di “sbiancamento”, perché come dice il filosofo tedesco Walter Benjamin la bellezza è come il denaro, non puzza. E così se ti presenti come un museo delle belle arti, i tuoi oggetti diventano delle opere d’arte
con un valore universale. Non devi spiegare qual era il loro scopo, da dove vengono e come sono stati presi.
“Se ti presenti come museo delle belle arti, i tuoi oggetti diventano delle opere con un valore universale. Non devi spiegare qual era il loro scopo, da dove vengono e come sono stati presi”
Nel museo di Bruxelles, com’è andata questa operazione?
CB L’AfricaMuseum è restato allo stesso tempo un museo coloniale, etnografico e delle belle arti. Ed è interessante vedere come non sia stata fatta una vera scelta e si siano mantenute tutte e tre le opzioni. Non sono sicuro che il risultato sia ottimale. Al tempo stesso, però, il processo è ancora in corso. Dopo la pubblicazione del libro sono tornato nel museo per un’intervista e ho trovato alcuni miglioramenti nella contestualizzazione degli oggetti.
In “King Kasai” lo scrittore Christophe Boltanski segue a ritroso le orme del cacciatore che partecipò alla spedizione del Museo e uccise l’elefante King Kasai, nel 1956, addentrandosi nell’oscurità di uno dei tanti “cuori di tenebra” dell’Occidente, densi di colpe un tempo impensabili, e ora appena ammissibili (add editore, 18 euro, 132 pagine)
In generale è possibile decolonizzare quello che in precedenza era uno strumento di propaganda?
CB Non saprei, non sono uno specialista di musei e lo scopo degli scrittori è più sollevare delle questioni che fornire delle risposte. Però è sorprendente il fatto che esistano musei su qualsiasi cosa ma non sulla storia coloniale: in Francia è così, ma credo anche nel resto d’Europa. E questo dimostra che non siamo in grado di affrontare questo passato. Perciò, forse, sarebbe interessante cercare di trasformare un museo coloniale in un museo sulla storia del colonialismo, in questo caso sull’occupazione belga in Congo.
“È sorprendente il fatto che esistano musei su qualsiasi cosa ma non sulla storia coloniale. In Francia è così. Questo dimostra che non siamo in grado di affrontare questo passato”
All’interno del libro, alcuni suoi incontri sono particolarmente rilevanti. Tra questi c’è quello con King Kasai, l’enorme elefante simbolo del museo, che dà anche il titolo al testo. Quali sono le riflessioni nate da questo confronto?
CB Lascia che le spieghi il contesto: deve capire che ero nel museo di notte, al buio, avevo soltanto il mio telefono per fare un po’ di luce. In questa situazione ti manca totalmente la visione dell’ambiente perché non riesci a vederlo, e va considerato che tutto il museo è una messa in scena. Vedi solamente i dettagli. Io ho passato la notte su una branda in quello che prima della ristrutturazione era l’ingresso principale, davanti a un enorme elefante che è stato cacciato e ucciso nel 1956 appositamente per esporlo. Durante la notte ho realizzato l’importanza della caccia nell’AfricaMuseum e forse nell’epoca coloniale: la maggior parte delle cose che ho osservato sono state cacciate e il museo ha negli archivi dieci milioni di campioni animali, ovviamente non solo leoni ed elefanti ma soprattutto insetti. Ognuna delle spedizioni in Congo tornava con centinaia, migliaia di animali morti. E questo non era dovuto soltanto a motivazioni scientifiche ma soprattutto a una logica estrattivista: questi reperti erano innanzitutto dei trofei, dei trofei di guerra. Per questa ragione, nel libro mi sono concentrato molto su questo elefante e sul suo cacciatore, il cavaliere Alphonse de Boekhat.
Sono 10 milioni i campioni animali tra cui leoni, elefanti ma soprattutto insetti archiviati all’interno dell’AfricaMuseum di Tervuren. Ognuna delle spedizioni belghe in Congo, durante l’epoca coloniale, tornava con centinaia, migliaia di animali morti. Lo scopo non era solo di ricerca scientifica ma rispondeva soprattutto a una logica estrattivista
Quando si parla di Congo e di colonialismo belga, il pensiero va subito al libro “Cuore di tenebra” di Joseph Conrad. A lungo, l’opera è stata criticata perché ritenuta uno dei simboli della mentalità coloniale e della visione dell’Africa come luogo immobile e arretrato. Al contrario, in “King Kasai” lei ne parla come un’opera da cui ripartire. Come mai?
CB Avevo letto “Cuore di tenebra” quando ero adolescente e l’ho riletto quando ho passato la notte al museo. Ovviamente conosco le critiche che sono sollevate contro Conrad per lo stereotipo dell’oscurità, che è sempre stata associata all’Africa: sin dal Medioevo questo continente è stato visto come una terra di tenebre, crimini e mostri. Rileggendo il libro ho pensato però che, parlando di tenebre, Conrad si riferisca alle nostre, quelle che abbiamo dentro di noi. Vedo un collegamento tra quest’opera e “I dannati della terra” di Frantz Fanon, in cui si afferma che dovremmo uscire dalla grande notte in cui siamo immersi. Fanon si riferisce al colonialismo e al razzismo. E per me anche questa notte passata nell’AfricaMuseum rappresenta la “grande notte”, durante la quale ho cercato di riflettere sulle rappresentazioni dell’Africa che sono state costruite e trasmesse, per uscire finalmente da queste tenebre.
© riproduzione riservata