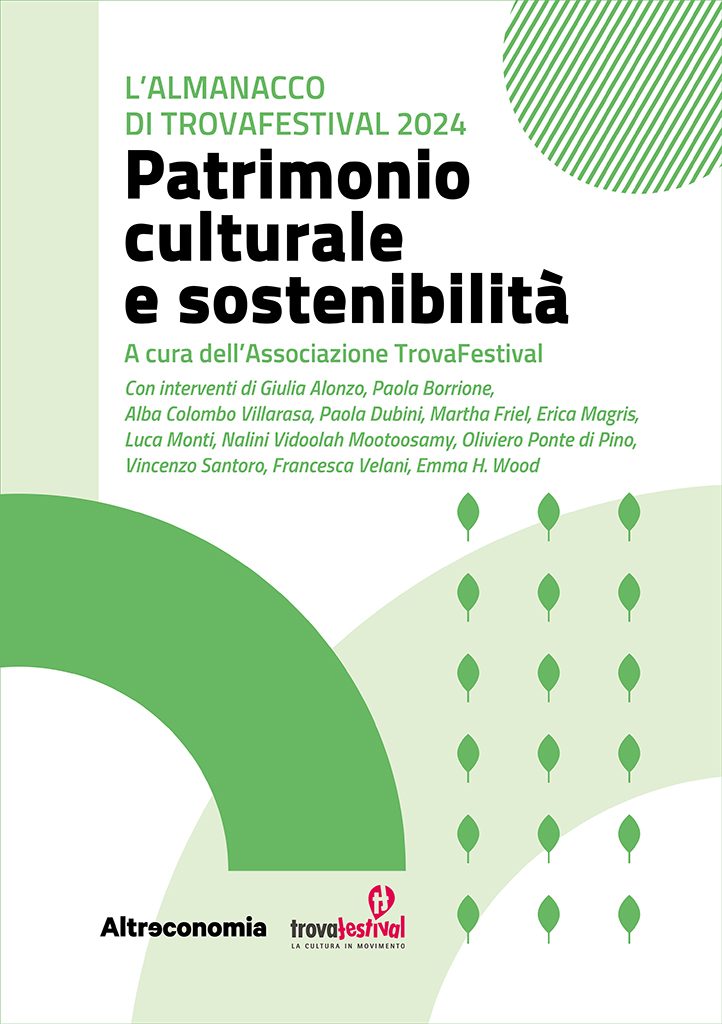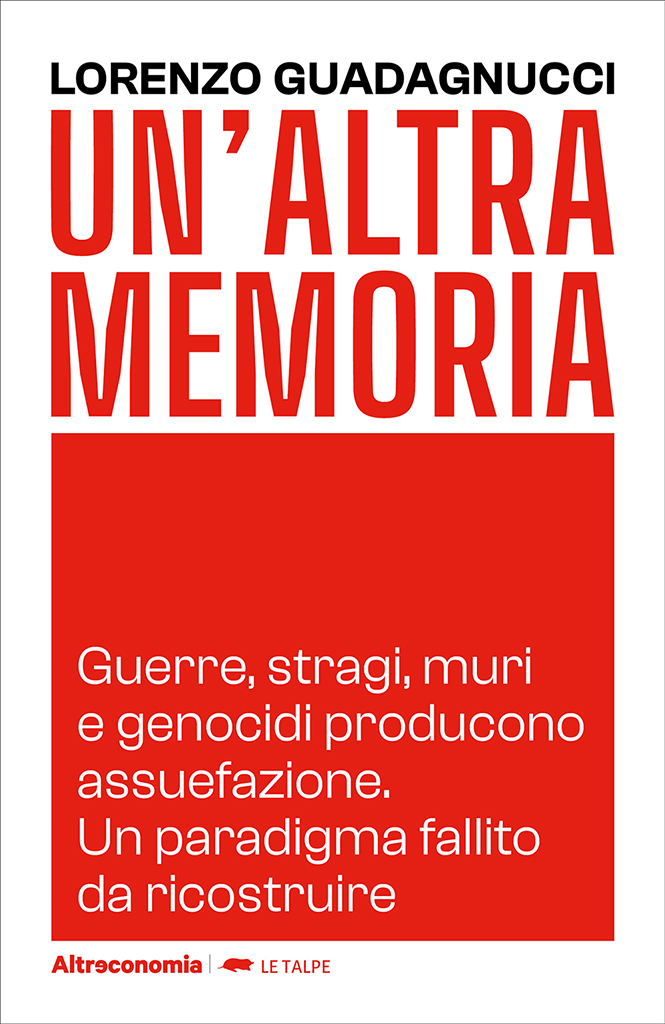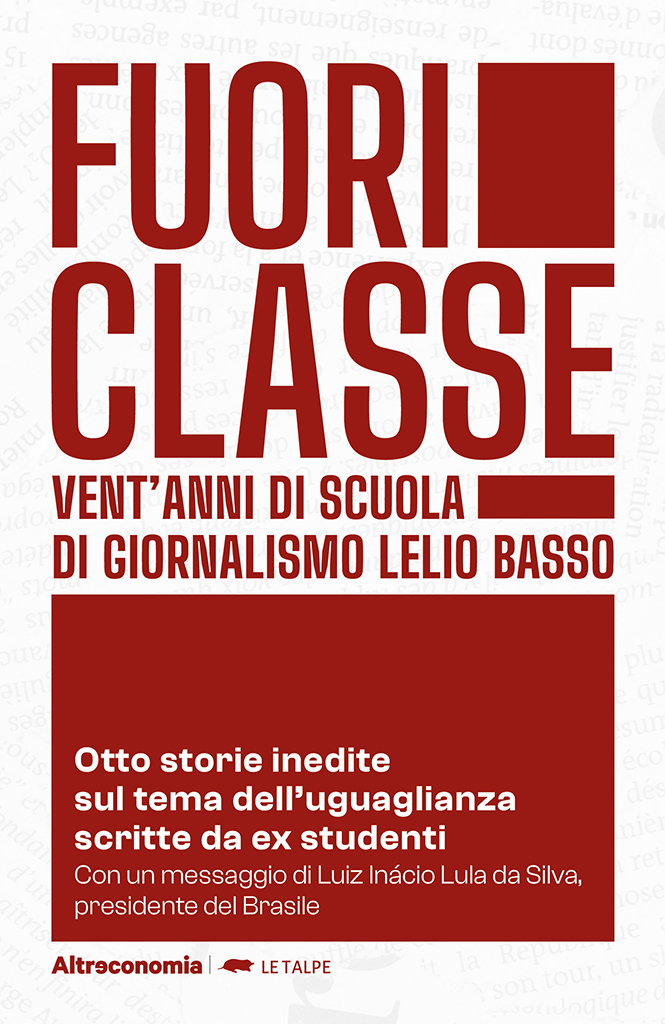Cultura e scienza / Intervista
Gianni Berengo Gardin. Una vita di buone foto

Punto di riferimento della fotografia, Berengo Gardin ha raccontato l’Italia senza compromessi: dalla vita operaia ai manicomi, dal reportage sociale al viaggio su treni e vaporetti, sempre alla ricerca della verità dell’immagine
“Sono nato con la camicia”, racconta Gianni Berengo Gardin, nato a Santa Margherita Ligure il 10 ottobre 1930, icona della fotografia italiana, con il suo consueto understatement. Come i suoi scatti, incontri e libri fossero solo questione di fortuna, mentre invece hanno trasformato il reportage e la fotografia contemporanea. Ha sempre vissuto il suo mestiere come un amatore, seguendo il proprio istinto e documentando l’Italia dal Dopoguerra a oggi, dagli anni Cinquanta in poi. Cresciuto a Venezia e vissuto a Roma e Milano, il suo lavoro spazia dal reportage sociale all’architettura.
Con 263 libri pubblicati, un piccolo record, e oltre 200 mostre internazionali, Berengo Gardin è oggi tra i fotografi più influenti, oltre a essere considerato un maestro per diverse generazioni. Tra i suoi libri più celebri: “Dentro le case” (Electa, 1977), “Dentro il lavoro” (Electa, 1979), “Venezia e le grandi navi” (Contrasto, 2015) e “Sicilia 1966/2008” (Humboldt books, 2024). Con la figlia Susanna ha scritto la sua biografia che s’intitola “In parole povere” (Contrasto, 2020).
Berengo Gardin, lei ha scelto di restare fedele alla pellicola, dichiarando che il digitale è incompatibile con la sua visione artistica. Come vede la diffusione delle immagini digitali e di strumenti come l’intelligenza artificiale? Possono, dal suo punto di vista, rappresentare un pericolo per l’autenticità fotografica?
GBG Con il digitale, si possono fare foto di notte che sembrano scattate a mezzogiorno. Ha i suoi vantaggi, ma io non mi sono mai convertito. La Leica mi ha regalato una macchina digitale, l’ho usata una volta e poi messa da parte. Il digitale è troppo perfetto e freddo; io ho bisogno della grana della pellicola. Se uno iniziasse oggi, probabilmente sceglierebbe il digitale, ma respingo il fotoritocco, specialmente in fotografia giornalistica, perché può creare gravi falsi. Ora, con l’intelligenza artificiale, la vera fotografia rischia di scomparire. Per questo timbro le mie foto con “vera fotografia, non modificata”, per assicurare che siano esattamente come le ho viste.
Nelle sue opere ha sempre sottolineato la differenza tra una “bella foto” e una “buona foto”. Potrebbe spiegare che cosa intende con questa distinzione e quale importanza attribuisce alla fotografia come documento storico?
GBG Il mio archivio comprende due milioni di foto, nel quale ci sono scatti buoni, cattivi, terribili e qualcuno ottimo. Henri Cartier-Bresson diceva che un buon fotografo riesce a fare una sola grande foto all’anno. Io credo di averne fatte un paio in più, e ne sono soddisfatto. Cartier-Bresson mi ha dedicato un libro con “amicizia e ammirazione”. Ricevere la sua stima è stato come ottenere una medaglia d’oro, quella che oggi mostro con orgoglio a tutti. Potevo anche morire il giorno dopo, sarei morto contento. In realtà, molti dicono che non sono propriamente un suo erede. Se devo sentirmi erede di qualcuno, direi di Willy Ronis, un fotografo francese di grande talento. Ho perso delle foto del periodo parigino. Ne abbiamo persino alcune simili, perché spesso scattavamo fianco a fianco. Da Ugo Mulas imparai la differenza di questo concetto: una bella foto può piacere a tutti, ma spesso è una foto superficiale, come un bel tramonto senza alcuna intenzione. Una buona foto, invece, racconta qualcosa. Da allora ho cercato di fare buone foto, anche se per vivere ho scattato anche tante foto belle. La fotografia che non mi piace è quella “d’arte”, che riproduce quadri o copia della pittura senza senso. Per me la fotografia è documento.

Nella sua biografia colpiscono molto gli incontri con grandi intellettuali del suo tempo. Che influenza hanno avuto sul suo percorso?
GBG Ho lavorato quindici anni con Renzo Piano. Con Cesare Zavattini eravamo amici stretti: ogni volta che andavo a Roma, passavo a trovarlo. Poi c’era Franco Basaglia. Questi personaggi, diventati amici, mi hanno insegnato moltissimo. Ancora oggi ho la fortuna di sentirmi un dilettante che fa il professionista, spinto dalla passione. Ho avuto il privilegio di poter scegliere i lavori senza doverli cercare, e soprattutto il lusso di rifiutarli, se non mi piacevano. Ho lavorato molto nel mondo dell’industria che all’epoca offriva molte oppurtunità: alla Fiat, alla Olivetti per quindici anni, alla Dalmine e alla Piombino. Ho sempre fotografato il lavoro degli operai, mai il prodotto finito per il catalogo. Poi c’è stato un giornale mitico: Il Mondo di Pannunzio. Mi ha dato un’aura intellettuale, anche se non mi considero tale ma un istintivo. Con loro ho pubblicato molto. Ricordo ancora quei viaggi senza soldi per andare a Roma in terza classe su sedili che erano ancora di legno e dormendo in stazione.
Che cosa l’ha colpita di più nel documentare i manicomi e la realtà delle persone internate? Qual è stato l’impatto del lavoro di Franco Basaglia e del suo rifiuto dei metodi tradizionali sul suo modo di fare fotografia?
GBG Le mie foto nei manicomi furono tra le prime a raccontare visivamente quel mondo. Documentando il lavoro di Basaglia ho assistito alla trasformazione radicale della società e delle istituzioni italiane, specialmente nelle prigioni e nei manicomi. Era un uomo straordinario. Basaglia volle raccontare quella realtà nel libro “Morire di Classe”, realizzato con le mie foto e quelle di Carla Cerati, recentemente ristampato dal Saggiatore. Oggi questo volume viene mostrato nelle università di medicina per illustrare come venivano trattati i poveri e i malati. Basaglia sosteneva che, se eri ricco, finivi in una clinica in Svizzera; se eri povero, finivi in manicomio, dove spesso erano internate anche persone sane. Ricordo ancora come Basaglia, il primo giorno come direttore a Gorizia, rifiutò di firmare una richiesta per venti elettroshock. Fece abbattere le barriere fisiche e introdusse stanze singole o per due persone, affermando che i pazienti non dovevano subire trattamenti disumani. Con lui iniziò un cambiamento fondamentale, ben prima della legge 180.
“Ancora oggi ho la fortuna di sentirmi un dilettante che fa il professionista, spinto dalla passione. Ho avuto il privilegio di poter scegliere i lavori senza doverli cercare, e soprattutto il lusso di rifiutarli, se non mi piacevano”
Le sue foto più celebri sono quelle del bacio sotto i portici a piazza San Marco e quella della coppia in Gran Bretagna, seduti in una macchina, ma trovo che quelle più riprodotte le abbia scattate in viaggio, spesso dietro il finestrino di un treno. È d’accordo?
GBG Questa è una particolarità della mia fotografia: le immagini più belle le ho scattate sui treni o sui mezzi di trasporto. Paradossalmente, le foto che hanno avuto più successo sono quelle scartate all’inizio o quelle messe nei provini ai margini. È il caso del triplo ritratto scattato in un vaporetto. Purtroppo oggi è un genere che non si usa più. Pochi anni fa mi pagavano 150 o 200 euro per ogni foto pubblicata su La Stampa o il Corriere. Ora mi offrono 15 euro, quindi sarebbe impossibile vivere. I giovani si dedicano soprattutto alla moda e alla pubblicità, gli unici settori che permettono di guadagnare decentemente. Anche io avrei potuto fare fotografia di moda, ma ho sempre rifiutato. Anche la fotografia di guerra l’ho evitata: sono un fifone e non rischierei mai la vita per una foto. Ho una sola vita, me la tengo stretta. Sono andato una volta in zona di guerra, in ex-Jugoslavia, in Serbia e in Kosovo, ma mi sono spaventato e ho deciso che bastava così.
Nel corso della sua carriera Berengo Gardin ha realizzato 263 libri fotografici
Un altro aspetto della sua vita è l’incontro con tanti fotografi che l’hanno anche influenzata politicamente come Mario Dondero. Ci può raccontare?
GBG Quando vivevo a Venezia, frequentavo molti amici, molti dei quali comunisti, e così diventai comunista anch’io, non per letture teoriche ma per le amicizie e il lavoro in fabbrica, dove ascoltavo le difficoltà degli operai. Non ero un comunista stalinista, ma seguivo Enrico Berlinguer e la sua idea di una via italiana al comunismo; il mio era un comunismo attento ai problemi concreti della classe operaia. Il mio modello era Mario Dondero, che cercavo di imitare persino nel vestire quando lo incontravo a Milano. Altro incontro fondamentale fu quello con Gabriele Basilico. Durante i miei viaggi da Nord a Sud, mi fermavo spesso nelle Marche, a Senigallia, per incontrare Mario Giacomelli. In Sicilia, invece, conobbi Ferdinando Scianna, con cui ho avuto una lunga amicizia e collaborazione. Mentre lavoravo a Matera per il Touring Club, lo stesso giorno, conobbi due grandi come Sebastiao Salgado e Josef Koudelka. Sono stati anni incredibili.
© riproduzione riservata