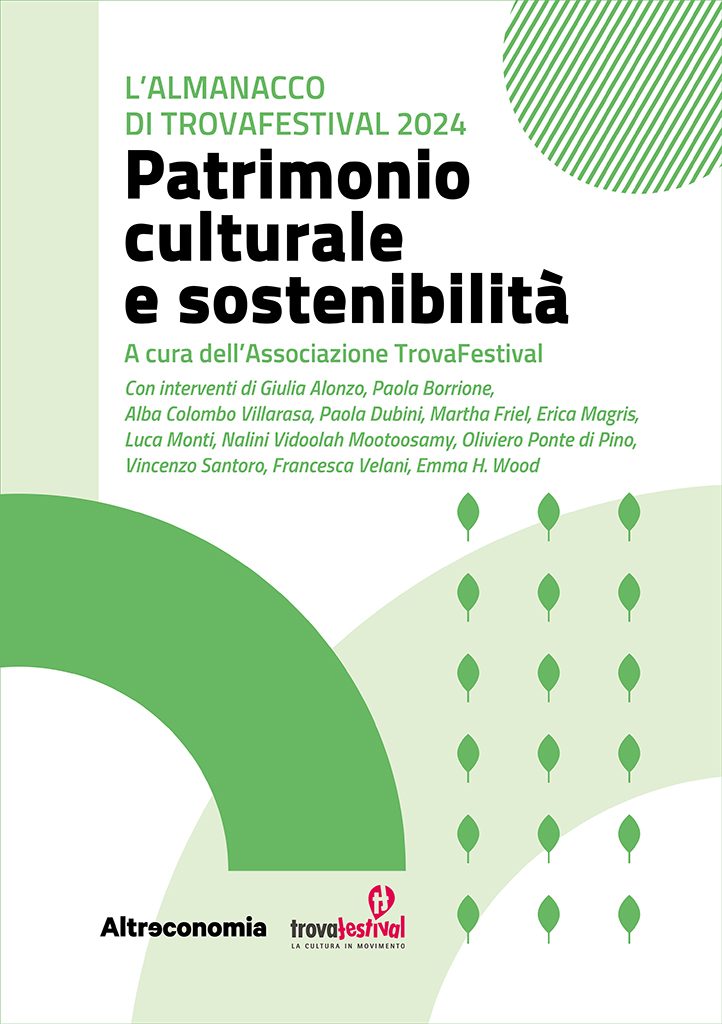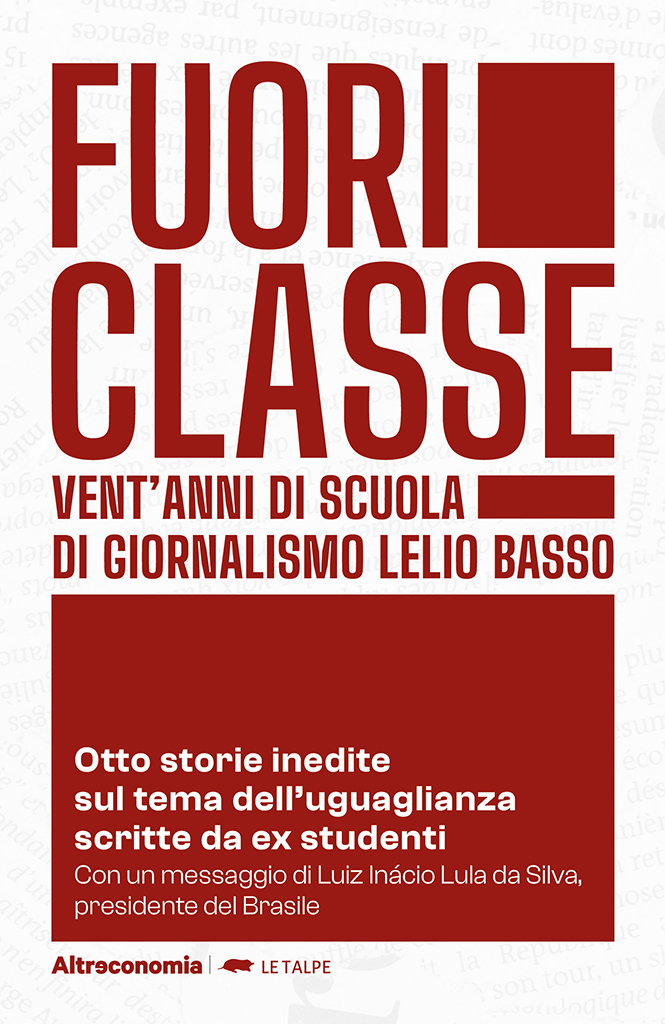Cultura e scienza / Intervista
Vinicio Capossela. Cantando di temi urgenti

Le tredici canzoni del nuovo album del cantautore trattano di guerra, epidemie, fine della convivialità, staffette partigiane e carcere. Una miscela musicale che trae ispirazione dalle opere poetiche e letterarie di Goethe, Brecht e Ariosto
È uscito il 21 aprile “Tredici canzoni urgenti”, il dodicesimo album in studio di Vinicio Capossela, cantautore, scrittore e polistrumentista tra i più influenti e importanti artisti della nostra scena musicale. Nato ad Hannover, in Germania, nel 1965, figlio di emigrati irpini, Capossela è l’erede ideale della tradizione del cantautorato italiano, di cui sono protagonisti Luigi Tenco e Fabrizio De Andrè, ma soprattutto di Matteo Salvatore: grande interprete dimenticato della musica folk che è stato riscoperto, proprio negli ultimi anni, grazie a Capossela stesso (da recuperare su YouTube un concerto integrale dei due, prima della scomparsa di Salvatore nel 2005).
Dopo due opere di profonda sperimentazione sulla musica tradizionale greca, “Rebetiko Gymnastas” (2012), su quella del meridione, “Canzoni della cupa” (2016), e con un disco di ritorno alle origini come “Ballate per uomini e bestie” (2019), Capossela ha realizzato un lavoro ancora più politico che, da un punto di vista compositivo, ricorda “Canzoni a manovella” (2000) e “Ovunque proteggi” (2006), con una preponderanza del pianoforte ma anche tanti archi, ottoni, strumenti elettronici. Molte le musiciste e i musicisti coinvolti e tante voci ospiti: Mara Redeghieri, Margherita Vicario, Irene Sciacovelli, Sir Oliver Skardy, Cesare Malfatti, Don Antonio (Gramentieri), FiloQ, Andrea Lamacchia, Alessandro “Asso” Stefana, Piero Perelli, Taketo Gohara, Mauro Ottolini, Michele Vignali, Daniela Savoldi, Enrico Gabrielli e il maestro Raffaele Tiseo.
Hai scritto e composto le canzoni del disco tra febbraio e giugno 2022, si avvertono quindi temi urgenti come la guerra, ovviamente, ma anche la polemica contro la fine della convivialità e il trionfo delle tecniche che sono temi che ricorrono nei testi di alcune canzoni.
VC Credo che sia in corso un’atomizzazione della società, anche attraverso la tecnologia e la domiciliazione delle interazioni. Una canzone a cui tengo particolarmente è “Il divano occidentale” che prende spunto un po’ dal famoso “Divano orientale occidentale” di Goethe, dove c’era un confronto con la poesia persiana. È interessante che il termine divan indichi sia un genere poetico, sia il consiglio dei saggi, quelli che esercitavano il potere insieme al Sultano, nell’Impero Ottomano. Le opere poetiche dovevano, in qualche modo, ispirare delle sagge decisioni.
Oggi, al contrario, la mia impressione è che dal “divano occidentale” attuale arrivino stimoli che vengono recepiti supinamente. Si alternano grandi questioni come il terrorismo, l’epidemia, la guerra che portano a una sorta di paralisi e di immobilità. Ci dibattiamo tra paure diverse, con un illusorio senso di partecipazione.
Credo che sia in corso un’atomizzazione della società, anche attraverso la tecnologia e la domiciliazione delle interazioni
Ci sono due riferimenti letterari, Bertolt Brecht e Ludovico Ariosto, che hanno ispirato almeno quattro canzoni. Perché ti sembrano importanti?
VC Per motivi diversi sono due autori che mi hanno accompagnato: sono partito prima da Ariosto per arrivare a Brecht. Il giovane Italo Svevo aveva concepito un’opera teatrale, che poi non realizzò mai: “Ariosto governatore”. Grazie a questo aneddoto ho scoperto l’esperienza di Ariosto come governatore in Garfagnana. Oggi viene ricordata la sua poesia per i caratteri del fantastico, ma in quell’occasione venne mandato, molto concretamente, ad amministrare la giustizia e l’economia di un territorio periferico. È stato interessante leggere nelle sue lettere, circa questo esercizio del potere amministrativo, come le decisioni non portassero a una reale incidenza sulla realtà.
È quello che succede con la poesia e con l’arte. Mi sono spesso interrogato sul senso dell’arte: sì, è vero, possiamo commuoverci, possiamo parteggiare, possiamo anche sistemare la coscienza, eppure come artisti non abbiamo la possibilità di incidere sulla realtà, non abbiamo altro da offrire che parole. Dall’altra parte Brecht avverte che le parole non devono essere completamente a servizio della denuncia: questo è il senso della canzone “La crociata dei bambini”. Ho iniziato a comporre all’inizio di questa ennesima follia della guerra in Europa, ma non è certo l’unico teatro di conflitto dove si fanno molti profitti con la vendita delle armi.
Ne “L’Orlando furioso” Ariosto parla dell’archibugio: la prima arma da fuoco della storia, strumento quasi magico, fatato, che permette non soltanto di uccidere, ma devastare e distruggere a distanza. Con sistemi sofisticatissimi, oggi, possiamo distruggere varie volte il mondo. Questo genere di violenza, quasi impersonale, permane anche nei droni, nei missili, nelle bombe a distanza. Ciò era chiarissimo, negli anni precedenti allo scoppio della Seconda guerra mondiale, nelle poesie di Brecht, il quale non aveva altro da offrire che le sue parole, ma queste incidevano sulla menzogna del potere e, in qualche modo, obbligavano all’opposizione e alla lotta. Due poeti, completamente opposti, che ci parlano da un lato dell’impotenza delle parole, dall’altro della loro efficacia.
Brecht e Ariosto sono due poeti opposti, che ci parlano da un lato dell’impotenza delle parole, dall’altro della loro efficacia
Colpisce la canzone “Staffette in bicicletta”, perché ha un’esplicita retorica positiva. Puoi raccontare la genesi?
VC A Scandiano, in provincia di Reggio Emilia, il paese dove sono cresciuto, si conserva la memoria di tutto quello che è stata la lotta partigiana e la guerra civile di quegli anni. Quelli che elenco nel testo erano i nomi scritti sui gradoni di un piccolo anfiteatro, nomi di un’altra Italia, che non si usano più. Hanno la forza e l’evocazione proprio di quella generazione, di quelle persone, quelle donne in particolare, che hanno vissuto la Resistenza, il dopoguerra. Gente che aveva molto chiaro quale fosse il proprio dovere. Siccome la figura della staffetta evoca il passaggio del testimone, credo che la memoria oggi sia la vera staffetta per mantenere vive, nelle lotte che si alternano e si avvicendano nel presente, il senso profondo di prendere parte alla storia. Le vicende delle persone comuni non entrano nei libri di storia.
Tra i temi c’è anche il carcere e il paternalismo istituzionale, con una delle ballate più belle del disco che è “Minorità”.
VC Ho voluto porre l’attenzione sul fatto che lo Stato si arroga il diritto di prendersi interamente a carico delle vite, sottratte dal vivere comune. Si tratta di un affidamento totale, in un sistema in cui si deresponsabilizzano i singoli. Ciò è evidente nel lessico, la famosa “domandina”, ma tutto si restringe: tutte le volte che mi è capitato di fare qualche spettacolo in luoghi di detenzione, si notano subito questi corpi ridotti, infantilizzati come dei grossi bambini.
Questa è una condizione più generale dell’uomo di affrancarsi da modelli sbagliati, che si è introiettato senza accorgersene nella cosiddetta cultura patriarcale, non solo paternalista. La celebre definizione dell’illuminismo di Immanuel Kant “uscire dallo stato di minorità”, è una condizione certo di detenzione carceraria, ma anche esistenziale. Il che significa sostanzialmente assumersi la responsabilità. Mi ha molto colpito, per esempio, che Giorgia Meloni, nel non entrare nel Governo Draghi, abbia preso a prestito proprio delle citazioni simbolo di Brecht: “Ci sedemmo dalla parte del torto perché tutti gli altri posti erano occupati”, un poeta che ha dato voce ai senza storia, ai senza volto. Questo è un esempio di come le parole possano essere private del loro senso originario. I liberisti usano molto la parola libertà. Eppure, per me la libertà non può essere dissociata dalla responsabilità. “Dalla parte del torto” è proprio su questo tema.
Le ultime due canzoni del disco sembrano recuperare una sfiducia che attraversa tutto il tuo ultimo lavoro. È così?
VC La penultima è “Tempo di regali”: un titolo che ho preso in prestito da un’opera di Patrick Leigh Fermor, uno scrittore meraviglioso che ho scoperto solo di recente acquistando il libro, solo per questo titolo, meraviglioso. È il diario di viaggio che lui fa da giovanissimo, a piedi come i viandanti del Medioevo, da Londra a Istanbul negli anni Trenta del Novecento prima della tragedia della guerra (in Germania è appena salito al potere Hitler).
Fermor ha uno sguardo che sa meravigliarsi, cogliere la luce e il miracolo dell’incontro. All’inizio c’è una citazione: “Il tempo dei regali è andato, amici miei”. Questa è un po’ la lezione di Fermor: il senso della gratitudine che non indulge mai nella nostalgia, è questo che spero di dare anche nello spirito di questa canzone. L’ultima traccia, “Con i tasti che abbiamo”, la dice lunga sul modo in cui cerco di prendere l’esistenza. Ho scritto questa canzone perché qualche anno fa i miei nipoti, giocando, hanno rotto dei tasti del pianoforte che erano stati poi rimossi dall’accordatore per ripararli. Per sei mesi il mio pianoforte era sdentato con dei buchi neri e ho provato a suonare solo i tasti rimasti, ottenendo comunque una melodia. Questa semplice allegoria mi ha insegnato che si può trasformare il limite in una possibilità. Significa anche riuscire a fare qualcosa dei buchi neri che ci sono rimasti. E soprattutto c’è il gioco che è essenziale. Il fine del gioco è anche quello di giocare, non solo di avere un utile.
© riproduzione riservata