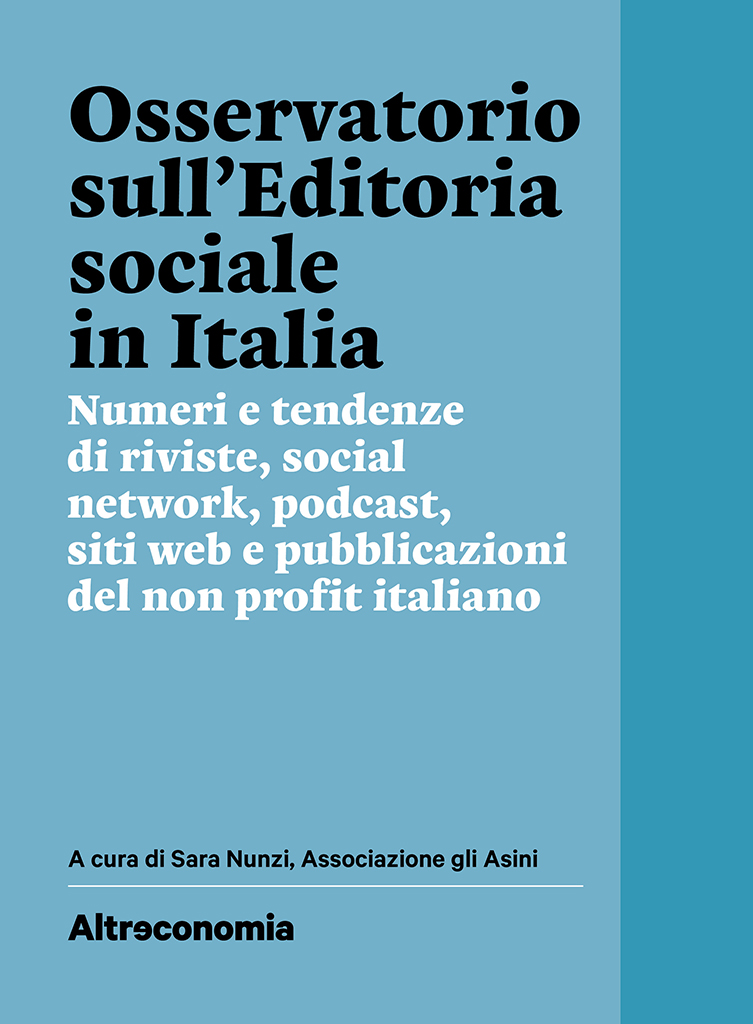Altre Economie
Senegal, land grabbing all’italiana

Due morti e 23 feriti è il risultato degli scontri avvenuti lo scontro 26 ottobre nella comunità rurale di Fanaye, situata nel Nord del Senegal nella River Valley al confine con la Mauritania. Motivo degli scontri l’assegnazione da parte delle autorità amministrative locali di ventimila ettari di terreno per la coltivazione prodotti agricoli da destinare al mercato alimentare e dei biocarburanti italiano.
Dietro all’investimento un’impresa a capitale misto senegalese italiano, la Senethanol SA, che nel giugno scorso ha ottenuto la cessione di trecento ettari per avviare la produzione di patata dolce e girasole da destinare al mercato alimentare e dei biocaburanti su un’estensione totale prevista in 20.000 ettari.
Da un lato, i sostenitori del progetto, tra cui i presidente del Consiglio Rurale, l’autorità competente per la gestione dei terreni pubblici, che affermano che quell’investimento garantirà occupazione e sviluppo locale; dall’altro la maggioranza dei villaggi situati nei terreni che saranno coinvolti nella coltivazione preoccupati delle conseguenze che tale produzione avrà per la sicurezza alimentare di migliaia di persone che in quell’area praticano agricoltura su piccola scala, allevamento e pesca. Sullo sfondo un Paese, il Senegal, che importa il 60% del proprio fabbisogno alimentare, con il 70% della popolazione attiva impiegata in agricoltura, fortemente colpito dalla crisi dei prezzi del 2007-2008 e che ha aperto le porte al capitale estero per sostenere il proprio sviluppo agricolo e la propria sicurezza energetica.
Grazie alla forte mobilitazione dei villaggi, organizzati nel Collettivo per la difesa delle Terre di Fanaye, il caso ha avuto una eco internazionale che ha raggiunto l’apice a causa dei tragici eventi del 26 ottobre scorso quando, nel tentativo di impedire la riunione del Consiglio Rurale, gli scontri tra oppositori e sostenitori del progetto hanno avuto esisti tragici. In conseguenza di ciò, il governo senegalese ha prima deciso la sospensione del progetto e, successivamente all’incontro avvenuto tra rappresentanti del Collettivo ed il presidente senegalese Abdoulaye Wade, quest’ultimo ha deciso l’annullamento dell’autorizzazione.
Il caso Fanaye è emblematico per spiegare quello che viene definito “Land Grabbing”, un termine ormai entrato a pieno titolo nel dizionario dei movimenti sociali e delle organizzazioni della società civile che criticano la globalizzazione. Letteralmente lo possiamo tradurre come “accaparramento di terre” e non a caso ha un’accezione negativa, perché racconta di enormi estensioni di terreni che finiscono sotto il controllo di multinazionali ed élite locali e a farne le spese sono milioni di persone che vivono in quelle terre e da esse traggono la principale risorsa per la loro sopravvivenza: il cibo.
In questo caso parliamo di 20000 ettari affittati , secondo quanto riportato dalla memoria preparata dal Collettivo, a prezzi irrisori: 25000 CFA all’ettaro, ovvero circa 38 euro.
Oltre alle irregolarità delle procedure di assegnazione dei terreni, il Collettivo denuncia la mancata consultazione delle popolazioni locali. Inoltre, il terreno in questione è soggetto a vincoli in quanto zona agropastorale a priorità per l’allevamento. Le critiche del Collettivo vanno al cuore del problema che il land grabbing pone per la sovranità alimentare di un Paese. I 20000 ettari verrebbero infatti sottratti alla popolazione privandola terreni coltivabili, aree di pascolo, foreste e laghi, con conseguenze negative dal punto di vista sociale e ambientale. E tutto questo in nome di uno sviluppo che vede i Paesi africani svendere i loro terreni per l’appetito di imprese europee, anche italiane come in questo caso, che hanno bisogno di materia prima agricola a basso costo per il mercato dei biocaburanti.
Sono secoli che i Paesi del Sud vengono depredati delle loro risorse e la terra è una di queste. Ciò che rende attuale ed insieme nuovo questo fenomeno è legato soprattutto ai fattori che lo determinano, alla scala che lo caratterizza ed al contesto – quello di una profonda crisi dei mercati agricoli – nel quale si realizza. Infatti, la crisi alimentare del 2007-2008, conseguenza di un aumento incredibile dei prezzi dei prodotti agricoli sui mercati nazionali e su quello internazionale, ha segnato uno spartiacque fondamentale per l’agricoltura: è finita l’era dell’abbondanza, il cibo sarà sempre più caro, i suoi prezzi sempre più volatili, le conseguenze per la sicurezza alimentare di miliardi di persone enormi e controllare la produzione sempre più redditizio. A guidare l’aumento della domanda, a dire il vero con diverso grado di importanza, la crescita demografica, l’aumento del consumo di carne e latticini determinata dall’aumento del reddito dei Paesi emergenti e una crescente richiesta di prodotti agricoli per il mercato dei biocarburanti. Tutto questo a fronte di un progressivo calo dell’offerta determinato dagli effetti dei cambiamenti climatici (eventi estremi, erosione dei suoli etc.) e dalla mancanza di adeguati investimenti in agricoltura.
La crisi dei prezzi e l’aumento degli investimenti di land grabbing sono espressione di un problema comune: l’assenza di adeguate politiche pubbliche in agricoltura orientate all’affermazione del diritto al cibo. Da un lato ci sono quasi un miliardo di affamati che vivono nelle città ma, ancora in prevalenza, nelle campagne, che non sono in grado di far fronte all’aumento dei prezzi – e non riescono a produrre a sufficienza per il proprio sostentamento – e pagano il prezzo più alto della crisi a causa dell’assenza di interventi adeguati in grado di sostenere il reddito e la produzione; dall’altro ci sono investitori agricoli, pubblici e privati, e nuovi attori come imprese energetiche e fondi di investimento finanziari, che considerano il controllo della risorsa terra (e con ciò della produzione) un investimento fortemente redditizio. Arbitri per niente imparziali di questa partita sono governi e le istituzioni internazionali che dietro la retorica di disegnare una strategia win-win, ovvero in cui a vincere sono tutti: investitori ed “investiti” (le comunità locali), in realtà non fanno altro che promuovere un modello di sviluppo agricolo fallimentare che determina la concentrazione della terra in poche mani (grazie a politiche fondiarie che non tutelano i soggetti più deboli come i piccoli contadini), l’aumento dell’insicurezza alimentare, rischi per l’ambiente ed un complessivo deterioramento delle condizioni di vita, spesso già fragili, delle popolazioni che vivono nelle aree rurali nei Paesi del Sud.
Catturare la dimensione esatta del fenomeno è impossibile. Ma le stime danno comunque l’idea di ciò che sta avvenendo. Secondo la Banca mondiale, e sono stime al ribasso, negli ultimi cinque anni circa 46 milioni di ettari di terreni sono stai oggetto di negoziazioni commerciali. Altri dati parlano di una cifra che per il solo continente africano oscilla tra i 50 ed i 60 milioni di ettari. Il continente nero è la destinazione principale dei cacciatori di terre, in quanto vi è ampia disponibilità di terra a prezzi stracciati. A guidare la domanda di terreni in Africa, oltre alla necessità di garantire la sicurezza negli approvvigionamenti alimentari da parte dei Paesi del Golfo e di alcuni Paesi asiatici come la Cina e la Corea del Sud, c’è l’aumento della richiesta di produzione agricola da destinare al mercato dei biocaburanti, in particolare quello europeo. Secondo uno studio realizzato dalla FAO e dallo IEED, che hanno preso in esame le acquisizioni di terreni in cinque Paesi africani dal 2004 al 2009, l’ammontare complessivo di superfici coinvolte è stato di di 2,5 milioni di ettari metà dei quali destinati alle agroenergie.
Il sostegno di molti alla produzione di biocombustibili necessari al raggiungimento degli obiettivi obbligatori di utilizzo (che l’Ue ha fissato nel 10% del totale il consumo di carburanti proveniente di fonti rinnovabili nel 2020, cui la parte del leone la faranno proprio i biocombustibili) ha determinato un aumento dei volumi prodotti e con essi delle superfici agricole utilizzate. Numeri alla mano, a livello globale è stimato che il consumo di biocarburanti nel 2030 determinerà la conversione di terreni per un ammontare oscillante tra i 18 ed i 44 milioni di ettari con evidenti impatti anche sul livello di emissioni. Se le quote di consumo obbligatorie stabilite dalle principali economie del mondo, tra cui, in particolare, Stati Uniti ed Unione europea, verranno mantenute, tra il 2008 ed il 2018 si stima che la domanda proveniente dal settore dei biocaburanti rappresenterà il 54% dell’incremento della domanda di mais e frumento ed il 32% per le oleaginose. Di fronte a questi dati, è evidente che per sostenere la produzione di biocombustibili sarà necessaria sempre più terra e che in continenti come quello africano vi è disponibilità a prezzi molto vantaggiosi.