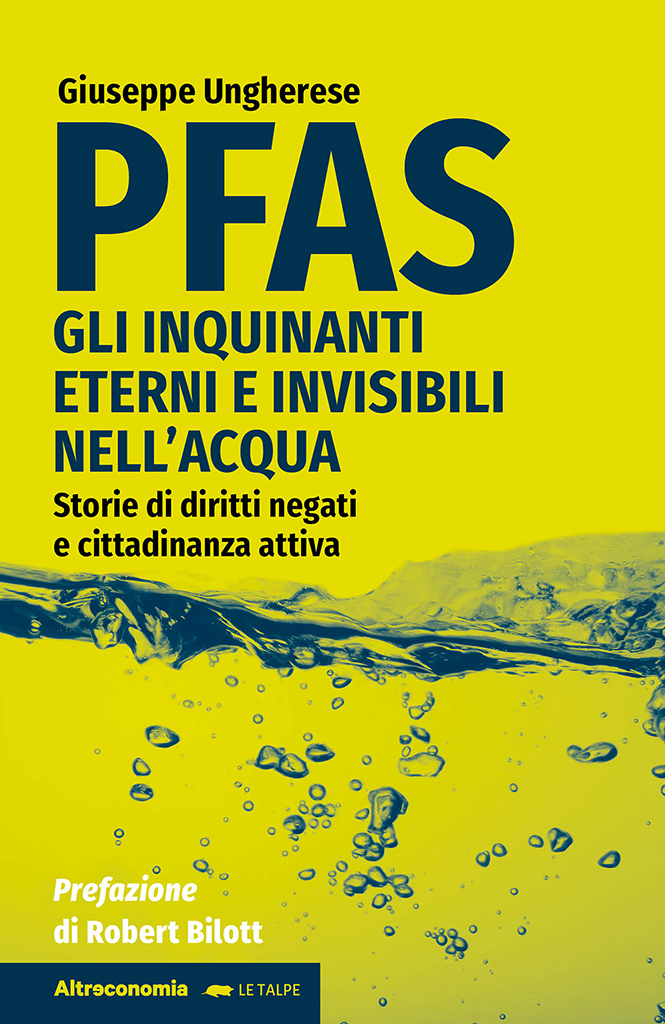Ambiente / Approfondimento
La Terra è abitabile grazie agli oceani. Ecco perché -e come- dobbiamo prendercene cura

Affacciato sulle loro coste vive il 37% della popolazione mondiale. Secondo le Nazioni Unite, i servizi ecosistemici che sono in grado di garantire ogni anno “pesano” circa 28mila miliardi di dollari. Ma gli oceani soffrono i cambiamenti climatici. Il nostro viaggio alla loro scoperta grazie a studiosi ed esperti del nostro Paese
La boa viene rilasciata da una nave e sprofonda nell’oceano a duemila metri di profondità. Ha una vita di due, al massimo tre anni. Mentre si inabissa raccoglie dati sulla sua posizione, sulla temperatura e salinità dell’acqua. Non è sola: con altre 3.900 “sorelle” compone oggi -a metà maggio 2017- la flotta del progetto di ricerca internazionale ARGO (argo.ucsd.edu). Quando riemerge comunica i risultati ad un satellite. Questo li impacchetta e li inoltra ai centri di ricerca di tutto il mondo, dove li incrociano con modelli matematici e osservazioni precedenti “in situ”. Le navi oceanografiche solcano gli oceani e raccolgono campioni biologici, analizzando i dati su ampie aree del globo. L’oceano del passato e del presente si studia anche così. Palmo a palmo. Ed è un lavoro che dal 2000 sta permettendo all’uomo di conoscere un ecosistema fino ad allora esplorato con strumenti poco sofisticati. Ma non è ancora sufficiente. Resta una parte degli oceani da esplorare di più. La parte “vivente”, attraverso tecnologie di rilevamento che permettano di osservare quella risposta biologica ed ecologica ai cambiamenti fisici e chimici che hanno un forte impatto sulle attività umane e sulla nostra stessa sopravvivenza.
Oscuri ma fondamentali per la vita sul nostro Pianeta, gli oceani -cui è stata dedicata la giornata mondiale dell’8 giugno- sono infatti minacciati dall’impronta dell’uomo, che sta lasciando un segno indelebile. Quello dei cambiamenti climatici.
Eppure affacciato sulle loro coste vive il 37% della popolazione mondiale. Che quasi mai se ne cura: si stima infatti che nel 2010, i 192 Paesi “costieri” abbiano prodotto qualcosa come 275 milioni di tonnellate di rifiuti plastica, 8 milioni delle quali sarebbero giunte al mare. Ogni anno. Considerandoli come un’unica distesa, gli oceani coprono il 71% della superficie del Pianeta e la loro profondità media è di 3.700 metri (quando la terra, invece, è “alta” in media “solo” un chilometro). Il 17% delle proteine animali che l’uomo consuma arriva da lì e questo valore oltrepassa il 20% per più di 3 miliardi di persone. La biodiversità che custodiscono ci tutela: la barriera corallina e le mangrovie, per esempio, agiscono a protezione delle coste contro tsunami o tempeste. Il 90% delle cose che utilizziamo li attraversano. E secondo un calcolo indicativo fatto proprio dal Consiglio economico e sociale delle Nazioni Unite nel 2015, i servizi ecosistemici che gli oceani sono in grado di garantire ogni anno “pesano” circa 28mila miliardi di dollari.

È un patrimonio a rischio che i Paesi dell’Onu si sono impegnati a “conservare”. Una responsabilità scolpita negli Obiettivi di sviluppo sostenibile (un.org/sustainabledevelopment) sottoscritti il 25 settembre 2015 e proiettati al 2030. Il quattordicesimo si prefigge l’uso attento degli oceani, dei mari e delle risorse marine. E un fondamentale appuntamento di verifica e rilancio della parola data è la Conferenza sugli oceani prevista dal 5 al 9 giugno a New York (oceanconference.un.org). L’hashtag è chiaro: #SaveOurOcean. “Salvare” dà l’idea dell’urgenza. Di norma si è portati ad osservare gli effetti del cambiamento climatico e dello scostamento medio delle temperature -il “riscaldamento globale”- sulla “terra ferma”, ignorando i riflessi sugli oceani. Ma è un errore.
La professoressa Nadia Pinardi insegna Oceanografia fisica presso il dipartimento di Fisica e astronomia dell’Università di Bologna. Nel marzo di quest’anno, l’Università di Liegi le ha conferito la laurea honoris causa introducendola così: “Se chiedete a un oceanografo chi più di tutti abbia contribuito a dar forma al panorama europeo delle previsioni oceaniche, probabilmente la risposta che avrete sarà Nadia Pinardi”, che è anche parte del consiglio strategico del Centro euro-Mediterraneo per i Cambiamenti Climatici (CMCC, cmcc.it) dove ha fondato a Lecce l’OceanLab, il laboratorio di ricerca avanzata nell’ambito dell’oceanografia operativa. Sceglie parole semplici per raccontare la sua passione. “Un anno chiave nella biografia recente degli oceani è il 1992, l’anno della Conferenza delle Nazioni Unite sullo sviluppo sostenibile. Per la prima volta venne posto l’accento sull’oceano, allora praticamente inesplorato, descritto come uno degli ambienti naturali su cui investire in ricerca e tecnologie per poter avere un futuro”. Un futuro che si basa sull’osservazione dello stato di salute. Gli oceani, infatti, sono una spugna che ha silenziosamente assorbito e attutito gli effetti devastanti dei cambiamenti climatici. Non a caso il Gruppo intergovernativo sul cambiamento climatico dell’ONU (IPCC) gli ha dedicato un capitolo dell’ultimo rapporto sul climate change (2016): il 93% del calore accumulato in atmosfera, infatti, è assorbito dagli oceani. Una traccia che resta. “Attraverso tutti gli oceani corre un ‘nastro trasportatore climatico’ che porta negli abissi l’acqua superficiale -spiega Pinardi-. Nella parte abissale dell’oceano esiste quindi una memoria di quello che accade in atmosfera. E lì, ‘intrappolata’ negli abissi, può impiegare fino a 3mila anni prima di tornare in superficie. Quando queste acque ‘calde’ sprofondano le temperature cambiano: e un decimo di grado è un cambiamento notevolissimo per il fondo dell’oceano, che può comportare ad esempio il blocco di quel nastro o ‘serpentone’”.

Il Mediterraneo -un piccolo oceano- raccoglie i segni di un cambiamento avvenuto migliaia di anni fa ricostruito grazie ai carotaggi sul fondale. “Si tratta dell’ultimo periodo glaciale, 22mila anni fa -racconta Pinardi-. Il livello del mare era 120 metri sotto a quello di oggi. Man mano è andato riempiendosi con lo scioglimento dei ghiacci alpini risalente a 8-9mila anni fa. Questo determinò un blocco del ‘serpentone climatico’, il rallentamento della circolazione marina fino alla stagnazione e alla diminuzione dell’ossigeno. La formazione di strati anossici, cioè senza ossigeno, provata dai sedimenti di materiale organico sul mare caratterizzati da un’importante percentuale di carbonio organico, è un problema. Il mare è stato capace di rigenerarsi ma ci sono voluti migliaia di anni”.
Un periodo che l’attuale “sviluppo” umano non ha preso in considerazione. “Dal 1880 a oggi la media globale della temperatura superficiale del Pianeta è aumentata di 1,1° C -racconta l’ oceanografa Simona Masina, esperta di modellistica oceanica e titolare del corso ‘Dinamica dell’oceano’ nel programma di dottorato in Scienza e Gestione dei Cambiamenti Climatici, nato nel 2007 dopo un accordo tra l’università Ca’ Foscari di Venezia e il CMCC-. Il 2016 è stato il terzo anno di fila più caldo da quando abbiamo le osservazioni. Un trend che non è naturale. La parte più consistente di questo cambiamento è avvenuta negli ultimi 35 anni. Fino a poco tempo fa si pensava che il problema dell’immissione di gas serra fosse limitato all’atmosfera. Ma questa visione sta cambiando da quando c’è l’evidenza che gran parte del calore introdotto nel sistema climatico viene immagazzinato dagli oceani dotati di un’inerzia termica molto maggiore di quella dell’atmosfera”. Tra gli effetti più evidenti di questo “oceano caldo” spicca l’innalzamento del suo livello medio, determinato anche dall’espansione dell’acqua, cioè dall’aumento del suo volume: “Dal 1990 -prosegue Masina- il livello marino globale è aumentato di 3,1 millimetri ogni anno. Può apparire un valore irrisorio ma bisogna ricordare che l’aumento non è uniforme. Significa ad esempio che ci sono zone costiere in cui il livello è cresciuto di 6 millimetri all’anno. In 10 anni sono 6 centimetri che per alcune località rappresenta un cambiamento evidente. Ed è una tendenza destinata a continuare”. L’oceano non “cattura” solo il calore ma anche un quarto di tutta l’anidride carbonica (CO2) prodotta dalla combustione delle fonti fossili. La CO2 che è costretta ad “accogliere” -circa 30 milioni di tonnellate al giorno- sprofonda nei suoi abissi, lentamente, provocando cambiamenti che mettono a rischio l’ecosistema marino e di riflesso le funzioni vitali legate anche alla salute umana. Il gas serra incide sul suo pH -intorno al valore 8- determinandone l’acidificazione. Un ambiente acido scioglie, non permette la calcificazione degli scheletri di carbonato di calcio come coralli. Li sbianca, impedisce la formazione di conchiglie, determina disordini riproduttivi nei pesci. Il professor Roberto Danovaro, presidente della Stazione zoologica Anton Dohrn di Napoli (szn.it) spiega: “I mari sono un’immensa soluzione tampone con pH basico, pH8. L’acidificazione è indotta dallo scioglimento dell’anidride carbonica in acqua di mare. Le condizioni previste di qui al 2100 con la diminuzione di 0,2-0,3 unità di pH renderebbero difficile se non impossibile la calcificazione in molti organismi come il corallo rosso e tanti altri organismi di interesse anche economico e commerciale. Inoltre sta diminuendo anche la concentrazione di ossigeno nel mare, cosa che può mettere a rischio molte specie marine, in particolare in ambienti costieri”.

Dal 1990 il livello medio del mare è cresciuto di 3,1 millimetri l’anno, con punte di 6 millimetri – © www.flickr.com/photos/ Unep – Kadir van Lohuizen / NOOR
Nell’Accordo di Parigi stipulato nel dicembre 2015 ed entrato in vigore il 4 novembre 2016, la parola “oceani” compare una volta. Valentino Piana, economista e consulente internazionale, direttore dell’Economics Web Institute (economicswebinstitute.org) nonché curatore della pagina accordodiparigi.it, è stato tra i primi a tradurlo in italiano (in rete si trova il pdf pubblicato da Lulu Editore). Nel “commento” al passaggio sugli oceani -bollato come una “nota un po’ riduttiva su questioni fondamentali”- Piana rammenta che “l’acidificazione degli oceani, al contrario della desertificazione, non ha una propria Convenzione quadro ma sta emergendo come drammatica”. Se nulla dovesse cambiare -e cioè lo scenario di emissioni di gas climalteranti restasse da qui al 2100 quello attuale, “business as usual”- il pH dell’oceano potrebbe toccare il punto più “basso” da 20 milioni di anni a questa parte. Una previsione contenuta in un lavoro scientifico indirizzato non più tardi di un anno fa ai Paesi membri del G7 -Stati Uniti, Canada, Germania, Regno Unito, Francia, Italia e Giappone-, sottoscritto anche dall’International Council for Science (ICSU, www.icsu.org). S’intitola “Il futuro dell’oceano e dei suoi mari”. Cinquanta pagine e sette capitoli divulgativi: oltre a quello sull’acidificazione ce n’è uno dedicato alla degradazione dell’ecosistema marino. L’ha curato, insieme ad altri esperti di scienze marine, Ferdinando Boero, professore di Zoologia all’Università del Salento. Per illustrare gli impatti dell’overfishing (pesca eccessiva) legale e illegale ha inserito tre fotografie della stessa gara di pesca di West Keys, in Florida. Una sopra l’altra. La prima è del 1957, la seconda del 1980 e la terza è del 2007, dieci anni fa. “I pesci della prima istantanea -spiega Boero ad Altreconomia- sono più grossi dei pescatori. Nella seconda sono molto più piccoli e nella terza lo sono ancora di più. È una dimostrazione pratica di come abbiamo depauperato il capitale naturale dell’oceano. In un modo terribile e in pochissimo tempo”. Boero suggerisce di guardarsi intorno. “Se entriamo in un supermercato e cerchiamo prodotti che provengano dall’ambiente terrestre ci rendiamo conto che sono tutti coltivati o allevati. Non c’è nulla che provenga da una popolazione naturale. Il motivo è che le abbiamo distrutte tutte e sostituite con artificio. Nell’ambiente acquatico, invece, siamo ancora allo stadio di cacciatori e raccoglitori. Li peschiamo. Ci sono ancora popolazioni naturali in grado di sopportare un prelievo industriale. Però con il tempo stiamo passando all’acquacoltura: alleviamo carnivori e gli diamo da mangiare farina di pesce. È una follia che sfugge solo a certi economisti. Nel Mediterraneo la pesca industriale è insostenibile, tant’è vero che compriamo permessi di pesca in Mauritania e in Sudan”.
Durante una pausa di lavoro nelle acque del Mediterraneo, e precisamente a Portofino, Paolo Guidetti -professore di Ecologia all’Università “Sophia Antipolis” di Nizza e direttore del laboratorio ECOMERS- riflette a voce alta sulla conservazione degli ecosistemi marini costieri e la gestione della pesca. Le sue materie di ricerca. Stando agli Obiettivi di sviluppo sostenibile dell’Onu, la fine della pesca incontrollata o illegale -un quinto della pesca in generale, si stima- e il raggiungimento di un (difficile) equilibrio, genererebbero oltre 3mila miliardi di euro l’anno, l’equivalente di 32mila posti di lavoro a tempo pieno soltanto nell’Unione europea.

“La pesca industriale porta a una destabilizzazione totale degli ecosistemi e delle comunità -spiega Guidetti-. Incide pesantemente sulle popolazioni dei grandi predatori, in termini di numerosità, taglie ed età. Penso alle cernie sotto costa o agli stock dei merluzzi o degli squali costieri in aree mediterranee. Gli effetti possono essere molto dannosi”. In che termini? “Nel Mediterraneo è evidente dappertutto dallo stretto di Gibilterra al bacino levantino. Le cernie sono tra i predatori più importanti: quelle rimaste cercano di sfuggire alla pesca costiera, non solo professionale ma anche sportiva e ricreativa, spostandosi in profondità. Mangiamo erbivori a terra ma carnivori in acqua, e quando si impattano stock di grandi predatori si produce un effetto domino sulla struttura dell’intera comunità”.
95% la percentuale di biosfera totale che sta in acque profonde, in abissi freddi e senza luce
Lo sfruttamento industriale si lega all’aumento delle temperature delle acque superficiali, scintilla di un esodo di massa di specie tropicali alla ricerca di acque meno surriscaldate. Sono quasi mille nel “mare nostro”. Per Guidetti è in atto un autentico “sconvolgimento nell’Est Mediterraneo”. “La porta aperta dall’uomo con il Mar Rosso, l’aumento globale delle emissioni e il ‘riscaldamento’ delle acque, hanno prodotto l’ingresso di nuove specie. Quando entrano non si trovano dinanzi alcun esercito naturale di contrasto, fatto ad esempio di cernie o branzini, e sono quindi libere da qualsiasi pressione predatoria. Nelle coste a Sud della Turchia il 70-80% dei pesci non sono più mediterranei: sono entrati pesci erbivori dal Mar Rosso, come il pesce coniglio, che stanno soppiantando la specie erbivora mediterranea, la salpa, e stanno desertificando i fondali rocciosi del Mediterraneo, dove i pesci piccoli trovavano nutrimento e rifugio. È una minaccia alla biodiversità dei nostri mari”. Cita un tentativo disperato di fermare il fenomeno: libri di cucina per far consumare specie “aliene”. O, per citare il professor Boero, “profughe”, in quanto fuggono da aree tropicali ormai troppo calde e dove le formazioni coralline sono a forte rischio di estinzione. La “pesca sostenibile” non è un ossimoro. “Nell’area marina protetta (AMP, ndr) di Torre Guaceto in provincia di Brindisi -racconta Guidetti- pescatori, la stessa AMP, associazioni come SlowFood e ricercatori si sono seduti a un tavolo per tentare di concordare modalità di prelievo della pesca basate sulla cooperazione e non sulla concorrenza. Si è ridotta la lunghezza delle reti, ampliate le maglie, deciso di non pescare tutti i giorni nella zona tampone dell’AMP, intorno alla zona di non-prelievo. Poi abbiamo confrontato le catture: a quasi 7 anni dall’avvio dell’esperienza, si pesca 2 o 3 volte di più rispetto all’esterno, dove c’è concorrenza selvaggia”. Una luce in un mare la cui superficie dichiarata formalmente “protetta” è pari al 6,5% e quella di “non prelievo” è ferma a un misero 0,04% in Mediterraneo. “Se si considera ottimisticamente che la metà del dichiarato sia effettivamente tutelata, ci si rende conto della situazione imbarazzante. A fronte di impegni internazionali (l’Aichi Target 11 che fa riferimento alla Convenzione sulla Biodiversità) che puntano alla protezione di almeno il 10% delle acque territoriali, entro il 2020, in maniera efficace e socialmente accettabile per sostenere le economie locali”.
17% sono le proteine animali che l’uomo consuma derivanti dagli oceani
Nel rapporto indirizzato al G7 sul “Futuro degli oceani”, Boero propone la promozione della “ocean literacy” nei curricula scolastici. Un’alfabetizzazione ecologica necessaria. “Non possiamo rispettare quel che non conosciamo”, dice. A giugno, a New York, alla Conferenza ONU dedicata all’ecosistema, il nostro Paese sarà rappresentato anche dal progetto “OLI”. L’acronimo sta proprio per “Ocean Literacy Italia” (oceanliteracyitalia.it), neonata rete fatta di Università, licei, centri di ricerca, onlus, che si propone di “diffondere anche nel nostro Paese -circondato dal mare e storicamente, culturalmente, economicamente legato al mare- la cultura dell’oceano”. Un’idea fondata su sette principi. Il quarto ricorda che è “il mare a permettere che la terra sia abitabile”. E, come ricorda il professor Danovaro, “oltre il 95% della biosfera sta in acqua profonde, in abissi freddi e senza luce”. Come dire, non ce la caviamo da soli. Con buona pace di chi, come l’astrofisico Stephen Hawking, propone di “cercare un Pianeta alternativo su cui un giorno l’uomo potrà abitare”.
© riproduzione riservata