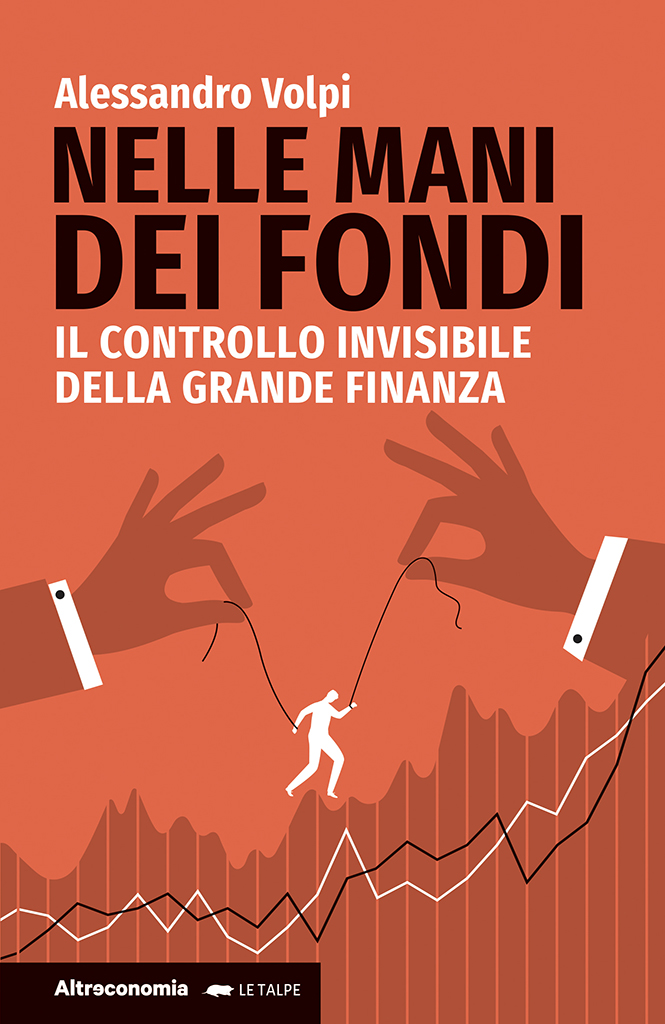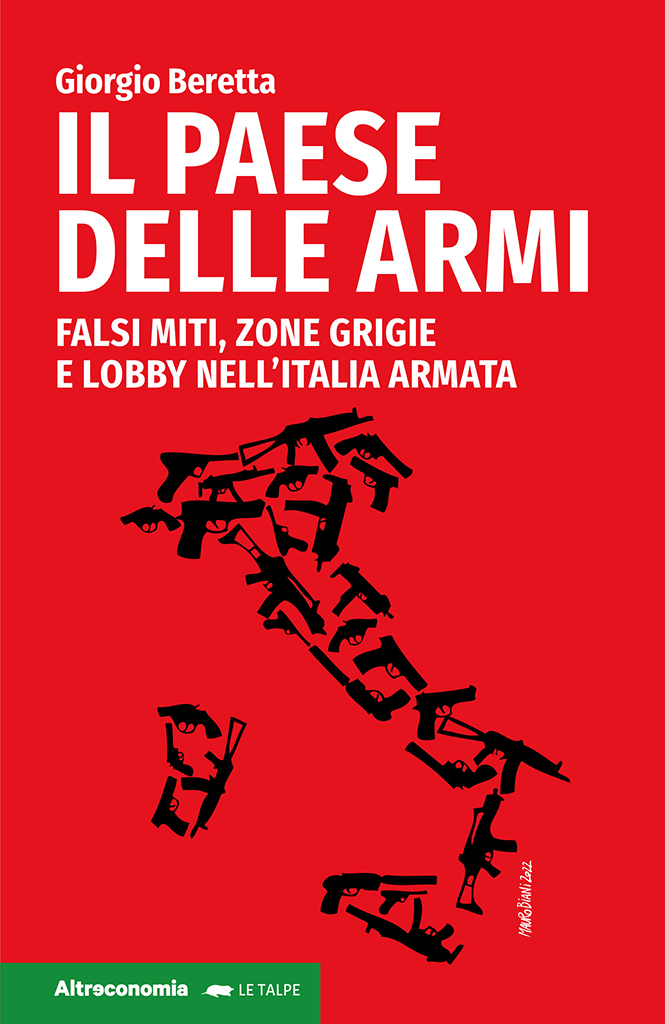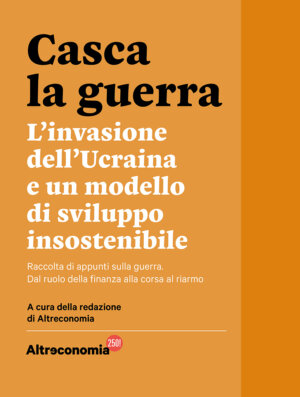Economia / Attualità
Il Progetto MedOr rinsalda il legame tra Italia e Israele. Dalle armi al gas

A dicembre 2024 il governo ha annunciato un nuovo programma con lo scopo di aiutare le società partecipate dallo Stato a stringere accordi in Medio Oriente e in particolare con Tel Aviv. Leonardo e Snam giocano un ruolo da protagoniste
Il genocidio a Gaza ha portato alla luce i legami a volte profondi di aziende e università italiane con Israele e con l’industria della guerra che alimenta il conflitto. Legami e interessi a dir poco importanti quelli delle partecipate pubbliche italiane, che nelle ultime settimane hanno trovato una forma rinnovata all’interno del “nuovo Progetto MedOr”, promosso dal Governo Meloni.
MedOr nasce come fondazione di Leonardo Spa, leader mondiale nell’aerospazio, difesa e sicurezza, che Palazzo Chigi ha deciso di trasformare in “Fondazione per l’Italia” con l’obiettivo di “fare squadra nell’interesse della Nazione”.
Con l’insediamento del Comitato strategico del “nuovo Progetto MedOr”, avvenuto lo scorso dicembre, la fondazione “rafforza la propria missione” coinvolgendo anche altre società partecipate dallo Stato italiano nella promozione di partnership pubblico-privato nella regione del Mediterraneo, nel Medio Oriente e nell’Africa subsahariana tra cui Cdp, Enel, Eni, Fs, Fincantieri, Poste Italiane, Terna e ovviamente Snam.
La relazione strategica tra Snam e alcune tra le principali aziende energetiche israeliane inizia nell’ottobre 2020, quando la società italiana firma i primi accordi quadro sul gas e l’idrogeno nella regione: tre “Memorandum of understanding” siglati nell’ambito di una visita di Stato dell’allora ministro degli Esteri Luigi Di Maio a Tel Aviv. A questi fece seguito la vera e propria entrata di Snam nel mercato del gas regionale, con l’acquisto -nel dicembre 2021- del 25% della East mediterranean gas company (Emg), la società proprietaria del gasdotto Arish-Ashkelon che collega Israele con l’Egitto.
Si tratta di un’opera di 90 chilometri costruita originariamente per esportare gas dal Cairo verso Tel Aviv. Ma da quando, nel 2020, il governo di Israele ha iniziato a vendere il gas estratto nei giacimenti offshore di Tamar e Leviathan, i ruoli si sono invertiti e ora è Israele a usare il gasdotto per esportare il gas che estrae verso l’Europa e il mondo arabo, passando attraverso l’Egitto. Nel frattempo Snam e le altre corporation proprietarie del gasdotto intascano i profitti e permettono anche a Israele di incassare laute royalties che vengono reinvestite sotto i nostri occhi per alimentare l’industria della guerra.
La relazione strategica tra Snam e Israele inizia nel 2020 quando l’azienda italiana firma i primi accordi con Tel Aviv per progetti sul gas e sull’idrogeno
Anche la relazione tra Snam e Leonardo precede quella definita dal Progetto MedOr e si rafforza con un “Memorandum of understanding” che le due compagnie hanno firmato nel 2021. In questo caso, lo sviluppo dell’economia dell’idrogeno e delle rispettive competenze tecnologiche a supporto dell’innovazione e della sostenibilità dell’industria energetica sono fumo negli occhi per una collaborazione che riguarda la sicurezza delle reti e delle infrastrutture, che nel caso di Snam sono ancora radicate profondamente nell’economia fossile, mentre nel caso di Leonardo in quella della guerra.
La costruzione del gasdotto Tap ha rafforzato la relazione economica tra Italia e Azerbaigian, favorendo anche gli affari di Leonardo che a giugno 2023 ha siglato un contratto per la fornitura dell’aereo C-27J Spartan nell’ambito di una visita di una delegazione azera in Italia. “La nostra cooperazione nel settore del petrolio e del gas è importante non solo per i nostri Paesi, ma anche per l’intero spazio europeo”, ha detto il presidente azero Ilham Aliyev in occasione della firma del contratto.
La costruzione dal gasdotto Tap, che collega Italia e Azerbaigian, ha segnato in modo profondo il territorio salentino e minato il rapporto tra territorio e istituzioni
Oltre alle entrate per le casse dello Stato derivanti dagli accordi di Leonardo e Snam, la “licenza sociale” di queste aziende dipende molto dall’immagine che riescono a dare di sé e da come vengono accettate nei territori in cui operano.
Nel caso del gasdotto Tap, la forte resistenza popolare contro l’eradicazione degli ulivi in Salento e contro la costruzione della mega-infrastruttura per il trasporto del gas azero (e non solo) in Italia, ha lasciato sul territorio salentino uno strascico profondo che ha intaccato le relazioni sociali e segnato profondamente quelle tra territorio e istituzioni.

Per ricostruire la propria “licenza sociale”, oltre alle sponsorizzazioni a eventi culturali, le donazioni alle associazioni, e l’intensa attività di comunicazione sociale da parte della società Tap sul territorio pugliese, Snam -che è azionista al 20% del progetto, e che vede alcuni dei suoi manager tra gli imputati del processo per disastro ambientale in corso presso il Tribunale di Lecce- ha giocato la carta dei progetti di forestazione urbana promossi da Arbolia, la società benefit nata in collaborazione con Cassa depositi e prestiti e da qualche anno controllata interamente proprio da Snam.
Uno di questi progetti è un boschetto privato, realizzato in un’area industriale all’interno dell’impianto di Leonardo a Foggia. Si tratta prima di tutto di un’iniziativa dal valore sociale limitato: realizzato nello stabilimento (per altro al centro di vertenze mosse dai lavoratori, dentro e fuori dalla cassa integrazione negli ultimi anni, nonostante le importanti commesse per gli impianti pugliesi della multinazionale) e in una zona industriale, il boschetto non è fruibile dagli abitanti di Foggia e della zona.
In un anno un aereo militare emette 642mila tonnellate di CO2 equivalente
Nel suo comunicato Leonardo ne parla come di “un progetto di riforestazione che si inserisce nelle iniziative del Piano di Sostenibilità dell’azienda. Con l’intervento di messa a dimora di oltre 1.650 piante, si stima che in venti anni sarà assorbito un totale di CO2 pari a 367 tonnellate, l’abbattimento di PM10 fino a 16,6 tonnellate e un rilascio di ossigeno fino a 268 tonnellate”. Si tratta di promesse, appunto, ma il clamore dell’annuncio, ripreso dai quotidiani locali, punta a far dimenticare che serviranno vent’anni per verificare lo stato del progetto, il suo valore ecologico e l’effettivo assorbimento di CO2.
Nel frattempo, possiamo tenere bene a mente che quello militare è tra i settori che più contribuisce ai cambiamenti climatici su scala globale. Secondo il report “Decarbonize The Military” ripreso dalla rivista Nature, il comparto genera tra l’1% e il 5% delle emissioni di gas serra totali nel mondo. Tornando quindi all’impianto di Leonardo a Foggia, è difficile calcolare quale sia l’impatto climatico dello stabilimento e della sua filiera. Il sito produttivo impiega circa mille dipendenti, e viene definito “centro di eccellenza dedicato alla produzione di aerostrutture in materiale composito per velivoli militari e civili: dall’Eurofighter Typhoon all’F-35, dal Boeing 787 Dreamliner all’Atr”.
Leonardo e Snam sono parte di quel “sistema Italia” che insegue i profitti a qualunque costo, dove interessi fossili e militari si muovono lungo le stesse maglie
Secondo i dati disponibili, un aereo militare in un’ora di volo consuma mediamente 10-12mila litri di combustibile generando in un anno 642mila tonnellate di anidride carbonica equivalente. Un valore paragonabile alle emissioni di un processo quale la produzione di vetro in Italia nello stesso anno e di migliaia di volte superiore alle 367 tonnellate di CO2 che il progetto di Arbolia-Leonardo promette di catturare in venti anni.
Leonardo e Snam sono entrambe parte di quel “sistema Italia” che insegue profitti a qualunque costo, dove interessi energetici e militari si muovono lungo le stesse maglie. Il nuovo progetto MedOr definisce una cornice ancora più sistemica per le operazioni delle partecipate pubbliche in una regione al centro di conflitti e cambiamenti epocali. Non basteranno i boschetti di Arbolia a farcelo dimenticare.
Lo spazio “Fossil free” è curato dalla Ong ReCommon. Un appuntamento ulteriore -oltre alle news su altreconomia.it- per approfondire i temi della mancata transizione ecologica e degli interessi in gioco
© riproduzione riservata