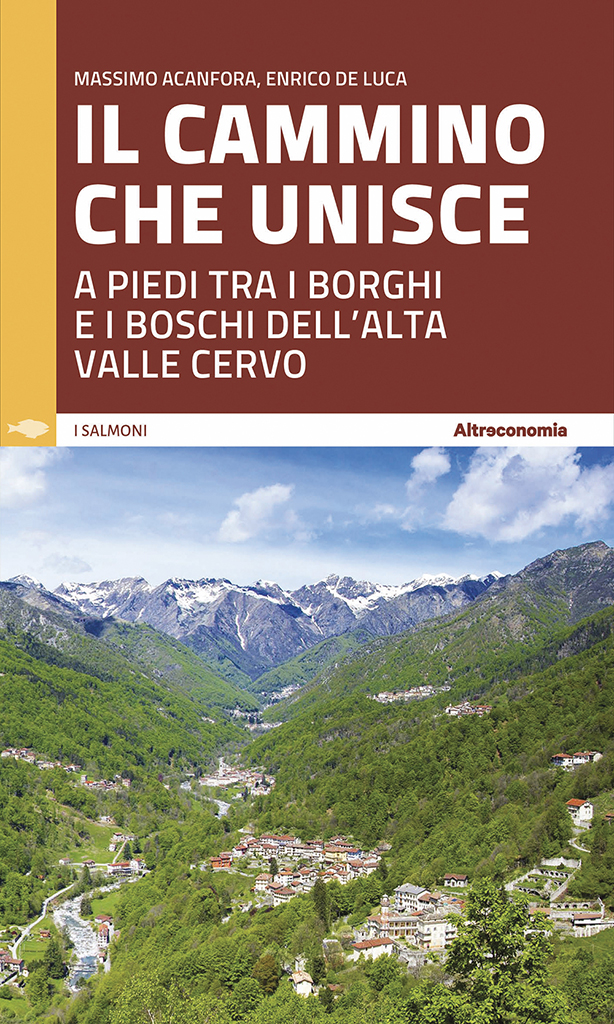Cultura e scienza / Approfondimento
I racconti e le qualità del documentario italiano

Non solo “Fuocoammare”, vincitore dell’Orso d’oro nel 2016: nonostante i pochi incassi in sala e finanziamenti limitati, il genere si fa spazio tra festival e pubblico. La chiave sta nella flessibilità di autori e produttori
Fuocoammare a Sanremo. Il documentario di Gianfranco Rosi sull’incontro fra migranti e lampedusani, coprodotto da Rai Cinema, è stato benedetto da trenta secondi di promozione all’ultimo Festival della canzone. Il film è poi rientrato dal Festival di Berlino con l’Orso d’oro. Sui giornali sono apparse le foto di Matteo Renzi che ne regala i dvd ad Angela Merkel e agli altri leader europei; papa Francesco ha voluto proiettarne degli spezzoni al Giubileo dei giovani; il presidente Mattarella ha ricevuto regista e protagonisti. “Eppure -commenta Dario Zonta, produttore creativo del documentario- il film nei cinema l’avranno visto forse 150mila persone. Considerata l’enorme visibilità che ha avuto, c’è da riflettere su cosa sia oggi il documentario nel nostro Paese”.
Nel 2001, secondo i dati Cinetel, i documentari proiettati nei cinema italiani erano stati 5: una ventina nel 2012, e 78 nel 2014. Nel 2013, era già affiorato Rosi, vincendo il Leone d’oro a Venezia con Sacro Gra, docufilm che racconta l’umanità nei dintorni del Grande raccordo anulare romano. “Sono quindici anni che il documentario propone molte delle novità più forti per ricerca formale e costruzione della narrazione”, racconta il critico Luca Mosso. “E il pubblico, sia quello più accorto che quello generalista, lo sta notando”.Grazie anche alla vittoria a Venezia, Sacro Gra “è stato il documentario italiano di maggiore successo al cinema, coi suoi 200mila spettatori” ricorda Zonta. “È stato poi trasmesso da Rai 1 in seconda serata, dove ha raggiunto 650mila spettatori, con punte di un milione. Infine, le vendite dei dvd. Ma in Italia l’ultimo film di Checco Zalone ha portato quasi dieci milioni di persone in sala. Dobbiamo ancora fare i conti con una diffusa incultura sul documentario”. Per Mosso, “il pubblico c’entra poco. Sono gli intermediari, tv e case di distribuzione, che attuano spesso strategie conservatrici, incuranti della qualità di molti lavori”.
Il ritratto degli emarginati della Louisiana di Roberto Minervini; il poema sulle reincarnazioni di un’anima di Michelangelo Frammartino; le parabole sull’Italia moderna di Pietro Marcello; la versione di un cantoniere siciliano sul Novecento raccontata da Costanza Quatriglio: sono vari i docufilm sperimentali italiani accolti con interesse nei festival e nei circuiti cinematografici stranieri. Al di là di Rosi “c’è un insieme di autori riconosciuti e capaci di osare”, afferma Ottavia Fragnito, produttrice e cofondatrice di Falest Film. “Poi ci sono i giovani ai primi film, talvolta registi con un talento notevole, anche se poco consapevoli delle dinamiche produttive”. Il sito CinemaItaliano.info registra circa 800 produzioni documentaristiche l’anno nel nostro Paese: grandi e piccole, lunghi e corti. “Gran parte di questi si autoproducono recuperando un po’ di soldi in famiglia, o investendo il proprio tempo”, spiega Stefano Tealdi, produttore di documentari e cofondatore di Stefilm. “I lavori migliori arrivano ai festival e vincono anche qualche premio, ma restano ai margini del sistema. Del resto il costo medio di un documentario di taglio cinematografico è sui 100mila euro, ma può anche salire a 400mila e oltre per lavori complessi”.
“Un documentario non parte da un tema, ma dalle persone”, dice Andrea Segre, regista di numerosi lavori a sfondo sociale. “Per riconoscere chi è capace di trasferire un’emozione narrativa e costruirci una relazione occorrono mesi. È la premessa di tanto cinema documentario, e parte di questo lavoro esplorativo va a vuoto”. Si incontra già in fase di scrittura dei documentari il primo imbuto produttivo: in Italia esistono pochissimi fondi di sostegno allo sviluppo. “Anche per questo con i miei quattro soci abbiamo fondato ZaLab”, riprende Segre. “È l’associazione attraverso la quale produciamo i nostri lavori: quello che incassa lo redistribuisce in progetti. Per esempio, abbiamo coperto così l’inizio del lavoro a Rosarno per ‘Il sangue verde’”, ritratto degli immigrati che lavorano come stagionali nel paese calabrese e della loro rivolta nel 2010. “Anche oggi siamo fermi su un nuovo progetto, perché le persone con cui ci stiamo confrontando per il film hanno subito un lutto. Attese e incertezza sono inevitabili. Farebbe una grande differenza se la Rai, o altri, allocassero un fondo a perdere, anche piccolo, per consentire ai documentaristi di sviluppare i loro progetti”.
Anche i produttori tradizionali vivono lo stesso problema. Molti sono concentrati a Torino, capitale italiana del documentario, dove c’è anche una film commission fra le più attive. Questi enti pubblici locali di sostegno all’audiovisivo “sono fra i primi soggetti ai quali ci rivolgiamo in fase di sviluppo”, racconta Simone Catania di Indyca Film e referente dell’associazione Doc/It. “Ma poi si deve ricorrere ai bandi europei per lo sviluppo, soprattutto lo storico fondo Media.
“Sono gli intermediari, tv e case di distribuzione, che attuano spesso strategie conservatrici, incuranti della qualità di molti lavori” (Luca Mosso, critico)
Chi spicca fra centinaia di concorrenti ottiene 25mila euro, e ha così il tempo di sviluppare storie e strategia per il progetto”. Nel momento in cui un documentario è scritto e si passa alle riprese, la partita decisiva diventano le coproduzioni con l’estero e, se possibile, con le televisioni europee. “Significa accedere ai fondi di altri Paesi, dove il mercato è molto più evoluto”, spiega Tealdi. “Anche le televisioni straniere, se decidono di investire sul tuo progetto, mettono da due a quattro volte le cifre che normalmente si ottengono in Italia col preacquisto del film”.
Per la parte italiana il tipico piano di finanziamento include i fondi del ministero per i film di interesse culturale, contributi da fondazioni o associazioni, o forme di finanziamento da privati basate sul tax credit. “Ma i margini sono scarsi, la concorrenza ampia e il cash flow problematico, con i soldi che entrano mesi o anche anni dopo la vittoria di un bando o la promessa di un contributo”, dice Fragnito. Così per molti documentari i tempi di lavorazione si allungano, rischiando di compromettere il racconto degli eventi nel loro svolgersi spontaneo.
Massimo D’Anolfi e Martina Parenti hanno cominciato a realizzare documentari insieme dieci anni fa, quando già erano una coppia nella vita. I loro lavori, rigorose esplorazioni in campo sociale e filosofico, sono passati da Berlino, Locarno e altri grandi festival. “Il castello”, un’indagine realista quanto visionaria sull’aeroporto di Malpensa nel clima di paura post-11 settembre, ha vinto il premio della giuria a Toronto. Come sempre la lavorazione l’hanno svolta in due: Massimo alla camera, Martina al suono ed entrambi al montaggio, senza quasi collaboratori esterni. Seguono una strada di completa autonomia, da registi–produttori. Con la piccola società fondata per realizzare i propri film vanno a caccia di fondi di ogni genere. “Per il nostro primo documentario ci ha sostenuti anche un pastificio”, sorridono. Negli anni il mix di finanziamento dei loro lavori ha più o meno ricalcato quello tradizionale, dalla tv alle coproduzioni con l’estero, dai fondi Media alle associazioni. Ma all’inizio creatività e fortuna sono state decisive: “La Lines, l’azienda produttrice di assorbenti, ci ha finanziato i primi tre lavori. Probabilmente realizziamo i nostri film con un quarto dei soldi che costerebbero se ci rivolgessimo al mercato, ma così restiamo liberi. E il gioco regge perchè siamo una troupe leggera, i mezzi tecnici sono nostri e il tempo pure. Se così non fosse, difficilmente potremmo accostarci a progetti vasti come quello di ‘Spira Mirabilis’, docufilm in quattro atti sugli elementi della natura al quale stiamo lavorando, e che ci ha portato a viaggiare fra Giappone, Svizzera e Stati Uniti”.
Rosi, Segre, D’Anolfi e Parenti e altri hanno anche trovato presso la tv pubblica un interlocutore attento inPaola Malanga, oggi vicedirettore Rai Cinema, che nel 2012 ha voluto una struttura dedicata ai documentari per erogare fondi alla produzione: “Era tempo che si desse un’attenzione diversa al documentario. Abbiamo un arcipelago di autori capaci di porre sfide di linguaggio di cui la fiction non è più capace da tempo, e vanno sostenuti”. I registi ai primi film, invece, spesso si rivolgono alle case di produzione strutturate. Spiega Catania di Doc/It: “Li sosteniamo nel processo di realizzazione dei film secondo modalità professionali. Li portiamo ai mercati internazionali, dove parliamo con i commissioning editor delle tv straniere, o con potenziali coproduttori, e seguiamo altre modalità di ricerca fondi, come il crowdfunding. Il produttore poi prende fra il 10 e il 20% del finanziamento ottenuto, ma è il primo a non venire pagato se non si raggiungono le soglie previste”. “Si lavora sempre per la pagnotta -conclude Zonta-, ma è un sistema che non genera profitti veri, coi quali reinvestire su un’opera successiva”.
Claudia Tosi, documentarista al suo secondo lungo, da mesi si interroga su come raggiungere il pubblico. Fa da sè, perchè “The Perfect Circle”, la storia degli ultimi giorni di vita di due persone in un hospice emiliano, non ha trovato un distributore. Una produzione di taglio cinematografico durata cinque anni, fra decantazione personale e ristagni produttivi. Risultato, un film duro e dolce sulla vita e la cura ai bordi della morte: “sulla carta è il film che nessuno vuole vedere, anche se poi in tanti vogliono riguardarlo. Ma i distributori non capivano come maneggiarlo”. Così Tosi ha scoperto la formula delle proiezioni on demand: attraverso piattaforme online si realizza l’incontro fra le sale disponibili e i potenziali spettatori del film, che preacquistano il biglietto per una data sera: se si raggiunge un certo numero di presenze, la proiezione è confermata. Per questa via si sono già organizzate una decina di serate in tutta Italia, anche in Parlamento.
“Forse il 5% dei documentari realizzati ogni anno trova un distributore vero”, dice Fabrizio Grosoli, consulente di I Wonder, una delle tre realtà distributive dedicate al documentario in Italia. “Per noi i margini di manovra sono molto ristretti. Televisioni e grandi piattaforme online, come Netflix o Amazon, si contendono i diritti per i film a monte nella filiera: la distribuzione di documentari in Italia è un non-mercato, vista anche la cautela dei distributori tradizionali. Il risultato è che un gran numero di lavori restano al di sotto del loro bacino potenziale di pubblico”. E se i documentari di taglio cinematografico arrivano di rado in sala, ancora meno si vedono in televisione. “Eppure -dice Tealdi- tv come la Rai avrebbero tutti i mezzi per investire, formare un pubblico e creare in qualche anno un mercato che darebbe ottimi ritorni”. Concorda Paola Malanga, che ha promosso la diffusione in prima serata sui Rai 5 di docufilm di qualità: “Oltre ai meriti artistici, questo è anche un prodotto dall’ottimo rapporto qualità-prezzo”. “In questo contesto resta strategica la vetrina dei festival”, spiega Mosso. “È il veicolo migliore per certificare la qualità di un film e attivare il passaparola che lo farà conoscere, visto che distributori e produttori non hanno soldi per fare pubblicità”. Mentre distribuisce “The Perfect Circle”, Tosi lavora al prossimo documentario. Da otto anni segue due donne entrate in Parlamento. “Sarà un film sulle emozioni e le pene del fare politica”. Titolo provvisorio: “I Had a Dream”. Non importano i tempi lunghi e la fatica, “alla fine lo fai perché ti piace, e perché vorresti persino fare una qualche differenza sul piano sociale. Comunque sì, sono lentissima”, scherza. “Ma forse lo chiudo l’anno prossimo. Forse”.
© riproduzione riservata