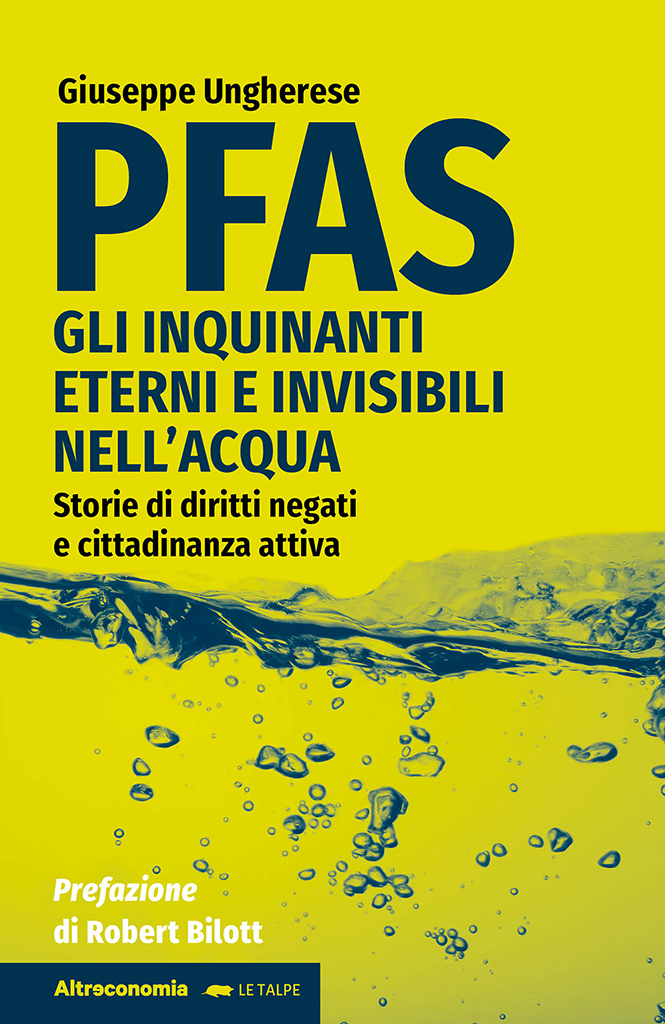Ambiente / Reportage
Le valli da pesca del Delta del Po: prove di allevamento sostenibile

Fin dal XVI secolo l’ecosistema lagunare dell’Alto Adriatico ha permesso di moltiplicare i pesci in un habitat naturale e secondo un modello estensivo. Che oggi subisce la concorrenza dell’acquacoltura intensiva. In Europa il consumo ittico è pari a 23 chili a testa e questo mette a rischio gli stock
La piccola barca di legno scivola veloce sullo specchio d’acqua calma della valle, attraversando canali bordati da argentee tamerici e fitte cannucce palustri. L’azzurro del cielo, rischiarato dalla luce dell’alba, diventa blu nell’acqua salmastra, tutt’intorno. Folaghe, aironi, cormorani, gabbiani, sterne, con le loro voci dissonanti, riempiono l’aria di un chiacchiericcio quasi assordante nel cielo sopra Valle Bertuzzi, una valle da pesca privata di circa 1.300 ettari nel Delta del Po ferrarese.
“Il concetto di conservazione dell’ambiente è così spinto che entrare in una valle da pesca è simile all’ingresso in un’oasi naturalistica, piuttosto che in un qualunque allevamento animale. Le valli da pesca sono definite zone di eccezionale valenza naturalistica e di elevata biodiversità. Uno dei modi per mantenerle vive è quello di mantenerle produttive, in alternativa, l’abbandono della gestione idrologica di queste aree umide porterebbe al loro progressivo interramento” così spiega il dottor Renato Palazzi dell’Azienda Regionale “Veneto Agricoltura”, dove si occupa di sperimentazione a supporto del settore della vallicoltura.
“I vallicoltori governano e mantengono vivo un ambiente acquatico complesso, tutelandone in tal modo la biodiversità, perché così indirettamente favoriscono la crescita del pesce” (Renato Palazzi)
Secondo FAO, l’acquacoltura è il settore agroalimentare in più rapido sviluppo, con un tasso medio di crescita di circa il 9% annuo su scala mondiale. Globalmente, il trend di consumo di risorse ittiche ha visto un generale aumento dagli anni Settanta del secolo scorso fino al livello record di 136 milioni di tonnellate nel 2012. La produzione di prodotti ittici da pescato è cresciuta fino al 1996 con 86 milioni di tonnellate, ma da allora è rimasta costante intorno a circa 80 milioni di tonnellate all’anno, mentre l’acquacoltura sta letteralmente “galoppando”. Perché?
Sasa Raicevich, ricercatore presso la sede di Chioggia (Ve) dell’ISPRA, l’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, spiega che nel Mediterraneo, ad esempio, in base a studi scientifici fatti negli ultimi vent’anni, risulta che circa il 90% degli stock delle specie ittiche pescate sia sovrasfruttato: “Il pesce viene pescato a un ritmo più rapido di quelli che sono i tempi necessari per rinnovarsi, e la popolazione è destinata a ridursi”. Le linee guida per una sana alimentazione, intanto, raccomandano di mangiare più pesce: per conciliare la salvaguardia degli ecosistemi marini con le esigenze alimentari umane di una popolazione globale in continuo aumento, l’acquacoltura sembra l’unica risposta. Che non sempre è sostenibile.
In termini di valore, l’Unione europea è il principale mercato mondiale di prodotti ittici e l’acquacoltura rappresenta ormai il 20% della produzione impiegando quasi 80mila persone. L’acquacoltura produce il 44% di molluschi e crostacei e il 56% di pesce (marini e d’acqua dolce) europei. In Italia, nel 2014, l’acquacoltura ha dato lavoro a circa 5mila persone e, secondo FAO, ha generato un valore economico di circa 466 milioni di euro. Assieme a Spagna, Francia, Gran Bretagna e Grecia, l’Italia è uno dei primi cinque Paesi per l’acquacoltura in Europa.

Tre sono le tipologie di acquacoltura, che si distinguono in base alla metodologia di allevamento: intensiva, semi-intensiva ed estensiva. Nei sistemi di produzione intensivi (in vasca di cemento o in gabbia in mare), le specie ittiche sono allevate in un ambiente controllato dove vi è un costante apporto di energia dall’esterno (aerazione forzata, ricambi d’acqua, introduzione di mangimi a base di farine di origine animale, cioè specie ittiche meno pregiate, e se necessario disinfettanti e farmaci) e una produzione di rifiuti che devono essere smaltiti (acque di scarico ricche di nutrienti): gli impianti di acquacoltura intensiva hanno un forte impatto sugli ecosistemi.
In Italia esiste però una forma storica di allevamento ittico estensivo, unico: la vallicoltura, appunto. Secondo il dottor Palazzi, può essere pensata come la “gestione di un ambiente ai fini produttivi piuttosto che come un allevamento diretto del pesce. I vallicoltori governano e mantengono vivo un ambiente acquatico complesso, tutelandone in tal modo la biodiversità, perché così indirettamente favoriscono la crescita del pesce”. Nelle valli da pesca la densità di pesce allevato rispetto alla superficie a disposizione è bassa (si parla di 130-150 chili di pesce per ettaro, mentre nell’intensivo il range va da 10 a 30 chili pesce per metro cubo) e manca qualsiasi apporto dall’esterno. La maggior parte delle valli da pesca italiane si trova in acque salmastre, nel tratto costiero tra Monfalcone e Ravenna, dov’è presente il più esteso, omogeneo e complesso sistema di zone umide d’Italia e dell’Europa mediterranea, per un’estensione totale di 150mila ettari.

“C’è una ragione idrologica ben precisa del perchè questo tipo di gestione dell’ambiente lagunare si è sviluppato storicamente proprio nella zona dell’Alto Adriatico: qui, per la conformazione a ‘cul de sac’, si trovano infatti i più alti e i più bassi valori di marea di tutto il Mar Mediterraneo. Questo significa che vi è un enorme scambio di acqua tra il mare e le lagune costiere” spiega Tiziano Scovacricchi, esperto dell’ISMAR di Venezia (Istituto di Scienze Marine del CNR). In questi ecosistemi lagunari, perciò, affluivano stagionalmente dal mare, in primavera, enormi quantità di avannotti tra cui specie marine pregiate come orata, branzino, cefali ed anguilla, chiamati collettivamente “novellame”. L’origine della vallicoltura perciò si può ricondurre alla funzione di “nursery” delle lagune costiere: fin da epoche remote, l’uomo ha sfruttato questo naturale ciclo di migrazione degli avannotti (“montata”) per mantenere il pesce ad ingrassarsi in porzioni di laguna chiuse, le “valli”, fino al tempo della raccolta (“fraìma”) che coincideva con il richiamo dei pesci adulti a riprodursi in mare, di solito nei mesi autunnali-invernali. Queste tecniche vennero affinate dai Veneziani che, già dal Sedicesimo secolo, cominciarono a separare parti di Laguna mediante staccionate. Con il tempo questi spazi chiusi diventarono idraulicamente sempre più complessi, dotati di argini di terra, canali principali e secondari, vasche di raccolta (“peschiere”) e chiuse per regolamentare l’ingresso delle acque.
Nel 2014 -secondo dati FAO- per ogni orata prodotta in Italia (da pescato o allevamento) ve ne erano sei e mezzo di provenienza estera, probabilmente allevate in Grecia o Turchia
La vallicoltura è stata pertanto la prima forma di allevamento del pesce su scala nazionale ed ha sostenuto la domanda di pesce allevato per gran parte del secolo scorso. Secondo i dati FAO, nel 1985, su 10 orate prodotte in Italia, una era stata allevata in valle e 9 erano state pescate in mare. Verso la fine degli anni Ottanta, a causa del progressivo impoverimento degli stock ittici in mare, vennero messe a punto tecniche per la riproduzione artificiale intensiva del pesce. La vallicoltura italiana, con le sue poche centinaia di tonnellate di prodotto ittico stagionale, non riusciva più a soddisfare la crescente domanda di pesce, che oggi si attesta a 26 chili pro capite all’anno in Italia (e 23 in Europa). Negli anni Novanta, pertanto, iniziarono massicciamente produzioni intensive, tant’è che oggi il rapporto si è completamente invertito: su 10 orate prodotte in Italia, una viene dal pescato e 9 da allevamenti.
C’è una differenza tra pesce allevato in intensivo e in valle. Alcune ricerche, spiega Palazzi di Veneto Agricoltura, “attestano che la qualità delle carni di quest’ultimi è prossima a quella del pesce pescato in mare, mentre per il pesce da allevamento intensivo essa risulta proporzionale alla qualità del mangime somministrato”.
Questa differenza sul banco del mercato non è sempre ben visibile, e il consumatore tende a privilegiare l’acquisto di pesce a basso prezzo. Che spesso viene prodotto fuori dal nostro Paese. Il boom dell’acquacoltura intensiva ha interessato soprattutto alcuni Paesi del Sud del Mediterraneo come Grecia, Turchia, Tunisia, Spagna e Croazia: climi più favorevoli e cicli produttivi più rapidi (ad esempio un’orata in valle impiega circa 20-22 mesi per arrivare alla taglia commerciale, mentre in mare in gabbia intensiva ne impiega tra i 12 e i 14) hanno portato sul mercato italiano pesce a prezzi più bassi e per tutto l’anno. Ad esempio, secondo i dati FAO, nel 2014 l’importazione di orate fresche o congelate in Italia è stata di 25.475 tonnellate, il che vuole dire che per ogni orata prodotta in Italia (da pescato o allevamento), acquistabile sul banco del mercato, ve ne erano sei e mezzo di provenienza estera, probabilmente allevate in Grecia o Turchia. La situazione è ancora più “estrema” se guardiamo al mercato di gamberi: l’Europa è letteralmente “impazzita” per questi crostacei tanto che, secondo FAO nel 2013, ne abbiamo importate 875.000 tonnellate contro le 120mila pescate e le 146 prodotte con acquacoltura. L’allevamento di gamberi in Europa è limitato a poche realtà in Francia, Spagna e Italia dove, circa vent’anni fa, la specie Penaeus Japonicus venne introdotta in alcune valli da pesca del Nord Adriatico. La gambericoltura italiana sembrava un valido aiuto economico e un ideale complemento naturale alla vallicoltura del pesce, grazie alla presenza di ampi bacini di allevamento, elevate produttività primarie e la stagionalità estiva della raccolta. La freschezza era sicuramente uno degli aspetti più qualificanti del gambero prodotto in valle rispetto a quello d’importazione, dal momento che quest’ultimo arriva sul banco del mercato sicuramente morto, congelato o surgelato, spesso con l’aggiunta di conservanti come i solfiti (che possono dare reazioni allergiche in soggetti sensibili). Ma ancora una volta, il depauperamento degli stock di gamberi selvatici, la crescente domanda europea di questo prodotto ittico e l’altrettanto elevata offerta di gamberi tropicali a basso prezzo sono alcuni tra i fattori che hanno determinato il quasi completo abbandono di questo allevamento nelle valli da pesca italiane, e contribuito al generale declino di questo sistema produttivo sostenibile ed efficace per la conservazione dell’ambiente lagunare costiero. Per contro, i principali Paesi tropicali produttori di gamberi (Ecuador, Indonesia, Vietnam, Tailandia, India), che importano in Europa, praticano una gambericoltura intensiva responsabile della distruzione di ambienti ad elevata biodiversità, le foreste di mangrovie costiere, per fare spazio ai bacini di acquacoltura.
Reportage realizzato grazie al contributo del programma Journalism Grants finanziato dall’European Journalism Centre
© riproduzione riservata