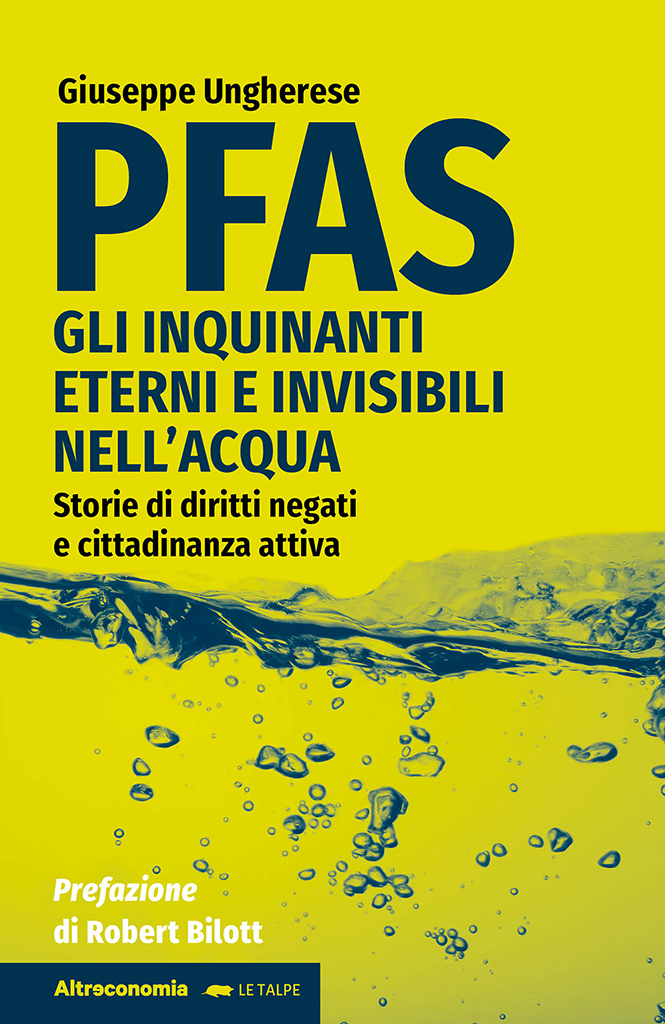Ambiente
La posta in gioco a Copenhagen
A dicembre riflettori puntati sul vertice sui cambiamenti climatici. Dai governi sono attesi impegni precisi: il fallimento del summit sarebbe catastrofico Un governo subacqueo. Mohamed Nasheed, presidente delle Maldive, a metà ottobre ha riunito il suo esecutivo sott’acqua. A due…
A dicembre riflettori puntati sul vertice sui cambiamenti climatici. Dai governi sono attesi impegni precisi: il fallimento del summit sarebbe catastrofico
Un governo subacqueo. Mohamed Nasheed, presidente delle Maldive, a metà ottobre ha riunito il suo esecutivo sott’acqua. A due mesi dalla Conferenza Onu sul clima di Copenhagen (Cop15, in programma dal 7 al 18 dicembre), ha denunciato così il rischio che incombe sullo staterello dell’Oceano indiano: l’aumento della temperatura provocherà l’innalzamento del livello dei mari, e i bellissimi atolli maldiviani (nella foto sopra) finiranno sommersi.
“Serve una soluzione concreta” spiegano i maldiviani, ed è a Copenhagen che i Paesi Onu dovranno trovarla, scontando i limiti delle misure adottate a Kyoto (gli strumenti per combattere il riscaldamento globale si sono spesso trasformati in pratiche speculative, vedi Ae 102) e il tempo che è andato perduto. È vero che nel 2009 le emissioni globali di CO2 saranno calate del 3%, per la prima volta dagli anni Novanta, secondo le stime dell’International Energy Agency (Iea), ma il risultato è dovuto alla crisi economica globale. Un’eventuale ripresa dell’economia nel corso del 2010 ci riporterà punto e accapo. Cioè in un vicolo cieco, a meno che da Copenhagen non esca un’agenda di interventi condivisi. Al tavolo negoziale, però, in molti siederanno scontenti. Ad esempio i G77, un’organizzazione intergovernativa delle Nazioni Unite, formata da 131 Paesi, principalmente in via di sviluppo, che a Bangkok -dove da fine settembre a inizio ottobre si è tenuto un incontro preparatorio a Cop15- hanno chiesto di non concentrarsi esclusivamente sulle misure di mercato, come lo scambio dei “crediti di emissione” generati nell’ambito del Clean Development Mechanism (Cdm, vedi box a pagina 31).
“No more business as usual, no more false solutions!” (“No al solito business, no a soluzioni false!”) è anche l’appello delle reti di organizzazioni che a Copenhagen hanno convocato il parallelo People’s Summit for Climate Justice, e che il 16 dicembre tenteranno di “entrare” nelle stanza dei bottoni per spiegare la propria “ricetta” contro il riscaldamento globale. Fatta di pochi passi concreti: lasciare i combustibili fossili sottoterra, lasciare alle persone il controllo sulle risorse, rilocalizzare la produzione di cibo, ridurre lo spreco, riconoscere il debito ecologico e climatico nei confronti del Sud del mondo, rispettare i diritti degli indigeni e dei popoli della foresta. Sono gli unici che sembrano prendere sul serio gli appelli della comunità scientifica internazionale. “Per cambiare prospettiva, servirà un altro grande disastro ambientale legato ai cambiamenti climatici -spiega Stefano Caserini, ingegnere ambientale che insegna Fenomeni di inquinamento al Politecnico di Milano e cura il sito www.climalteranti.it-. Negli Usa, ad esempio, qualcosa è cambiato dopo l’uragano Katrina del 2005. Ma se aspettiamo a ridurre le emissioni di CO2, ci sarà più anidride carbonica in atmosfera”. La partita si fa sempre più difficile: per i climatologi il problema non è la produzione di CO2, ma la sua concentrazione, “perché è da quella che dipendono gli effetti del riscaldamento globale”, spiega Guido Visconti dell’Università dell’Aquila, che qualche anno ha descritto “il tempo che ci aspetta” nel libro Clima estremo (Boroli, 2005). “Se riduco la produzione, cala anche la concentrazione. Ma se la riduco del 20%, ottengo solo un rallentamento nell’aumento della concentrazione. Per mantenerla costante, dovrei ridurre la produzione di CO2 del 70%. Per questo non mi aspetto niente da Copenhagen”.
I modelli scientifici ipotizzano un aumento dai 3 ai 5° delle temperature a livello globale. E se la comunità internazionale scegliesse davvero di mettere in campo una strategia contro i “cambiamenti climatici”, il risultato sarebbe “contenere il danno” in 2 gradi centigradi. “Il problema maggiore è l’impossibilità per gli esseri viventi di adattarsi al cambiamento -riprende Visconti-. La maggior parte delle specie animali e vegetali potrebbero sparire. Se lo immaginate distribuito in altitudine, il processo è drammatico -conclude-. L’aumento di temperatura sposta la vegetazione: quella che cresceva sopra i mille metri, si sposta ad una quota dove non può più crescere”.
Stoccaggio, inutile e costoso
A Copenhagen si gioca la partita per “sdoganare” la tecnologia del Carbon Capture and Storage (Ccs), cioè la cattura e lo stoccaggio sottoterra della CO2 emessa da centrali termoelettriche ed attività industriali. Alcune lobby -l’industria petrolifera, cementiera, dell’acciaio ed elettrica- lavorano per includere lo stoccaggio della CO2 tra i progetti “eleggibili” nell’ambito dei Clean Development Mechanism (Cdm) delle Nazioni Unite, quelli “verdi” che generano crediti di emissione. A metà ottobre si è tenuto a Londra un incontro del Carbon Sequestration Leadership Forum (Cslf, www.cslforum.org), di cui fanno parte 23 Paesi (tra cui Cina, Giappone e Usa) e la Commissione europea. C’era anche il ministro italiano dello Sviluppo economico, Claudio Scajola, che ha annunciato che il nostro Paese “sperimenterà” il Ccs nelle centrali Enel di Porto Tolle (Rovigo, vedi Ae 108) e Sulcis (Cagliari). L’Ue finanzierà con circa 1,35 miliardi di euro questi progetti sperimentali, anche se molte analisi -tra cui uno studio dell’Energy Technology Innovation Policy di Harvard- evidenziano i costi eccessivi di una tecnologia “non matura”. Secondo il report “The Realistic Cost of Carbon Capture”, lo stoccaggio di una tonnellata di CO2 costerà dai 120 ai 180 dollari, con un aumento tra gli 8 e i 12 centesimi del prezzo di un chilowattora di energia prodotta. Il Ccs nasconde un’evidenza: la necessità di ridurre l’utilizzo di combustibili fossili. È una “falsa soluzione”, che allontana investimenti dalle energie rinnovabili.
Il trucco delle foreste
L’acronimo è Redd (Reducing Emissions from Deforestation and Degradation), e alla lettera significa “Riduzione delle emissioni a causa della deforestazione e della degradazione dei suoli”. Dovrebbe sancire il principio per cui i Paesi in via di sviluppo saranno pagati per ridurre le proprie emissioni fermando la deforestazione e i cambiamenti nell’uso del suolo. Per molti, l’accordo Redd è la “pietra miliare” su cui costruire un protocollo post-Kyoto, e nei gruppi di lavoro convocati dall’Unfccc (la Conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici) si tenta di armonizzare 30 diversi testi proposti. Molti gruppi indigeni e alcune ong, però, protestano: a loro avviso, Redd significa “Raccogliere profitti dalle espulsioni forzate, furto di terra, deforestazione e distruzione della biodiversità più piantagioni industriali, alberi ogm ed aree protette”. Si tratta, secondo l’Indigenous Environmental Network (www.ienearth.org) di “Co2lonialismo delle foreste”.
Anche l’Onu -che definisce foreste anche le piantagioni- afferma che l’accordo Redd potrebbe portare a criminalizzare l’agricoltura e gli stili di vita indigeni, a violare i diritti delle popolazioni indigene, a “chiudere a chiave” le foreste ed emarginare i senza terra.
Trasporti come se nulla fosse
Aerei e navi continueranno ad emettere “senza contatore” anche dopo il 2012. È improbabile, infatti, che la Conferenza di Copenhagen arrivi a stabilire degli obiettivi di riduzione per i settori “aviazione” e “trasporto marittimo”, che già erano rimasti da fuori dal Protocollo di Kyoto. Continua la resistenza di Icao (l’Organizzazione internazionale dell’aviazione civile) e Imo (l’Organizzazione internazionale dei trasporti marittimi). L’Unione europea avrebbe dovuto presentare le proprie proposte in merito ai target di riduzione ai Bangkok Climate Change Talks 2009, il penultimo incontro preparatorio alla Conferenza sul clima che si è tenuto a ottobre, ma non lo ha fatto. A settembre, la International Air Transport Association (Iata) aveva proposto una riduzione del 50% delle emissioni tra il 2005 e il 2050, ma secondo l’European Federation for Transport and Environment (T&E, transportenvironment.org) era un documento “privo di significato, che parlava di aspirazioni”. Secondo Bill Hemmings di T&E “la posizione di Icao e Iata è basata sulla premessa che le emissioni dell’aviazione possano crescere all’infinito, e che -in un dato momento-, l’aviazione sarà d’accordo a farsi carico delle proprie esternalità”.
Fondi climatici, per chi?
Negli ultimi due anni si è assistito a un proliferare dei cosiddetti “fondi climatici”, promossi da vari organismi per arginare l’emergenza “surriscaldamento globale”. A quelli delle Nazioni Unite, gli unici gestiti a livello multilaterale da tutti i governi membri, si affiancano quelli istituiti dalla Banca mondiale, che però già dalla loro nascita hanno provocato più di una controversia. Si tratta di tre fondi per il trasferimento di tecnologie, investimenti strategici in energie rinnovabili e per la protezione delle foreste. Sulla carta esistono da un anno e “valgono” 6,3 miliardi di dollari, la cifra maggiore messa assieme per interventi sul clima nei Paesi del Sud. Nessuno sa quanti fondi siano stati davvero versati, né si ha idea della ripartizione delle risorse tra i diversi fondi. Sono però evidenti i loro aspetti più discutibili, a partire dalla scarsa trasparenza e dal sostegno del fondo sulle tecnologie, il più cospicuo dei tre, alla costruzione di nuove e inquinanti centrali a carbone nel Sud del mondo. I Paesi in via di sviluppo e numerosi gruppi della società civile preferirebbero meccanismi e strutture diverse e nell’alveo delle Nazioni Unite. Non foss’altro perché i banchieri di Washington continuano a investire in progetti altamente inquinanti, che contribuiscono copiosamente alle emissioni di gas serra nell’atmosfera, come l’estrazione di combustibili fossili (2,2 miliardi in media nel triennio 2007-09, di cui 470 per il carbone), o in grandi dighe. Queste ultime, conteggiate come rinnovabili, inflazionano i dati sugli investimenti in energie pulite. I rappresentanti dei Paesi più poveri evidenziano una pericolosa sovrapposizione tra i fondi Onu e quelli della World Bank, che con la copertura del G20 punta a ottenere la gestione della finanza globale per il clima. (Luca Manes)
Ridurre, non compensare
L’idea di barattare le propri emissioni con foreste da piantare altrove non funziona. Significherebbe, cioè, riprodurre a livello volontario e personale lo schema, che non ha dato risultati, della compravendita dei diritti di emissione (vedi Ae 102). I climatologi ci dicono che non abbiamo bisogno di compensazioni, ma di riduzioni. Perciò:
– non usate l’auto ma la bici o il trasporto pubblico, e volate solo se devete. Un Suv emette 1,3 tonnellate di CO2 per percorrere meno di 3.000 chilometri. 1,3 tonnellate di CO2 pro capite è il nostro “fabbisogno” annuale di CO2 se vogliamo contenere entro i 2° l’innalzamento della temperatura;
– riducete il consumo di carne. Ogni chilo causa l’emissione di gas serra (inclusi metano e ossido d’azoto) con un effetto equivalente a 3-4 chili di CO2: secondo la Fao, l’allevamento di bestiame è responsabile di circa il 18% delle emissioni totali di gas serra;
– sfruttate gli incentivi per ristrutturare la vecchia abitazione: potete ridurre i consumi energetici dal 50% all’80%. E non riscaldate mai più del necessario: 18-20° C sono generalmente sufficienti nelle stanze più usate.
Info: www.cop15.dk, il sito della Conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici che si terrà a Copenhagen, in Danimarca, dal 7 al 18 dicembre; www.climate-justice-action.org, la rete internazionale Climate Justice Action, che sta organizzando mobilitazioni e un contro forum in Danimarcia nei giorni di Cop15; www.greenpeace.it/energyrevolution, consigli pratici per salvare il clima partecipando alla rivoluzione energetica