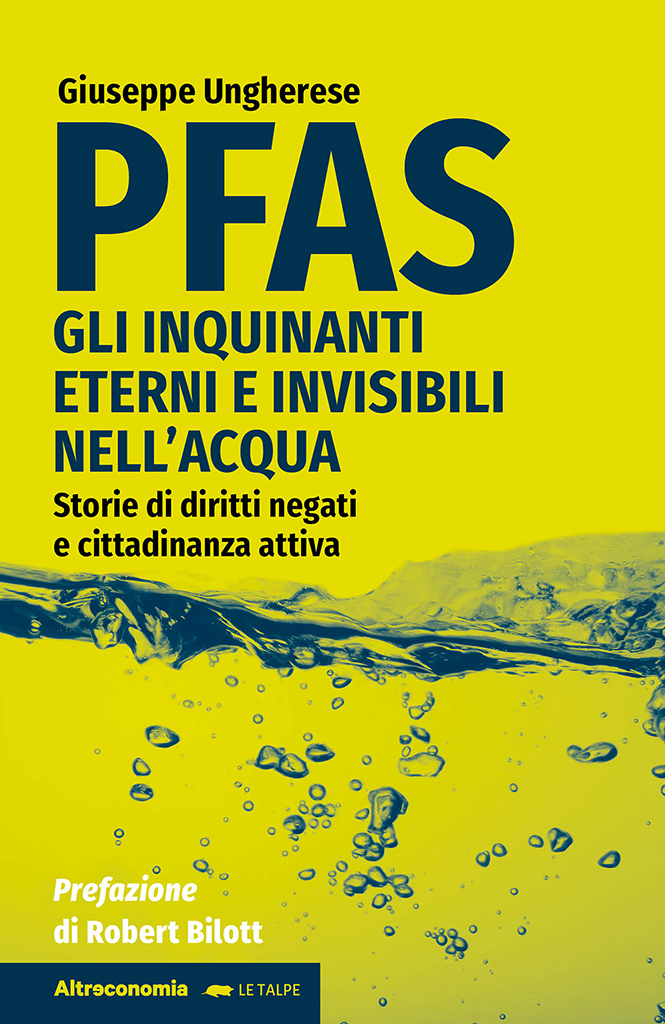Ambiente
Il greggio italiano è un’illusione

Anche sfruttando tutto il petrolio e il gas presenti nel sottosuolo e offshore, il nostro Paese non potrebbe ridurre la dipendenza dall’estero
Entro la fine del 2012, salvo complicazioni, il governo Monti dovrebbe varare il nuovo Piano Energia nazionale. Una serie di misure per il settore energetico italiano -definite “urgenti”- fortemente volute dal ministro allo Sviluppo economico, Corrado Passera, ed orgogliosamente sponsorizzate dalla lobby petrolifera, compagnie nostrane e straniere su tutti.
Perché il Piano Energia strizza gli occhi proprio ai petrolieri, come dimostra un comunicato stampa di Assomineraria -l’Associazione mineraria italiana per l’industria mineraria e petrolifera- dell’aprile 2012. Un disegno di legge ben preciso che -al fine di garantire l’innalzamento della produzione petrolifera nazionale fino al 20% del fabbisogno nazionale, l’aumento del Prodotto interno lordo di mezzo punto e la riduzione di 6 miliardi della bolletta energetica- necessita, oltre che del lasciapassare da parte del Cipe (Comitato interministeriale per la programmazione economica) che ne finanzierà lo sviluppo, anche della realizzazione di imponenti opere infrastrutturali: rigassificatori (da Livorno e Porto Empedocle, da Falconara a Gioia Tauro), gasdotti nazionali ed internazionali (Galsi, TAP, South Stream e IGI-Poseidon), centrali e megastoccaggi.
Fino ad arrivare a nuove trivellazioni alla ricerca di greggio, gas e gas non convenzionale (shale gas). Per farlo serve una normativa sulle autorizzazioni più snella e la possibile abolizione di ogni vincolo e limite per la prospezione, la ricerca e coltivazione di idrocarburi nel sottofondo marino. Perché le attuali norme di tutela dell’ambiente -tra cui quelle che fissano a 12 miglia dalle coste il limite entro il quale non è possibile effettuare trivellazioni in mare- rappresentano un vincolo troppo rigoroso.
Altreconomia, in un articolo dal titolo “Il greggio italiano è un’illusione” dell’aprile scorso aveva già anticipato questi temi, così come nel libro “Trivelle d’Italia”. Ecco il nostro pezzo:
Investimenti per 12 miliardi di euro, 70mila nuovi posti di lavoro, oltre 40 miliardi di euro di entrate per lo Stato in 20 anni e -nello stesso arco di tempo- un risparmio stimato sulla bolletta energetica di 120 miliardi di euro. Sarebbe questo il potenziale economico dello sfruttamento di idrocarburi nel nostro Paese. Numeri diffusi a febbraio da Assomineraria, l’associazione che rappresenta le compagnie che operano nella esplorazione e produzione di greggio e gas in Italia. Investimenti che, avvertono le imprese, potrebbero essere vanificati dai tempi, troppo lunghi, legati alla fase esplorativa e allo sviluppo delle attività estrattive. Per la prima, la media italiana è di 36 mesi, un anno in più rispetto al resto del mondo; per la seconda, invece, ci vogliono in media 8 anni, il doppio che altrove. In pratica, una media di 11 anni prima di poter “pescare” idrocarburi nel sottosuolo italiano. Proprio sul superamento di queste “difficoltà strutturali” puntano tutto le multinazionali che decidono di trivellare nel nostro territorio, in terraferma e in mare.
Per snellire le lungaggini burocratiche serve l’intervento del Governo e del ministero dello Sviluppo economico. Corrado Passera, però, non si tira indietro, rilanciando la necessità di “adeguare agli standard internazionali la normativa di autorizzazione e concessione che chiaramente non è oggi adeguata, richiedendo passaggi autorizzativi lunghissimi, oltre ad essere per molti aspetti più restrittiva di quanto non sia previsto dalle normative europee che, a nostro parere, dovrebbero essere il punto di riferimento: non c’è ragione di andare oltre”. Un passaggio che dimostra l’enorme influenza della lobby petrolifera, che può permettersi di “suggerire” nuovi possibili interventi normativi a favore dell’indotto estrattivo. Ma il ministro dice di più. E a margine di un forum economico internazionale tenutosi a Cernobbio (Co) a fine marzo, apre le porte allo sfruttamento di “risorse italiane, giacimenti di gas e petrolio non ancora sviluppati”. Passera tira in ballo le riserve accertate e anche quelle non accertate, cioè le quantità di idrocarburi “recuperabili”. Gran parte di queste riguarderebbero giacimenti sotterranei presenti soprattutto nelle regioni del Sud Italia, con la Basilicata capofila.
Tra i Paesi europei, l’Italia è già al quarto posto per produzione petrolifera. Al 31 dicembre 2011 la produzione di greggio si è attestata su 5.283.866 tonnellate, quasi 40 milioni di barili. L’Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi e le georisorse (Unmig) comunica che l’84% della produzione nazionale proviene dalla terraferma, il restante 16% dal mare. Numeri che potrebbero aumentare se calcolassimo (e sfruttassimo) le riserve, tra le prime a livello europeo per potenzialità.
Incrociando i dati forniti dal ministero dello Sviluppo economico con quelli di Assomineraria, infatti, sarebbero 800 i milioni di barili di greggio e 150 i miliardi di metri cubi di gas che si spera di produrre. Invece, potrebbero essere 900 milioni i barili potenziali delle nostre riserve e 180 miliardi i metri cubi di gas ambìti.
Anche se escludiamo le riserve, i numeri paiono importanti. In ogni caso, potrebbero incidere poco sulle percentuali di greggio importato dall’Italia, pari nel 2011 a 72 milioni di tonnellate (circa 468 milioni di barili), pari a poco più del 92% del totale. Con 27 milioni di tonnellate, i maggiori fornitori dell’Italia sono i Paesi dell’ex-Unione Sovietica (circa 175 milioni di barili). 19 milioni di tonnellate arrivano dal Medio Oriente (circa 123 milioni di barili) e 15 milioni e mezzo di tonnellate dal continente africano (circa 100 milioni di barili). Il resto proviene dall’Europa e dalle Americhe. Ma il confronto tra quello che potremmo produrre e quello che importiamo dice altro. Ipotizzando di estrarre nei prossimi dieci anni gli 800 milioni di barili di greggio ancora da produrre (tempo medio per mettere in produzione un giacimento), le importazioni potrebbero essere “sgravate” di circa 80 milioni di barili all’anno, ovvero, più o meno, del 17% ogni anno, e per un periodo limitato di tempo. Quantità che influirebbero poco a livello di costi economici, ma moltissimo a livello di impatti ambientali e consumo del territorio, già messo a dura prova dalle infrastrutture a supporto delle attività estrattive: 17 raffinerie, 554 depositi di oli commerciali e 41 oleodotti -13 per il trasporto di greggio e 28 per il trasporto di prodotti petroliferi-, di cui 14 di proprietà Eni, pari a 2.515 chilometri di autostrade d’acciaio, come la distanza -andata e ritorno- tra Vibo Valentia, in Calabria, e Bolzano, in Trentino Alto Adige. Insomma, il gioco non vale la candela, se non fosse per la favorevole legislazione italiana in tema di royalty, ossia la previsione di compensazioni ambientali tra le più basse del mondo. Ogni compagnia petrolifera versa a Stato e Regione il 7% per l’estrazione di idrocarburi gassosi in mare, il 4% per l’estrazione di greggio in mare e il 10% per l’estrazione di gas e petrolio in terraferma (vedi Ae 131). La evocata autosufficienza economica, sarebbe un business per le sole compagnie petrolifere, che devono però fare i conti con il crollo dei consumi petroliferi, che in Italia nei primi tre mesi del 2012 sono stati pari a circa 15,9 milioni di tonnellate, con un calo del 9% rispetto allo stesso periodo del 2011.
Eppure le parole del ministro Passera hanno trovato presto proseliti. Tra questi Stefano Saglia, deputato del Pdl, già sottosegretario al ministero dello Sviluppo economico, che ha detto: “Le dichiarazioni del ministro Passera sul rilancio della produzione nazionale di idrocarburi vanno nel verso giusto. L’Italia ha bisogno di autosufficienza energetica e per far ciò deve puntare sulle proprie risorse nazionali”, sottolineando però che “è stato proprio questo Governo ad aver ceduto alle pressioni degli ambientalisti quando ha ritirato i provvedimenti che avrebbero ridotto le restrizioni per le prospezioni minerarie e la produzione in Italia”. Proprio così. Le attuali norme di tutela dell’ambiente -tra cui quelle che fissano a 12 miglia dalle coste il limite entro il quale non è possibile effettuare trivellazioni in mare- rappresentano un vincolo troppo rigoroso. Ecco palesarsi la possibilità di mettere mano alla normativa e, magari, rispolverare la legge “libera-trivelle”. —