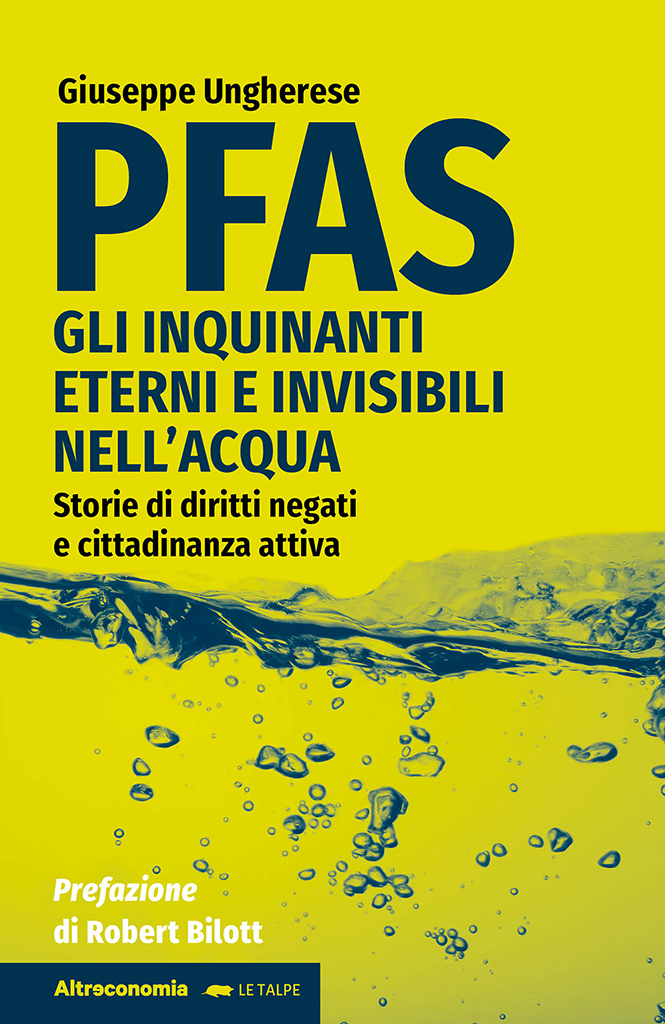Ambiente
Diario da Copenhagen

Copenhagen, 18 dicembre 2009 (AZ) Il mondo sta guardando. Ma lo hanno lasciato praticamente fuori dalla porta. Fisicamente, perché oggi, al Bella Center, dopo le botte ed i lacrimogeni dei giorni scorsi è stato permesso l’ingresso a sole 90 persone…
Copenhagen, 18 dicembre 2009 (AZ)
Il mondo sta guardando. Ma lo hanno lasciato praticamente fuori dalla porta. Fisicamente, perché oggi, al Bella Center, dopo le botte ed i lacrimogeni dei giorni scorsi è stato permesso l’ingresso a sole 90 persone della società civile. E politicamente, perché dopo il momento dei discorsi ufficiali e delle bozze finali, la montagna sembra partorisca il topolino.
Obama, atteso come il nuovo che avanza, ha parlato di un impegno limitato degli Stati Uniti, in un discorso che ha affiancato una grande oratoria a numeri miserrimi. Gli Stati Uniti non sarebbero in grado di andare oltre il taglio del 17% nel 2020 rispetto alle emissioni del 1990. Addirittura il 3% in meno rispetto al 20% proposto dall’Europa.
Nelle bozze, in verità, sugli impegni di taglio delle emissioni non si parla di numeri. Ma dio generiche volontà. Ed i soldi promessi sono pochi, dilazionati nel tempo e soprattutto poco impegnativi. Secondo World Development Movement, membro del network Climate Justice Now!, davanti agli oltre 400 miliardi di dollari richiesti dai Paesi del G77 solo che alcuni giorni fa, vengono offerti da Stati Uniti ed Unione Europea 10 miliardi di dollari (un quarantesimo) per il biennio 2010-2012, provenienti per lo più da linee di finanziamento già esistenti (quindi non nuovistanziamenti) che dovrebbero salire a 100 miliardi di dollari. “Dovrebbero” perché in verità la cifra di 100 miliardi di dollari si riferisce al costo necessario per combattere il cambiamento climatico e non quelli veramente messi a disposizione. Per di più, buona parte delle risorse citate, da 22 a 50 miliardi di dollari) proverranno da impegni che coinvolgeranno sia i Paesi industrializzati sia quelli emergenti, escludendo quindi i Paesi più poveri.
Viene indicato sempre il limite di 2°C, tanto osteggiato dai Paesi più poveri, per le conseguenze pesanti che potrebbe avere sulle loro economie e sulla loro produttività agricola.
Nelle bozze circolate nei giorni precedenti, nulla a supporto di un cambiamento del modello di sviluppo: l’agricoltura industriale, gli agroarburanti, persino il nucleare. Tutto diventa buono da far passare sotto la lotta al cambiamento climatico. E’ la “shock economy”, descritta perfettamente dalla Klein. Davanti al disastro che incombe, è possibile far passare qualunque cosa, anche la più discutibile ed osteggiata.
Ed intanto, mentre i politici parlano ed i leader non decidono, dei dati raccolti in quattro anni dal progetto Share promosso dal Comitato Evk2Cnr e analizzati nell’ambito di una collaborazione con il Nasa Goddard Space Flight Center aggiungono un’ulteriore preoccupazione sul futuro che ci aspetta. I ghiacciai himalayani sono a rischio di aumento dello scioglimento del 24% rispetto alla velocità normale. "E’ una minaccia che grava direttamente su un miliardo e mezzo di persone” affermano gli esperti” e a Copenhagen, nessun atto dedicato ai ghiacciai himalayani pare sia stato inserito nell’agenda ufficiale del Cop 15".
Sembra fantasia, ma non lo è. L’unica cosa che appare fantascientifica è che i Capi di stato del mondo intero non se ne assumano la responsabilità.
————————————————————————————————————————————————
Copenhagen, 17 dicembre 2009 (LM)
E venne il giorno del G2. Stati Uniti e Cina sono finalmente usciti allo scoperto. Per la verità i cinesi lo avevano già fatto in nottata con le possibili indiscrezioni sull’impossibilità di raggiungere un’intesa fatte trapelare ad arte da una “fonte anonima” a un giornalista dell’agenzia Bloomberg. Ma le seguitissime conferenze stampa delle due super-potenze e responsabili del 50 per cento delle emissioni di gas serra hanno fugati tutti i dubbi, qualora ce ne fossero ancora: a Copenaghen l’accordo è lontano, le speranze ridotte al lumicino.
Ad aprire le danze è stato il segretario di stato americano Hillary Rodham Clinton, che ha battuto molto sui fondi da destinare ai Paesi del Sud. “Tramite iniziative misto pubbliche-private e strumenti di finanza alternativa arriveremo a destinare alle realtà più povere ed impattate dal cambiamento climatico 100 miliardi di dollari l’anno fino al 2020, partendo dal 2012”, ha affermato il ministro degli esteri Usa, parafrasando quanto detto dal Premier britannico Gordon Brown in plenaria poche ore prima. A precisa domanda su quali fossero gli strumenti di finanza alternativa presi in considerazione, la Clinton ha preferito glissare, facendo capire che su questo fronte ci sono però delle opinioni differenti. Insomma, tirando ad indovinare, agli Usa non piace tanto la tassa sulle transazioni finanziarie che invece sembra più gradita a Regno Unito, Francia e Germania. L’incertezza rimane anche su quanto il pacchetto proposto dal segretario di stato sia basato su soldi pubblici e su quanto incidano invece gli investimenti e i prestiti dei privati.
“Siamo sulla stessa barca e dobbiamo attraversare il fiume insieme”. Citando questo proverbio cinese l’esponente dell’esecutivo guidato da Barack Obama ha richiamato tutti, ma in particolare la Cina, a un impegno comune per un intesa che non andrà comunque oltre un mero accordo politico su cui costruire un trattato vincolante nel corso del prossimo anno. Senza un’intesa sugli standard di trasparenza -“che i cinesi devono accettare” – e su un impegno reciproco sul taglio delle emissioni – – “noi ridurremo del 17% entro il 2020 e del 42% entro il 2030 rispetto ai livelli del 2005” – salta tutto.
Così come potrebbe saltare la trasferta danese di Obama se non ci fosse più margine di manovra, ha fatto intendere la Clinton con una frase molto sibillina.
La risposta dei cinesi non si è fatta attendere. Invece del Premier Wen Jiabao, in conferenza stampa si è presentato il vice-ministro degli Esteri He Yafei che, in perfetto inglese, ha snocciolato i punti su cui c’è disaccordo. Praticamente ogni aspetto fondamentale del negoziato. Non è mancata la ormai consueta stoccata al governo danese sulle questioni procedurali. Yafei ha chiarito che gli obiettivi di riduzione delle emissioni della Cina non sono sindacabili e saranno raggiunti anche qualora Copenaghen si dovesse concludere con un nulla di fatta. Quelli dei Paesi ricchi, invece, non sono ritenuti sufficienti. Il vice-ministro ha poi voluto rispondere senza mezzi termini ai richiami della Clinton sulla trasparenza. “Noi prenderemo degli obblighi vincolanti e che saranno pienamente verificabili, anche a livello internazionale”. Anche sui fondi c’è disaccordo. Quanto promesso dagli Usa e dagli altri Paesi occidentali non basta.
———————————————————————————————————————————————–
Copenhagen, 16 dicembre 2009 (AZ)
A Copenhagen è arrivata la neve. Cosa frequente, d’inverno. Meno frequente è l’arrivo del premio Nobel Al Gore, quello che è apparso al pubblico sotto forma di ologramma al Wembley stadium all’inizio dell’anno. Questo Natale l’ex vicepresidente ha fatto il regalo di farsi vedere in carne ed ossa, il problema è che se fosse stato in silenzio avremmo apprezzato. Tra i principali affossatori di questo vertice del possibile nulla di fatto è proprio Gore, che indica il giugno del 2010 come possibile date quando chiudere l’anelato accordo.
Questa una delle novità della giornata del 16, forse tra le meno eclatanti ma certamente di peso politico. In verità la mattina si è aperta con le manifestazioni di “Reclaim the power”, la parola d’ordine lanciata dai due network Climate Justice Now! e Climate Justice Action che hanno coordinato e promosso questi giorni campali. Manifestazioni letteralmente decimate dalla polizia danese: arresti preventivi, fermi di 24 ore, treni e metropolitane bloccate. Dei tre “bloc” che sarebbero dovuti partire verso il Bella Center, il Centro congressi dove si tiene la COP15, riesce a partire solo quello da Tornby station con diverse migliaia di persone. E’ quello concordato ed autorizzato dalla polizia, con un percorso prestabilito che avrebbe dovuto portare fin sotto le grate della COP15. Ma se è autorizzata la partenza, non è consentito l’arrivo dei manifestanti, considerato che vengono bloccate per un certo tempo sia la metropolitana che i treni.
Peggio finisce per il corteo non concordato né autorizzato che sarebbe dovuto partire da Orenstad station, la presenza della polizia è tale che i manifestanti (pochi) non riescono a fare due passi.
Il terzo blocco, il “bike bloc” organizzato con biciclette e quant’altro non si forma neppure, considerato che due giorni prima la polizia ha pensato bene di requisire le biciclette.
Altro destino ha la manifestazione interna (l’azione “inside”) che fa marciare tra delegati attoniti e festanti attivisti oltre 150 persone verso l’uscita. L’obiettivo è uscire per unirsi ai cortei in arrivo alla COP15, per organizzare una vera e propria Assemblea dei popoli. Ma polizia, manganelli e lacrimogeni impediranno sia il congiungimento che l’Assemblea, nella civile Danimarca la libertà di pensiero sembra non comprendere la libertà di manifestarlo.
Tutto questo mentre la situazione di stallo all’interno della COP15 assume il contorno della farsa: il ministro dell’ambiente danese Connie Hedegaard lascia la presidenza al premier Rasmussen per apparenti motivi formali (l’arrivo dei Capi di stato), in verità la Ministra era stata oggetto di contestazioni da parte dei Paesi del sud del mondo per apparenti favoritismi ai Paesi industrializzati.
Nei fatti non esiste ancora una bozza condivisa che dovrebbe essere firmata dai Capi di stato e nonostante l’ottimismo un po’ fuori le righe di Barack Obama: ”il presidente e’ fiducioso” sul fatto che ”la sua presenza potra’ aiutare” a raggiungere un accordo, ha affermato il suo portavoce Robert Gibbs.
In verità, ad oggi, di quell’ottimismo non se ne capiscono le ragioni. E la giornata della conclusione del vertice si avvicina.
Durante la manifestazione del 12 dicembre, Greenpeace aveva issato uno striscione sulla Rainbow Warrior, “i politici parlano, i leader decidono”. Il rischio sincero è che qui a Copenhagen non solo non decideranno nulla, ma alla fine non riusciranno neppure a capirsi.
————————————————————————————————————————————————
Copenhagen, 16 dicembre 2009 (LM)
Ormai sono rimasti in pochi, pochissimi, a farsi qualche illusione che il vertice di Copenaghen possa regalare al mondo un accordo di portata epocale per combattere i cambiamenti climatici.
Nelle enormi sale del Bella Center inizia a farsi largo un termine scomodo, ma forse del tutto appropriato: fallimento. Le dimissioni della presidentessa della Conferenza, il ministro dell’Ambiente danese Connie Hedegaard, non sono che l’ultimo campanello d’allarme che gli addetti ai lavori e gli analisti hanno udito fin troppo bene.
Certo, la Hedegaard ha dichiarato di aver lasciato il posto al premier Lars Rasmussen per una pura ragione procedurale, visto che tra oggi e venerdì sono attesi in Danimarca ben 115 capi di Stato e di governo e si è pensato che fosse più opportuno mettere un loro pari alla presidenza del summit. Spiegazione tecnicamente ineccepibile e che i media locali difendono con convinzione, ma le voci che danno imminente una nuova bozza di testo finale sembrano confermare il disagio e l’incertezza dei padroni di casa, peraltro già scottati dalla fuga di notizie sul primo testo negoziale occorsa la settimana scorsa. Padroni di casa che sono sotto ulteriore pressione dopo le accuse -mosse nei loro confronti dalla Cina e da alcuni Paesi del Sud- di agire in maniera poco trasparente e di essere fin troppo appiattiti sulle posizioni dell’Unione europea.
Ma basta rileggersi le dichiarazioni del premier britannico Gordon Brown o del Segretario generale delle Nazioni Unite per avere ulteriori timori su un esito positivo dell’incontro. Il primo, appena giunto a Copenaghen martedì sera, ha prefigurato un possibile naufragio dei negoziati, richiamando però all’impegno le sue controparti di tutto il mondo. Il secondo ha ammesso che il tanto atteso accordo di sostanza sui fondi da destinare ai Paesi poveri colpiti più duramente dai cambiamenti climatici quasi sicuramente non si raggiungerà, nonostante le promesse fatte due anni fa durante il summit di Bali.
Anche le ong meno radicali, come Oxfam, criticano con durezza lo stallo attuale, richiamando i Paesi del Nord ai loro impegni soprattutto in termini di “finanza per il clima”. Insomma, basta chiacchiere, il tempo a disposizione è poco e bisogna mettere mano al portafoglio per dare una mano a coloro che i cambiamenti climatici non li hanno provocati ma più ne subiscono le conseguenze.
Ma l’aria che si respira al Bella Center è intossicata anche da altri miasmi. Questa mattina è stato negato l’accesso al Bella Center a tutti i rappresentanti di Friends of the Earth. Nonostante ieri lo stesso Yvo de Boer, segretario generale della Convenzione Onu sui Cambiamenti climatici, avesse parlato di quote per le varie ong presenti, gli esponenti della più grande organizzazione ambientalista del mondo non sono potuti entrare nella sede del vertice. Neanche coloro in possesso del famigerato secondo badge, che in teoria avrebbe dovuto evitare qualsiasi tipo di problemi, potranno seguire “dal vivo” i lavori del summit.
Nnimmo Bassey, presidente di Friends of the Earth International, ha manifestato tutto il suo disappunto: “Siamo scioccati e del tutto sorpresi da quanto si è verificato questa mattina” ha affermato. In un secondo momento gli attivisti della ong sono riusciti a parlare con de Boer e altri esponenti delle Nazioni Unite, che però non hanno tenuto esattamente una linea comune. Si passava dai motivi di sicurezza alla mancanza di spazio nel centro congressi…
Copenhagen, 15 dicembre 2009 (LM)
Lo hanno già scritto numerosi quotidiani, riferendosi a quanto accaduto ieri, 14 dicembre. Oggi vi possiamo confermare, avendolo sperimentato sulla nostra pelle, che la COP 15 di Copenaghen non sarà ricordata come il summit meglio organizzato della storia. Anzi. Noi abbiamo atteso oltre cinque ore per poter ritirare il nostro passi – si badi bene, quello per la stampa. Per buona parte della coda siamo stati al freddo al gelo, muovendoci molto lentamente – ma la fila riservata agli esponenti delle Ong e della società civile era ancora più lunga e statica. A proposito di società civile, in tanti non possono più entrare, si parla di quote e di doppi badge. Secondo il Climate Justice Network il 70 per cento degli accreditati non avrà più accesso al Bella Center, la sede del summit. Una sede grande ma forse non abbastanza, se lo stesso Yvo de Boer, segretario generale della Convenzione Onu sui Cambiamenti climatici, ha dovuto ammettere che a fronte delle 15mila unità di capienza, sono stati rilasciati 45mila permessi di entrata e che per le Ong ci saranno delle ingenti limitazioni. Per i cinquemila giornalisti ammessi le postazioni approntate dagli organizzatori non bastano, almeno a giudicare dalla situazione all’ora di pranzo di oggi.
Insomma, tra una latente disorganizzazione e l’occasione presa al volo di mettere a tacere un po’ di voci “dissenzienti”, le Nazioni Unite e il governo danese hanno fatto sicuramente una figuraccia.
Nel frattempo al Klima Forum non si sono ancora spenti gli echi dei duri scontri andati in scena la notte passata nel quartiere di Christiania. Se ne parla, e parecchio, sebbene a tenere banco siano ancora i numerosi incontri e seminari in programma. Tra i più seguiti, quello del pomeriggio con Naomi Klein, durante il quale è stata “premiata” la Monsanto con l’Angry Marmaid Award per la più nefasta attività di lobbying sulla lotta ai cambiamenti climatici. La multinazionale americana del settore agricolo si è “imposta” con il 37% per cento degli oltre 10mila voti registrati sul sito di Friends of the Earth, l’organizzazione che ha lanciato l’iniziativa. Al secondo posto la corporation petrolifera anglo-olandese Shell (18%).
La Monsanto è da anni in prima fila nel promuovere le sue sementi geneticamente modificate, che la compagnia definisce “un’ottima soluzione per combattere i cambiamenti climatici”. Nella sostanza, invece, la soia biotech che ha invaso l’America Latina ha contribuito a imponenti processi di deforestazione, con il conseguente aumento delle emissioni di gas serra.
Un altro degli eventi di maggior interesse della giornata è stato il workshop su finanza e clima, co-promosso tra gli altri dalla italiana CRBM. Steve Kretzmann di Oil Change International ha riferito le cifre contenute nell’ultima bozza negoziale in merito ai fondi di adattamento per i Paesi del Sud del mondo, previsti espressamente dall’articolo 11 del Protocollo di Kyoto. In totale si parla di 10 miliardi di dollari fino al 2012. Troppo poco e per un lasso di tempo troppo limitato, anche in considerazione che con una tassa sulle transazioni finanziarie o l’impiego dei fondi prima destinati ai sussidi per i combustibili fossili (si parla di almeno 150 miliardi di dollari) si potrebbero raggiungere quei 100 miliardi l’anno richiesti dalle realtà più povere del pianeta. Le speranze che il testo definitivo possa contenere ben altri dati non sono tante, ma ormai manca poco per sapere come andrà a finire.
———————————————————————————————————————————————–
Copenhagen, 14 dicembre 2009 (AZ)
 Un proverbio Masai recita “se vuoi arrivare primo, corri da solo. Se vuoi camminare lontano, cammina insieme”. E loro, insieme, sono usciti dalle stanze negoziali sbattendo la porta. Sono le delegazioni dell’Africa group, degli LDCs (i Paesi più poveri), addirittura del G77 che di fronte all’ennesima forzatura dei Paesi industrializzati hanno deciso di sospendere i negoziati della COP15 sui cambiamenti climatici, in corso a Copenhagen. «Stanno cercando di far precipitare tutto», ha accusato Kamel Djemouai, il capo della delegazione algerina, durante una conferenza stampa. Nessun accordo sui tagli alle emissioni, nessun accordo sui finanziamenti per i progetti di mitigazione e di adattamento, nessun accordo sull’aumento della temperatura media. Ma soprattutto il tentativo di far fuori la cornice del protocollo di Kyoto, che per quanto sghimbescia può essere è comunque un quadro normativo esistente.
Un proverbio Masai recita “se vuoi arrivare primo, corri da solo. Se vuoi camminare lontano, cammina insieme”. E loro, insieme, sono usciti dalle stanze negoziali sbattendo la porta. Sono le delegazioni dell’Africa group, degli LDCs (i Paesi più poveri), addirittura del G77 che di fronte all’ennesima forzatura dei Paesi industrializzati hanno deciso di sospendere i negoziati della COP15 sui cambiamenti climatici, in corso a Copenhagen. «Stanno cercando di far precipitare tutto», ha accusato Kamel Djemouai, il capo della delegazione algerina, durante una conferenza stampa. Nessun accordo sui tagli alle emissioni, nessun accordo sui finanziamenti per i progetti di mitigazione e di adattamento, nessun accordo sull’aumento della temperatura media. Ma soprattutto il tentativo di far fuori la cornice del protocollo di Kyoto, che per quanto sghimbescia può essere è comunque un quadro normativo esistente.
Le delegazioni hanno acconsentito dopo poche ore di riprendere i negoziati, ma lo strappo è davanti a tutti: il clima, a Copenhagen, è sempre più incandescente. E questo soprattutto dopo i tentativi di gestione non trasparente dei processi decisionali da parte dei Paesi industrializzati, come le ministeriali Wto ci hanno purtroppo abituato. Una situazione talmente inaccettabile che Pablo Solon, ambasciatore della Bolivia presso le Nazioni Unite, nell’incontro quotidiano con la stampa ha chiesto ”un processo trasparente, democratico ed inclusivo. Sembra che i negoziatori vivano dentro Matrix – ha accusato – mentre la negoziazione vera avviene nelle ”green room”, sedi separate in tavole piccole con ospiti selezionati”.
Sembra, ha continuato sulla linea “Hollywood” il diplomatico ”che quelli che hanno preso la ‘pillola rossa’ e che si rendono conto di che cosa sta succedendo davvero sono solo quelli che sono scesi in piazza sabato, che hanno denunciato che i Paesi ricchi stanno tentando di collazionare un accordo che alleggerirà i loro obblighi nell’affrontare questa urgente crisi climatica”.
Tutto questo mentre i Capi di stato e i ministri che contano stanno sbarcando in queste ore in Danimarca, con la grande responsabilità sulle spalle di chiudere un accordo che in diversi vorrebbero non ci fosse. E quelli che “sono scesi in piazza sabato” sono pronti a scendere in piazza pure mercoledì, per “reclaiming the power”.
Diversi blocchi: il blue bloc, il green bloc, il bike bloc, lo yellow bloc si dirigeranno verso il conference center. Di comune, con il più tetro black bloc, hanno soltanto parte del nome. Sono in realtà gruppi di affinità che avranno l’obiettivo di avvicinarsi il più possibile al vertice per organizzare una vera e propria assemblea fuori le porte della COP15. Chiedendo a chi sta dentro di uscire per denunciare dei negoziati troppo sbilanciati e troppo lenti.
Il presidente danese di turno si agita. La polizia purtroppo anche (sono di lunedì sera le notizie di lancio di lacrimogeni a Christiania). Gli unici che sembrano tranquilli sono i manifestanti e, tra loro, i gruppi di clown. Questo negoziato pare talmente una farsa che gli unici a loro agio sembrerebbero soltanto loro
———————————————————————————————————————————————–
Copenhagen, 13 dicembre (AZ)
Le bozze, come è ovvio che sia, sono provvisorie. Ma quello che più colpisce delle due bozze negoziali uscite venerdì mattina sono i dati messi tra parentesi quadra, ed ancora oggetto nel negoziato. Le forbici attorno alle quali si dovrebbero concentrare le decisioni dei capi di Stato sono: l’aumento della temperatura media che non dovrebbe superare gli 1.5°C o, in alternativa, i 2°C rispetto ai livelli preindustriali; il taglio delle emissioni delle parti prese collettivamente, che oscilla tra il 50%, l’85% o il 95% entro il 2050 rispetto ai livelli del 1990; e, infine, la riduzione delle emissioni dei Paesi industrializzati, che oscilla tra il 75/85%, almeno l’80/95% o più del 95% entro il 2050 rispetto ai livelli del 1990.
Una situazione che rispecchia ancora lo scontro che si sta consumando all’interno della Cop15. E che la società civile di tutto il mondo sta cercando di condizionare. “Cambiamo il sistema, non il clima” è stata la parola d’ordine della grande manifestazione di sabato, oltre 100mila persone hanno sfilato pacificamente e allegramente per le vie della città. Nessuno scontro né lancio di molotov, nonostante le notizie che venivano riportate dai media italiani che parlavano di un clima da guerra civile, né visto né immaginato qui in Danimarca. Il dubbio che le immagini truci e le notizie fosche interessino alla nostra stampa più della serietà dei contenuti espressi (e la positività di una dimostrazione così grande) c’è, ed è palese.
Dalla piazza del Parlamento al Bella Center, gli oltre 20 blocchi che formavano il corteo hanno dimostrato che è necessario cambiare modello di sviluppo e che da Copenhagen potrebbe ripartire un movimento che, a livello globale, potrebbe rimettere assieme contadini e pescatori, ambientalisti e organizzazioni dell’economia solidale. Soprattutto davanti all’inerzia di governi che, solo che un anno fa, hanno deciso di mettere mano al portafoglio per spendere migliaia di miliardi di dollari per salvare il sistema finanziario. “Too big to fail” , “troppo grandi per fallire” era la parola d’ordine riferita alle banche. Ci si domanda se anche il pianeta non sia un sistema “too big to fail” e se non sia il caso di mettere mano ai danni provocati da un modello di sviluppo impazzito.
Il rappresentante degli Stati insulari si è rivolto, con le lacrime agli occhi (e non metaforicamente), ad Obama: “Il nostro futuro è nelle vostre mani”, ha detto. Ed è nelle loro mani anche il futuro dei nostri figli. Parlano del 2050, quando nessuno di loro ci sarà più. Ma il cambiamento deve partire da oggi: radicale, deciso, concreto. “Basta bla bla, agite subito” recitava un cartello in manifestazione. Mai parole così semplici hanno raccolto tanta saggezza.
———————————————————————————————————————————————–
Copenhagen, 11 dicembre (AZ)
È come se durante un’alluvione, mentre l’acqua sta allagando il piano terra i vicini del piano di sopra continuino a giocare con i numeri. Il negoziatore algerino, a nome dei Paesi africani e davanti alla stampa mondiale, non poteva essere più chiaro.
Il cambiamento climatico è oramai una certezza, persino un “ambientalista scettico” come Bjørn Lomborg, che per anni ha scritto libri e ribadito l’inconsistenza del rischio del “global warming” ha dovuto fare marcia indietro. Figuriamoci i global leader, a cominciare dal presidente europeo Barroso, che dell’Ue vorrebbe fare la paladina della salvezza del pianeta.
Il problema, al solito, sono i passi concreti. I Paesi avanzati “hanno presentato in questi giorni all’esterno molti elementi filosofici, ma all’interno non hanno fatto seguito elementi concreti. Abbiamo la necessità di conoscere i numeri del loro impegno -hanno richiamato i negoziatori africani- perché ci risulta che stiano facendo molti passi indietro in concreto rispetto agli obiettivi concordati a Bali”. Che, per chiarezza, parlano di un impegno ancor più esigente per i Paesi industrializzati nel tagliare le proprie emissioni di gas serra e uno stanziamento di finanziamenti adeguato per le azioni di mitigazione e di adattamento al cambiamento climatico.
“L’Africa semplicemente non ha tecnologia e i soldi per affrontare i cambiamenti climatici. Siamo qui e lotteremo per avere un accordo vincolante, lotteremo per la nostra vita”. La conclusione della conferenza stampa dei Paesi africani non può essere più chiara.
Nonostante alcune note di ottimismo espresse da alcuni negoziatori in via informale e da alcune organizzazioni della Società civile a mezzo stampa, la situazione è ancora molto aperta e non è chiaro come si posizioneranno i Paesi, soprattutto in questi ultimi momenti prima dell’arrivo dei Capi di stato.
Il G77, in un incontro con la società civile ha ribadito la sua posizione ferma su non più di 1.5 °C e non più di 350 ppm di CO2 in atmosfera. Un quadro più rigido rispetto al Protocollo di Kyoto, che prevederebbe tagli drastici nelle emissioni dei Paesi industrializzati: del 52% nel 2017, del 65% nel 2020, dell’80% nel 2030.
In questa situazione, non è dato sapere da dove l’ottimismo di alcuni prenda alimento. Intanto la macchina organizzativa dei movimenti si è messa in moto da diversi giorni.
Solo oggi si contano circa 35 arresti per un presidio e un volantinaggio non autorizzato, dalla manifestazione del 12 dicembre inizierà una lunga fila di dimostrazioni a Copenhagen che si concluderà con “Reclaim the Power”, il 16 dicembre. Quando il mondo, oltre che a guardare, passerà all’azione.
———————————————————————————————————————————————–
Copenhagen, 10 dicembre 2009 (bis) (AZ)
Un consiglio: se avete intenzione di andare a Tuvalu per le vacanze, andateci il prima possibile. L’Oceano Pacifico, quello delle barriere coralline e degli atolli sabbiosi, rischia di inghiottirsele da qui a qualche decennio. Otto isole abitate da poco più di 11mila persone, il quarto Paese più piccolo al mondo, poco interessante per i negoziatori che contano, Tuvalu -assieme ad altri stati più o meno grandi, tra cui anche il più strutturato Bangladesh-, sarà una delle prime vittime dell’innalzamento degli oceani come conseguenza dell’aumento delle temperature.
È per questo che Tuvalu si è fatta coraggio e ha bloccato i lavori della Cop15, la Conferenza Onu sui cambiamenti climatici che si tiene in questi giorni a Copenhagen. Il fronte dei Paesi emergenti e in via di sviluppo non era riuscita a trovare una quadra tra quelli che credono che sia necessario riconfermare il Protocollo di Kyoto e quelli che chiedono un accordo più vincolante. Tra questi Tuvalu, che per bocca della capo negoziati Ian Fry ha chiarito che senza alcun accordo legale non si va avanti: “Il mio Primo ministro così come altri Capi di stato sono venuti a Copnhagen con la chiara intenzione di firmare un accordo legalmente vincolante”, ha dichiarato Fry alla stampa.
Alle richieste di Tuvalu si sono associati il gruppo delle Small Island States (42 Paesi) e i Paesi poveri africani, con l’obiettivo di inserire nell’accordo vincolante un aumento della temperatura non superiore agli 1,5 gradi centigradi, stabilizzando la concentrazione dei gas climalteranti in atmosfera a non più di 350 ppm (parti per milione) piuttosto che a 450 ppm con un aumento di 2° C della temperatura come indicato dai Paesi sviluppati ed alcuni Paesi emergenti.
“Con l’aumento di 0,8 gradi registrato nel secolo”, hanno sottolineato da Tuvalu, “l’aeroporto locale è già a serio rischio di inondazione. Questa è la nostra linea”, concludono, anche se non è supportata “da tutti i Paesi in via di sviluppo tanto che Brasile, Cina e Sudafrica, per loro questioni, si sono chiaramente dissociati”.
“Non siamo neanche sulla mappa” ha dichiarato Dessima Williams, capo negoziatrice per il gruppo delle Small Island States. E non è un eufemismo. Né Tuvalu né le altre piccole realtà insulari sono riportate sull’enorme globo di cinque metri di diametro che incombe sui delegati nella grande sala centrale del Bella Centre, il Centro conferenze dove si sta svolgendo la Cop15. E nonostante questo dietro a Tuvalu si sta raccogliendo una massa di Paesi piccoli o poveri, più di cento secondo Dessima Williams, che si sono posti l’obiettivo di limitare l’aumento della temperatura a 1.5 ° centigrafi.
Alla Wto di Cancun furono i Paesi africani a far saltare il banco dei negoziati, perché alla loro richiesta di trattare alcuni temi sensibili, tra cui il cotone, venne risposto picche dai Paesi industrializzati. Forse anche a Copenhagen saranno le formiche a fare la differenza.
———————————————————————————————————————————————–
Copenhagen, 10 dicembre 2009 (AZ)
Altro contesto, stesso scenario. Dalla Wto di Ginevra alla COP15 di Copenhagen il passo è paradossalmente breve. Non tanto per i chilometri che le distanzia, sempre di Europa per lo meno geografica si tratta, ma per le dinamiche che emergono. E che parlano di un mondo industrializzato che difende le proprie prerogative, nel tentativo di non assumersi le responsabilità storiche delle emissioni, che pure gli competono, e di ridurre la questione della lotta al cambiamento climatico a mere questioni di mercato. Con tutti i mezzi, anche quelli meno trasparenti.
Nelle scorse settimane la presidenza danese, che per definizione dovrebbe essere superpartes ha confezionato una bozza di dichiarazione finale nettamente a favore dei Paesi industrializzati. Il segreto di Pulcinella, uscito su tutti i giornali tra cui il Guardian grazie alla denuncia delle reti sociali presenti, ha fatto andare su tutte le furie i Paesi emergenti, la cui posizione si è immediatamente irrigidita. Lumumba Di-Aping, il presidente sudanese del gruppo informale del G77 più la Cina, che raggruppa ben 132 Paesi, ha denunciato il ruolo ambiguo del Primo Ministro Rasmussen nel gestire il negoziato addirittura accusandolo di “aver scelto di proteggere i Paesi ricchi”. Per Meena Raman, di Friends of the Earth Malesia “la bozza di accordi di Copenhagen viola i principi democratici delle Nazioni Uniti e minaccia i negoziati. Permettendo che il loro testo fosse discusso in incontri segreti con alcuni Paesi selezionati, la presidenza danese ha fatto l’opposto di quello che il mondo si sarebbe aspettato da un Paese ospite”.
Il giallo della “green room”, che come nelle peggiori tradizioni della Wto mette attorno ad un tavolo pochi privilegiati per decidere sulla testa di tutti gli altri, oramai è di dominio comune ed ha irrigidito le posizioni. Perché ha nella sostanza evidenziato che il tentativo dei Paesi industrializzati è quello di svuotare il Protocollo di Kyoto trovando un’altra cornice di riferimento, nella quale spostare gli obblighi e le responsabilità dei tagli e della limitazione delle emissioni per la gran parte sui Paesi emergenti. E le reazioni non si sono fatte attendere: dall’India, che fa notare come i Paesi in via di sviluppo stiano già rispondendo al cambiamento climatico nonostante non esista un obbligo legale nel farlo all’ALBA, rappresentata da Cuba, che evidenzia come il Protocollo di Kyoto sia l’unico regime legale per contrastare il riscaldamento globale, uno strumento che dovrebbe essere mantenuto e non rimpiazzato con nuovi accordi che potrebbero cambiare le carte in tavola.
Nel frattempo i movimenti sociali si stanno preparando alla prima della grandi mobilitazioni previste per i prossimi giorni, quella del 12 dicembre, dove migliaia di persone convergeranno su Copenhagen per chiedere un cambio radicale non nel clima, ma nel sistema. Sono attese quindicimila persona, ma pare che gli arrivi stiano superando le aspettative.
Sono intanto arrivati dalle ultime mobilitazioni della Wto di Ginevra oltre sessanta attivisti della rete internazionale Our World Is Not For Sale, tra cui contadini indiani, pescatori filippini e rappresentanti delle comunità indigene dalla Colombia e dall’Ecuador. La “carovana per la giustizia climatica” ha toccato Francia, Germania, Belgio prima di arrivare in Danimarca, con l’obiettivo di collegare le mobilitazioni contro le liberalizzazioni e per un commercio più giusto con la lotta contro il cambiamento climatico. Perché il problema, oggi, è di cambiare sistema.
——————————————————————————————————————————————–
Copenhagen, 7 dicembre 2009 (AZ)
Da oggi l’intero mondo si trova a Copenaghen. E non solo metaforicamente. In questi giorni nella Capitale danese comincia lo storico vertice sul clima: si apre la 15a Conferenza Onu sui cambiamenti climatici (Cop15) con decine di Paesi tra cui Usa, India e Cina insieme a Brasile e Sudafrica che saranno i principali protagonisti. A fianco del presidente degli Stati Uniti, Barack Obama, che ha annunciato la sua partecipazione alla chiusura dei lavori, al momento delle decisioni finali.
Un enorme globo di trenta metri di diametro troneggia su una delle piazza principali della città, a pochi metri dal parco divertimenti di Tivoli. E’ la cittadella di Hopenaghen, allestita in occasione della COP15, la Conferenza delle Parti delle Nazioni Unite sul cambiamento climatico, e che parla la lingua della quotidianità: con lo stand della cucina a risparmio energetico che affianca l’ultima invenzione di motore ibrido; con il modello di pannello solare che la municipalità di Barcellona sta utilizzando per l’illuminazione delle fermate dei bus affiancato dalla pala eolica Siemens che off-shore permette alla verde Danimarca di essere a posto con la sua coscienza. E tutto questo abbracciato da decine di migliaia di persone, tra giovani entusiasti e delegati disorientati, che si muovono a ritmo della musica di un famoso gruppo rock danese.
Perché questo Summit è anche e soprattutto questo: volti, persone e tante, tante speranze. Hopenaghen è solo una esempio, e forse il più mainstream e il più contraddittorio, di come questa città si stia preparando all’evento: aprendo spazi di incontro, discussione e divertimento sui temi del cambiamento climatico. Perché è un problema che appartiene a tutti, militanti e non, e dev’essere affrontato con la serietà e la delicatezza che merita, utilizzando insomma tutti i linguaggi possibili,a anche quelli giovanili.
Ma Copenaghen è anche il KlimaForum, il controvertice della società civile, con un programma di oltre 190 incontri pubblici focalizzati sul cambiamento climatico ed i suoi impatti, ed oltre 50 rappresentazioni musicali ed artistiche. A pochi metri dalla stazione, al centro della città, questo spazio aperto ha l’obiettivo di essere il riferimento per i movimenti sociali, le organizzazioni ed i singoli cittadini che non solo vogliono ascoltare, ma vogliono diventare protagonisti: in questi giorni verrà conclusa una Dichiarazione finale, già definita per sommi capi nel corso di quasi due anni, che verrà consegnata ai leader politici della Cop15 con l’obiettivo di influenzarne agenda e decisioni. Una cornice politica di riferimento nata dal basso e rivolta a tutti i movimenti sociali, perché da qui, dalla fredda Danimarca, potrebbe ripartire la speranza di un nuovo movimento.
Dall’altra parte (della città ma non soltanto) il Bella Center, il grande centro congressi all’ombra di un’enorme pala eolica, nel quale migliaia di delegati discuteranno sul pianeta del futuro. Le incertezze sono ancora molte, a cominciare dai numeri: dei 15mila delegati attesi ne sono arrivati ben 34mila, e siccome il Bella Center non ne accoglie più di 15mila, 20mila persone sono rimaste fuori, tra cui molti delegati africani.
Tutti gli occhi del mondo sono puntati sul Centro Congressi, dove nei prossimi giorni arriveranno anche i Capi di stato, oltre 103, tra cui Barack Obama. Le aspettative sono molte, comprese quelle del Segretario generale dell’Onu Ban Ki-moon, secondo il quale occorre "non perdere tempo, perché – ha detto – tutti i governi del mondo sono d’accordo sul fatto che la temperatura media del pianeta non deve aumentare di oltre due gradi".
Copenaghen, in questi giorni, si è trasformata in Hopenaghen, la città della speranza. Ma è bene tenere alta la guardia. Hopenaghen, l’evento organizzato con concerti e il mondo appeso a mezz’aria, ha avuto molti sponsor tra cui la Siemens, a fianco di Coca Cola o Bmw per sostenere eventi di sensibilizzazione sul clima.
Siemens però è membro della Tabd, la Transatlantic Business Dialogue, una delle principali lobbies transatlantiche molto influenti a livello di grandi istituzioni internazionali, come l’Organizzazione Mondiale del Commercio. L’apertura dei mercati e la globalizzazione dell’economia sono una della cause dell’aumento delle emissioni, e la Tabd è forte sostenitrice di un approccio liberista all’economia.
Dietro alle migliori intenzioni si nascondono, a volte, lati oscuri e doppiogiochismi. Ed è responsabilità di questo movimento nascente e della società civile globale tenere la barra a dritta e gli occhi bene aperti.