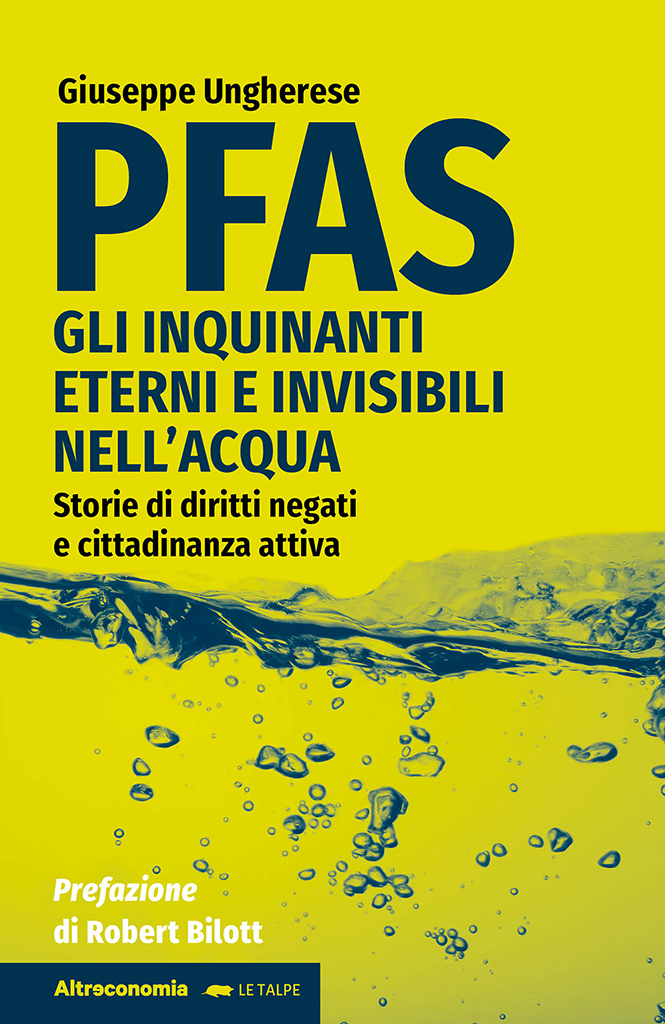Ambiente
L’Italia che cava non se la cava

Sono oltre 20mila i "crateri" disseminati lungo la Penisola. Ben sedicimila "ferite" sono aree estrattive ormai dismesse, ma mai "ricucite", cioè sottoposte a interventi di ripristino ambientale. Il business legato a quasi 6mila impianti attivi, invece, vale un miliardo di euro. Ma i canoni riconosciuti da chi preleva ghiaia, sabbia, calcare e pietre ornamentali sono spiccioli
L’Italia, la Repubblica fondata sul cemento, si nutre di cave. Se esistessero occhiali capaci di guardare dentro e oltre i manufatti che occupano quasi 22mila chilometri quadrati, vedrebbero enormi crateri, come ferite aperte sul territorio, che costellano i paesaggi italiani.
Legambiente, ogni anno, aggiorna il proprio censimento. Il rapporto 2014 -presentato a Roma il 29 aprile- spiega che da Nord a Sud le cave attive in Italia sono 5.592, quelle dismesse e monitorate addirittura 16.045, mentre se aggiungessimo anche quelle delle regioni che non hanno un monitoraggio (Calabria e Friuli-Venezia Giulia) il dato potrebbe salire a 17mila.
“Nonostante la crisi del settore edilizio abbia contribuito a ridurre le quantità dei materiali lapidei estratti, i numeri rimangono comunque impressionanti -spiega l’associazione ambientalista-: 80milioni di metri cubi di sabbia e ghiaia, 31,6 milioni di metri cubi di calcare e oltre 8,6 milioni di metri cubi di pietre ornamentali estratti nel 2012”. Un miliardi il ricavo per chi scava.
Il rapporto evidenzia i dati: sabbia e ghiaia rappresentano il 62,5% di tutti i materiali cavati in Italia, soprattutto nel Lazio, Lombardia, Piemonte e Puglia, dove ogni anno vengono prelevati circa 50 milioni di metri cubi di queste materie prime.
Rilevanti sono anche gli impatti e i guadagni legati all’estrazione di pietre ornamentali, ossia di materiali di pregio dove sono minori le quantità estratta ma rilevantissimi i guadagni e gli stessi impatti (dalle Alpi Apuane al Marmo di Botticino-Brescia, alla pietra di Trani).
 Poi c’è spazio per la denuncia (che purtroppo è sempre la stessa, da quando nel 2008 anche Altreconomia si occupò del tema): a governare un settore così importante e delicato per gli impatti ambientali è a livello nazionale tuttora un Regio Decreto del 1927, con indicazioni chiaramente improntate a un approccio allo sviluppo dell’attività oggi datato. Inoltre in molte Regioni, a cui sono stati trasferiti i poteri in materia nel 1977, si riscontrano rilevanti problemi per un quadro normativo inadeguato, una pianificazione incompleta e assenza di controlli sulla gestione delle attività estrattive (lo abbiamo segnalato, nell’inchiesta dedicata agli “Stati nello Stato”).
Poi c’è spazio per la denuncia (che purtroppo è sempre la stessa, da quando nel 2008 anche Altreconomia si occupò del tema): a governare un settore così importante e delicato per gli impatti ambientali è a livello nazionale tuttora un Regio Decreto del 1927, con indicazioni chiaramente improntate a un approccio allo sviluppo dell’attività oggi datato. Inoltre in molte Regioni, a cui sono stati trasferiti i poteri in materia nel 1977, si riscontrano rilevanti problemi per un quadro normativo inadeguato, una pianificazione incompleta e assenza di controlli sulla gestione delle attività estrattive (lo abbiamo segnalato, nell’inchiesta dedicata agli “Stati nello Stato”).
La presentazione del rapporto di Legambiente è anche occasione per ragionare di proposte per ridurre l’impatto ambientale dell’attività estrattiva nel territori. In questa direzione va la proposta di Capitolati RECYCLE, elaborata in collaborazione con Atecap, che si pone l’obiettivo di stimolare le stazioni appaltanti a intraprendere la strada già fissata al 2020 dalla Direttiva 2008/98 quando l’Italia dovrà raggiungere un obiettivo del 70% di recupero di materiali inerti. “Occorre promuovere una profonda innovazione nel settore delle attività estrattive – spiega il vice presidente di Legambiente Edoardo Zanchini – attraverso regole di tutela efficaci in tutta Italia e canoni come quelli in vigore negli altri Paesi Europei. Ridurre il prelievo di materiali e l’impatto delle cave nei confronti del paesaggio è quanto mai urgente e oggi assolutamente possibile. Lo dimostrano i tanti Paesi dove si sta riducendo la quantità di materiali estratti attraverso una politica incisiva di tutela del territorio, una adeguata tassazione e la spinta al riutilizzo dei rifiuti inerti provenienti dalle demolizioni edili”.
Nel complesso, la situazione è leggermente migliore al centro-nord, dove il quadro delle regole è in gran parte completo con Piani cava – lo strumento che indica le quantità di materiale estraibile e le aree dove è consentita l’attività di cava – periodicamente aggiornati, mentre non vi sono Piani in vigore in Veneto, Abruzzo, Molise, Sardegna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Sicilia, Calabria e Basilicata. Il Piemonte ha solamente Piani di indirizzo e rimanda alle Province l’approvazione del Piano. “Questa situazione di incertezza -spiega Legambiente- lascia tutto il potere decisionale in mano a chi concede le autorizzazioni, ma considerando il peso che interessi economici e criminalità organizzata, in particolare nel Mezzogiorno, hanno nella gestione del ciclo del cemento e nel controllo della aree cava, si comprende perché bisogna correre ai ripari e regolamentare il settore”.
Prelevare e vendere materie prime del territorio è un’attività altamente redditizia, mentre i canoni di concessione pagati da chi cava sono -secondo Legambiente- “a dir poco scandalosi”. In media infatti, si paga il 3,5% del prezzo di vendita degli inerti ma esistono situazioni limite come nel Lazio, in Valle d’Aosta e in Puglia dove il prelievo degli inerti costa solo pochi centesimi e regioni come Basilicata e Sardegna dove si cava addirittura gratis.
Le entrate degli enti pubblici attraverso i canoni di prelievo sono dunque ridicole in confronto ai guadagni del settore: il totale nazionale dei canoni pagati nelle diverse regioni, per sabbia e ghiaia, è arrivato nel 2012 a 34,5 milioni di Euro, mentre il ricavato annuo dei cavatori risulta pari a un miliardo di Euro.
Solo per fare un esempio, in Puglia nel 2012 sono stati cavati cavati 10,3 milioni di metri cubi di inerti che hanno fruttato 129 milioni di euro di introiti ai cavatori e solamente 827mila euro al territorio. Ma anche dove si pagano canoni leggermente superiori, come nel Lazio ed in Valle d’Aosta, il rapporto tra le entrate regionali e quelle delle aziende è di 1 a 40. Nel Lazio la Regione ricava meno di 4,5 milioni di euro contro i quasi 190 milioni di euro del volume d’affari complessivo con i prezzi di vendita. Quello che emerge dunque, è l’enorme e netta differenza tra ciò che viene richiesto e incassato dagli enti pubblici ed il volume d’affari generato dalle attività estrattive in tutte le regioni, in quelle dove il canone richiesto non arrivano nemmeno ad un decimo del loro prezzo di vendita come in Piemonte, Provincia di Bolzano, Friuli Venezia Giulia, Emilia-Romagna, Toscana ed Umbria, ma anche in Campania, Abruzzo e Molise, dove i canoni sono più alti. In Sicilia e Calabria, con l’introduzione per il primo anno del canone di concessione, le regioni ricavano rispettivamente 208 e 420mila euro per l’estrazione di sabbia e ghiaia a fronte dei 10 milioni ricavati dai cavatori in Sicilia ed ai quasi 15 milioni ricavati in Calabria.
“In un periodo di tagli alla spesa pubblica – ha concluso Zanchini – è inaccettabile che un settore tanto rilevante da un punto di vista economico e ambientale venga completamente trascurato dalla politica nazionale. È possibile creare filiere innovative di lavoro e ricerca applicata, ridurre il prelievo di cava attraverso il recupero di materiali e aggregati provenienti dall’edilizia e da altri processi produttivi, ma serve intervenire su una normativa nazionale vecchia di quasi 90 anni, per ripristinare legalità, trasparenza e tutela”.
Raggiungere questi obiettivi in tempi brevi, secondo Legambiente è possibile, e per questo l’associazione chiede: di rafforzare tutela del territorio e legalità (attraverso controlli, individuazione delle aree da escludere e delle modalità di escavazione, obbligo di valutazione di impatto ambientale, ecc.); di aumentare i canoni di concessione per equilibrare i guadagni pubblici e privati e tutelare il paesaggio (gli attuali 34,5 milioni di Euro guadagnati dalle regioni italiane per l’estrazione di sabbia e ghiaia, potrebbero diventare ben 239 milioni, se fossero applicati i canoni in vigore nel Regno Unito. Ad esempio in Sardegna si potrebbe passare da 0 a 17 milioni di euro); spingere l’utilizzo di materiali riciclati nell’industria delle costruzioni, per andare nella direzione prevista dalle Direttive Europee e riuscire così ad aumentare il numero degli occupati e risparmiare la trasformazione di altri paesaggi.