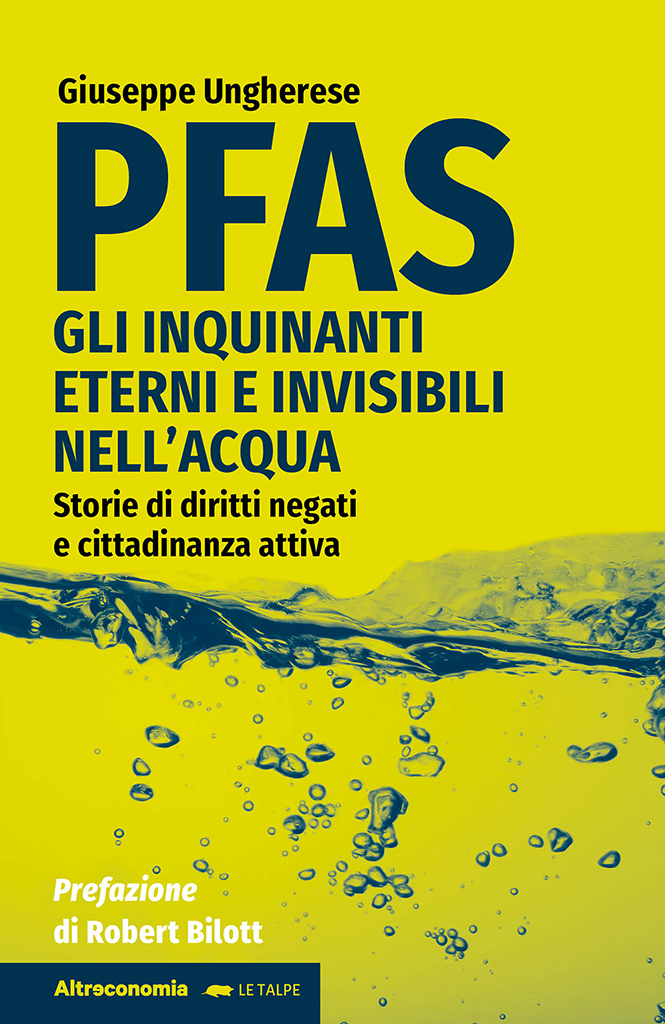Ambiente / Intervista
La tragedia del Vajont e le comunità “scartate” del Wasteocene

Nel cimitero di Longarone “ci sono i marginali, coloro che pagarono il prezzo di un’opera che venne presentata come necessaria per il benessere di tutti”. Nel suo ultimo saggio lo storico dell’ambiente Marco Armiero riflette sull’esigenza di cambiare la narrativa sul Vajont. Una lezione ancora attuale
Il premio Nobel per la chimica Paul Crutzen ha descritto per primo il concetto di Antropocene come l’era geologica dominata dagli umani come forza geologica in grado di cambiare i cicli bio-geochimici del Pianeta. Per molti aspetti, la storia della diga del Vajont può sembrare un Antropocene in miniatura: gli uomini sono stati in grado di modificare il sistema idrografico di un’intera valle, costruendo una diga alta 260 metri e capace di contenere oltre 168 milioni di metri cubi d’acqua. Una diga talmente ben costruita da reggere all’impatto di una frana di 270 milioni di tonnellate di roccia e all’onda gigantesca che il 9 ottobre 1963 ha spazzato interi Comuni e causato la morte di quasi duemila persone.
Una visione che però non convince Marco Armiero, research professor presso l’Istituto di Storia della scienza dell’Università autonoma di Barcellona, autore del saggio “La tragedia del Vajont. Ecologia politica di un disastro” pubblicato il 3 ottobre da Einaudi. “La narrazione sulla tragedia del Vajont cambia a seconda che la si guardi dalla diga o dal cimitero di Fortogna (una frazione di Longarone, ndr) dove non ci sono i capitani d’industria del capitalismo idroelettrico di quegli anni che furono i veri fautori del progetto e nemmeno i funzionari statali e i ministri compiacenti -spiega Armiero-. Ci sono invece i montanari, i marginali, coloro che pagarono il prezzo di un’opera che venne presentata come necessaria per il benessere di tutti. In quest’ottica la tragedia del Vajont si inserisce in quella che ho definito Wasteocene, l’era dei rifiuti, in cui si producono comunità che non hanno valore e vengono scartate. E che si pensa non valga la pena ascoltare”.
Professor Armiero, nelle conclusioni del suo libro lei scrive che abbiamo bisogno di smantellare la narrativa ufficiale dell’Antropocene, come si compie questa operazione al Vajont?
MA Lo hanno fatto Marco Paolini e Gabriele Vacis con la loro orazione civile del 1993: un esempio di “guerriglia narrativa”, che prova a sabotare la narrazione dominante raccontando quelle storie che nessuno ha avuto la pazienza di ascoltare e di raccogliere. Il primo passo per smantellare la narrativa dell’Antropocene è accorgersi che ne esiste una alternativa a quella mainstream: il Wasteocene, infatti, non produce solo comunità di scarto -gruppi marginali che possono essere sacrificati- ma anche un’infrastruttura narrativa tossica che normalizza e naturalizza l’ingiustizia.
Una narrativa che non si applica solo a vicende come quella del Vajont.
MA Esattamente. Normalizzare e silenziare le ingiustizie è la grande vittoria del Wasteocene: averci convinto che se sei povero è perché non sei stato abbastanza intraprendente o che se non trovi lavoro è perché non sei sufficientemente capace.
Lo scorso maggio l’Unesco ha inserito l’Archivio processuale del disastro della diga del Vajont nel suo registro “Memory of the world”. E nel 2008 aveva già indicato questa vicenda come una delle cinque “Storie esemplari che possono guidarci verso un futuro sostenibile”.
MA In quanto studioso di scienze umane sono convinto che i dati siano importantissimi. Ma un grafico, per quanto ben fatto, non ha la capacità di spingere le persone a mobilitarsi per chiedere un cambiamento. Sono le storie a farlo: pensiamo, ad esempio, alla fotografia scattata nel 1972 alla bambina vietnamita ustionata dal napalm e al ruolo che ebbe nel mobilitare l’opinione pubblica contro la guerra in Vietnam. Tuttavia su un aspetto non condivido totalmente il ragionamento dell’Unesco.
Ovvero?
MA L’agenzia delle Nazioni Unite cita il caso del Vajont come un evento causato dalla mancanza di interdisciplinarità tra geologi e ingegneri. Questo, a mio avviso, è il punto debole: le duemila vittime di quella tragedia non hanno perso la vita per questo motivo, ma perché si è deciso che il profitto dovesse essere la legge suprema nell’organizzazione dei rapporti socio-ecologici di quella valle. Un ragionamento a parte, invece, lo merita la decisione di tutelare l’archivio processuale: spesso sentiamo ripetere che è importante conservare la memoria dei disastri per non ripeterli. Non è successo solo con il Vajont ma anche con la tragedia del Sarno, con il terremoto in Irpinia e con il crollo del ponte Morandi a Genova. A mio avviso, però, pensare che la memoria si possa mettere in congelatore e tirarla fuori all’occorrenza è un po’ naif: perché le memorie di questi eventi sono necessariamente conflittuali, in frizione tra loro. La decisione dell’Unesco di tutelare l’archivio processuale va proprio in questa direzione: solo se conserviamo traccia del conflitto possiamo imparare qualcosa da questa tragedia. Al Vajont la giornalista Tina Merlin e le comunità locali, ad esempio, fecero del loro meglio per provare a opporsi a quello che stava succedendo, denunciarono le complicità delle istituzioni e degli organi di controllo. Una lotta che venne sostenuta anche dal Partito comunista di allora che venne poi accusato dalla Democrazia cristiana di sciacallaggio. La memoria non si fa con i minuti di silenzio -per citare Marco Paolini- ma con la richiesta di giustizia.
© riproduzione riservata