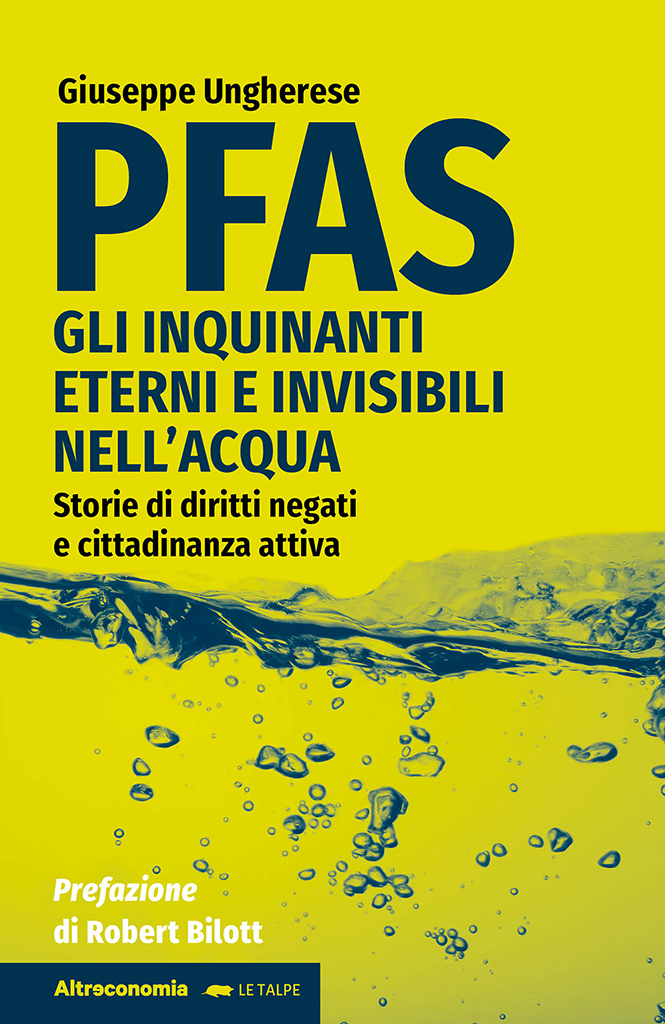Ambiente
Addio urbanistica

La differenza tra programmazione e gestione del territorio, i limiti alla partecipazione dei cittadini nei processi decisionali, gli effetti indesiderati del mantra "è necessario riqualificare le aree dismesse" nel libro di Patricio Enriquez, architetto e urbanista che insegna al Politecnico di Milano e lavora con i comitati in tutto l’Alto milanese
Patricio Enriquez è un urbanista e un architetto. Ha uno studio a Milano, insegna al Politecnico, ma è più facile incontrarlo durante un’assemblea che discute gli effetti sul territorio brianzolo dell’autostrada Pedemontana lombarda o che affronta con i cittadini di Sesto San Giovanni i rischi del progetto di “riqualificazione” dell’area ex Falck, quello firmato da Renzo Piano. Forte di un’esperienza maturata “sul campo”, oggi a fianco dei comitati ma prima da dirigente in alcuni Comuni, Enriquez ha mandato in libreria per Maggioli editore “Addio urbanistica, appunti per un progetto di governo del territorio” (14 euro).
Qual è la differenza tra l’urbanistica e il governo del territorio? Che cosa rappresenta la legge lombarda del 2005?
L’urbanistica è una materia che si pone tra quelle umanistiche e quelle scientifiche, poiché si occupa del comportamento umano e delle modalità di insediamento nel territorio. L’esigenza di regolamentazione del suolo nasce in età moderna per correggere gli effetti negativi derivanti dall’ampliamento delle città industriali e dai fenomeni di urbanizzazione della campagna.
Compito dell’urbanistica è quello di assicurare, pur promuovendo lo sviluppo edilizio, la tutela e l’uso razionale del territorio per contenere gli effetti più deleteri di esso: sovraffollamento, inquinamento, alterazioni idrogeologiche, inadeguatezza dei servizi.
Il governo del territorio, invece, nasce da motivazioni finanziarie del terzo millennio, con la cosiddetta riforma della Costituzione, sancendo l’affermazione della rendita fondiaria ed economica dei suoli. In altri termini, il governo del territorio è il garante del ruolo determinante della finanza nell’edilizia rispetto alla tutela del territorio.
La legge urbanistica lombarda del 2005 rappresenta l’esempio più calcante di come la tutela sia secondaria alla finanza, e l’aspetto più preoccupante è come tale legge stia facendo da scuola nel territorio italiano.
Nel tuo lavoro di urbanista hai seguito e accompagnato numerosi movimenti che hanno cercato di far valere il proprio punto di vista nell’elaborazione di piani o strumenti urbanistici in vari Comuni della Lombardia. Nel libro dai conto, però, dei limiti dei processi di "partecipazione". Quali sono i principali?
Intanto la partecipazione nei piani urbanistici è dovuta alla recente introduzione di normative ambientali di matrice europea. E senza tali norme in Italia, forse, non sarebbe mai stata introdotta. Ma in Italia continua a sussistere una “devianza” che confonde -volutamente- procedure ambientali e procedure partecipative di condivisione delle scelte.
Generalmente, salvo rari casi, possiamo parlare semmai di “momenti informativi”, dove il Comune illustra le scelte già prese e caso mai decise insieme a qualche “stakeholder” referenziato e ben accreditato. L’uso oramai generalizzato di un termine anglosassone, invece di uno latino, rende bene già l’idea del significato che si dà alla partecipazione, la quale è diventata una procedura di mera ottemperanza di un obbligo di legge, piuttosto che una vera occasione per acquisire un “sapere sociale” che è radicato solo nella società.
Davvero "il recupero di aree dismesse costituisce attività di pubblica utilità ed interesse generale", a prescindere dal tipo di recupero programmato, come si legge in una legge lombarda? Che cosa comporta, a tuo avviso, una visione del genere?
È importante avviare un serio processo di riconversione delle aree dismesse mediante forme di riuso che si contrappongano alla tradizionale abitudine del consumo del suolo libero, ma questa non può essere coniata come una attività di pubblica utilità e di interesse generale.
Una distorta visione del significato di “pubblica utilità”, come è avvenuto in Lombardia, comporta infatti un rovesciamento degli interessi collettivi a favore di quelli privati, che si sostituiscono, impropriamente, al pubblico nell’individuazione dei fabbisogni collettivi.
In altri termini la riconversione delle aree private, per usi privati, spesso incorniciati con i termini di “valorizzazione” e “riqualificazione”, diventano prioritari rispetto agli urgenti e datati fabbisogni della collettività, perché la parola d’ordine è diventata “togliere il degrado dalla vista”, senza nemmeno capire se ciò che sostituirà il degrado comporterà maggiori problematiche rispetto allo stato iniziale. Un tipico paradosso italiano.
In che modo la realizzazione della "città pubblica", ovvero l’esigenza di garantire servizi ai cittadini presenti e futuri, che dovrebbe essere al centro dell’attività di pianificazione, arriva a rappresentare un "Cavallo di Troia" a favore di una ulteriore urbanizzazione?
Realizzare prioritariamente la “città pubblica” significa costruire città che soddisfino le esigenze di tutti, garantire qualità abitativa e inequivocabilmente impiegare le aree per finalità pubbliche, sottraendole all’urbanizzazione della città privata. Se un piano urbanistico è redatto da un ente pubblico, allora non si comprende per quale motivo si debbano rendere edificabili aree private quando queste non corrispondano ad un reale e vero interesse pubblico. Il governo del territorio sorge su un paradosso, perché individua a priori le aree riservate all’edificazione privata, che garantiscono gli introiti finanziari, e poi sulle restanti aree -che sono residuali- identifica la città pubblica. Anzi nei peggiori casi, sarà l’attività edificatoria del privato che individuerà, e non si capisce con quale criterio pubblico, le aree della città pubblica.