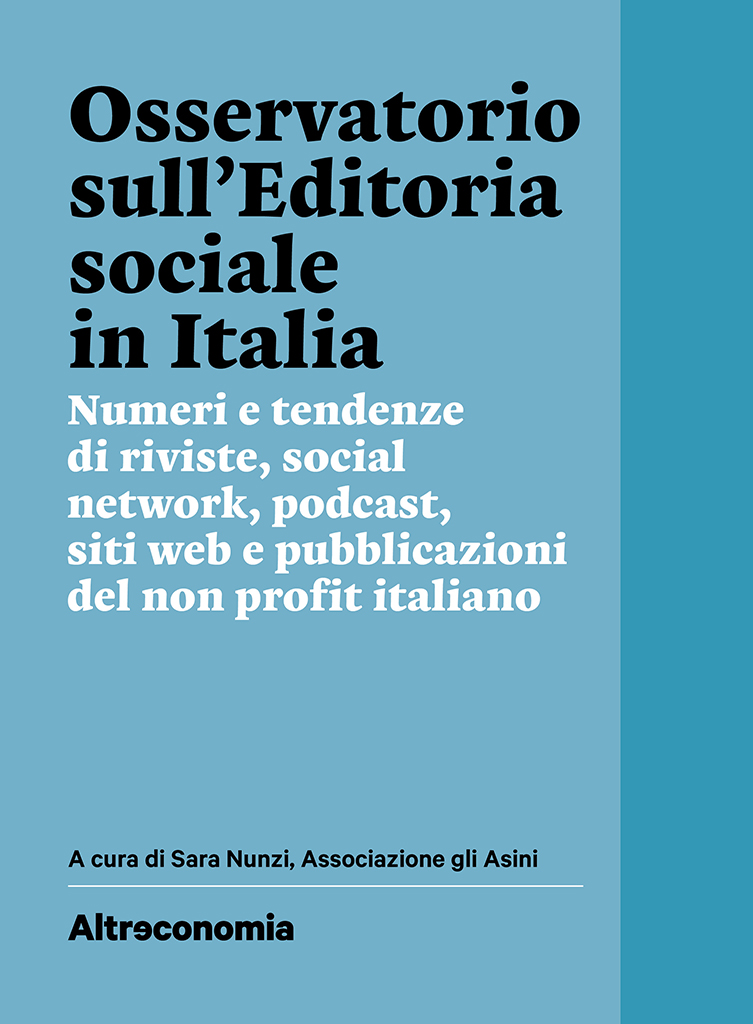Altre Economie
Tra etica e imprenditorialità

Intervista a Bertram Niessen, tra i più attenti conoscitori della cultura maker. “Un pensiero che s’interroga sulle diseguaglianze” —
"Non esiste una definizione univoca di ‘maker’, semmai una, forse positiva, confusione terminologica. Positiva perché in realtà riflette una molteplicità di pratiche, valori, tipologie organizzative, soggetti coinvolti molto diversi tra loro”. Bertram Niessen, 34 anni, è un sociologo, con un percorso di ricerca “ibrido”: si è occupato di spazi urbani, economia della cultura e più recentemente di reti peer to peer e produzione distribuita. Docente ma anche artista, il professor Niessen spiega: “Al cuore di tutto c’è un forte interesse per l’intersezione tra cultura, tecnologia e società, e la convinzione che ci sia il bisogno di nuove forme di azione sociale e politica”. È anche tra gli ideatori e project manager di “cheFare”, un premio da 100mila euro per progetti di innovazione culturale promosso dall’associazione “doppiozero” di Milano (www.doppiozero.com).
Allora, professor Niessen, chi sono i maker?
“Il termine si riferisce a un movimento subculturale americano e alla rivista Make (makezine.com), titolare del brand delle ‘Maker Fair’. Parliamo quindi di un primo nucleo molto americano, un mix tra l’eccellenza scientifica del Mit e l’imprenditorialità della Silicon Valley. La cultura originale peraltro attinse anche alla cosiddetta estetica ‘steampunk’, ovvero al riutilizzo di alta tecnologia in una forma quasi barocca, all’idea che il ‘fai-da-te’ (Do It Yourself, DIY) sia un valore, e a quella di ‘Slacktivism’, l’‘attivismo del cazzeggio’, che vuol dire che le cose si fanno perché piacciono, e per questo riescono meglio, soprattutto se in maniera organizzata.
A partire da questo fenomeno, numericamente limitato, si sono aggiunte altre ‘correnti’: il craftivism, movimento che negli Usa riguarda figure professionali che hanno deciso di abbandonare percorsi tradizionali per dedicarsi a lavori più appaganti, spesso perseguendo motivazioni sociali o politiche; oppure il mondo storicamente più hacker, ovvero più legato alle tecnologie e ai software. Tutto mescolato con la cultura della start up americana: cominci dal garage e speri di diventare Google. Con tutta la retorica che questo implica. Infine c’è tutta l’eredità dell’attivismo politico digitale, che in Italia è stato poco raccontato ma che è arrivato ad altissimi livelli di competenze. Detto questo, il fenomeno ‘maker’ prende forme originali a seconda di dove attecchisce. Si sono diffusi ad esempio i cosiddetti ‘fablab’, che sono l’esplicitazione, i contesti dove queste ‘culture’ si ritrovano. Anche qui c’è un po’ di confusione terminologica, ma possiamo dire che un fablab è laboratorio di fabbricazione digitale dotato di un set preciso di macchinari (come una tagliatrice laser digitale, o una stampante 3D), che in qualche modo aderisca alla codificazione data -in grande- al Mit di Boston, nel Center for Bits and Atoms nato nel 2001 (cba.mit.edu). Poi ci sono almeno altri due tipi di spazi: i maker space, con funzioni un po’ ibride (ad esempio laboratori dove si riparano oggetti), e gli hacker space”.
Ma come distinguiamo un maker da un artigiano, o semplicemente da una persona appassionata di autoproduzione?
“Vi sono almeno due elementi da tenere in considerazione. Il primo è l’autoriconoscimento -che è tipico dell’emersione di gruppi sociali- in una serie di pratiche, valori -come l’accesso, la trasparenza, l’apertura-, e spazi. Questi elementi perimetrano un’area sociale.
Il secondo è più complesso: se prendi un oggetto prodotto da una stampante 3D, magari autoassemblata, può anche essere inutile. Anche se il valore d’uso è molto basso, gli oggetti sono prototipi che incorporano le relazioni sociali che sono state messe in campo per realizzarli. Nell’economia post-fordista abbiamo assistito a una progressiva dematerializzazione dell’economia, ovvero il valore aggiunto immateriale di un oggetto è divenuto preponderante. La produzione dei maker in un certo senso è un modo per rimaterializzare il valore aggiunto.
Quindi, la stampante 3D è un oggetto paradigmantico, ma forse è anche quello che serve meno. Con una tagliatrice laser si possono fare molte più cose di uso comune.
Ma se c’è un risultato, è che oggi mondi che prima si guardavano con diffidenza -ingegneri, designer, operatori sociali, artigiani- trovano in questo ambito modo di parlarsi.
Nel modello economico post-fordista prima c’è un’indagine di mercato, poi un centro di ricerca che ipotizza una serie di risposte alla domanda, poi una prototipizzazione che cerca soluzioni tecniche, poi ancora l’ufficio economico che cerca le soluzioni più profittevoli, e infine l’ufficio di comunicazione e marketing che quel prodotto deve fare incontrare con la domanda. Nell’approccio maker tutti questi aspetti convivono, coesistono nello stesso spazio, -per altro con la proprietà dei mezzi di produzione-. I team lavorano sempre in gruppo, e un solo oggetto racchiude sin da subito , ricerca, tecnologia di alto livello, comunicazione adeguata”.
Possiamo definire quella dei maker una “controcultura”?
“A causa di quello che chiamiamo il ‘riflusso’ dei movimenti sociali, avvenuto tra il 2003 e il 2006, oggi una visione critica della società è molto minoritaria. Anzi: assistiamo all’affermarsi della cultura delle start-up, che è quasi iper-liberista. Però dall’altra parte si afferma anche la cultura dell’innovazione sociale: il mondo maker sta nel mezzo. Tuttavia è ancora alla ricerca delle sue vie, non a caso siamo costretti ad abusare di termini inglesi per cercare di definirlo. Però è un pensiero che prende piede -basta pensare al diffondersi degli ‘open data’ nella pubblica amministrazione-. Un pensiero che certamente si interroga anche sui temi della distribuzione delle risorse, sull’uguaglianza, sulla proprietà intellettuale. Se e quando ci sarà una nuova ondata di mobilitazione, avrà senz’altro i maker tra i protagonisti. Questa fa sì che una serie di pratiche di collaborazione, condivisione e solidarietà stiano già sorpassando quelle che noi oggi chiamiamo ‘alternative’. Ad esempio, i gruppi di acquisto solidali sono stati fondamentali negli ultimi 10 anni, anche per modalità e linguaggio proposto, ma rimangono accessibili fino a un certo punto. Oggi invece molte persone non hanno un preciso background, e si oppongono a quel che non ritengono giusto nel mondo in maniera molto immediata, quasi prepolitica.
Proviamo a prevedere il futuro.
“Assisteremo intanto a un intervento massiccio delle grandi corporation, che cercheranno di far propri i principi dei maker. La ‘customizzazione’ definitiva. Basta pensare a quanto dichiarato da Barilla (che vorrebbe che i consumatori di producessero da sé la pasta con una stampante 3D a partire da una base fornita dall’azienda, ndr) o da Coca-Cola (anche in questo caso, prodursi la bevanda a partire da cialde, ndr).
Dall’altra parte ci sarà un numero sempre maggiore di cittadini che svilupperanno interesse per il fai-da-te, prolifereranno luoghi e pratiche dell’autoproduzione. Nel mezzo, anche questo: il diffondersi spazi di produzione ad alta competenza: ci vai e ti producono un cellulare, senza farlo venire dalla Cina. Questo riguarderà però anche il mondo medicale, le biotecnologie e , ahimé, le droghe.
Infine, si mobiliteranno le istituzioni: all’estero è prassi, ma già oggi in Italia qualcosa sta accadendo. Tre esempi: il Comune di Milano che concede spazi apposta per maker, la biblioteca di Cinisello Balsamo che si reinventa come centro civico di nuova concezione, il Museo della Scienza di Trento che ha al suo interno un fablab”. —