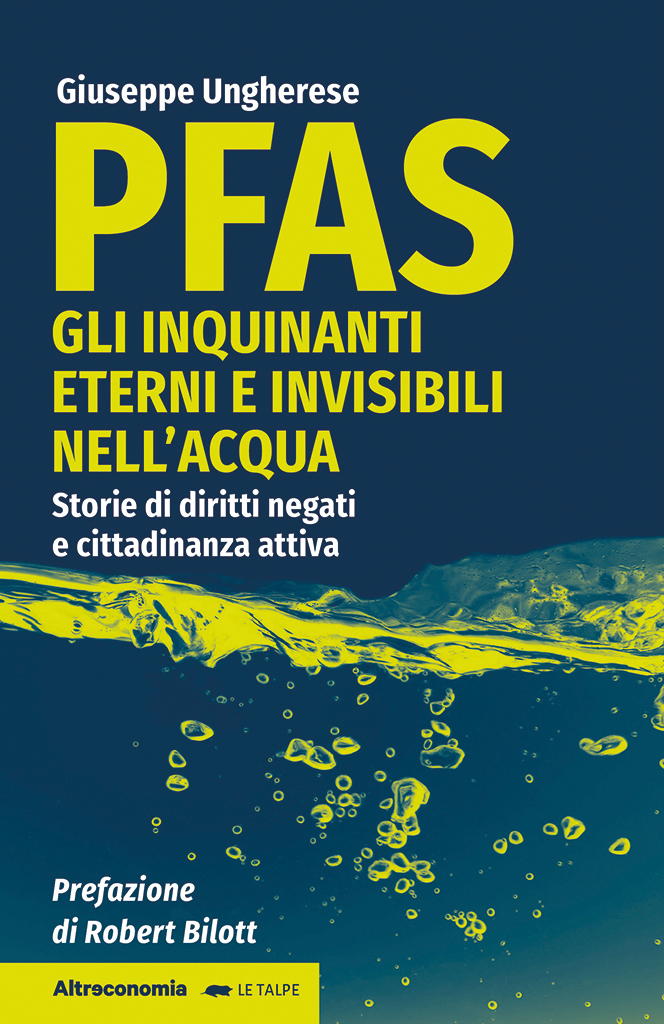Ambiente / Approfondimento
Il greenwashing della moda dietro le certificazioni di “sostenibilità”

Esistono oltre 100 certificazioni che valutano l’impronta ecologica degli abiti che compriamo e indossiamo ogni giorno. Fioriscono etichette “sostenibili” e bollini “green”. L’industria della fast fashion rivendica passi avanti verso una maggiore sostenibilità e circolarità. Ma un report di Changing markets racconta un’altra storia
Sul mercato esistono più di cento certificazioni registrate dall’Ecolabel index che valutano l’impronta ecologica degli abiti che compriamo e indossiamo ogni giorno. Se ci limitassimo a osservare questo fiorire di etichette “sostenibili” e bollini “green” applicati a jeans e magliette potremmo pensare che l’industria della moda stia avanzando rapidamente verso una maggiore sostenibilità ambientale e un sistema di produzione circolare. In realtà non è cosi. Lo evidenzia il report “Licence to greenwash”, pubblicato a marzo 2022 dalla fondazione olandese Changing markets che analizza nel dettaglio dieci certificazioni selezionate tra quelle più diffuse e che affermano di prestare maggiore attenzione ai temi della sostenibilità e dell’economia circolare nel settore tessile. Si tratta di Higg Index, Oeko-Tex, Zdhc, Cradle to cradle, Ellen McArthur foundation, Weap, The microfibre consortium, Bluedesign, Eu Ecolabel, Textile Exchange.
“La nostra indagine -si legge nel report– ha cercato di stabilire la validità delle certificazioni in dieci settori, per stabilire se queste possono rivendicare di aver generato un effettivo cambiamento. Abbiamo intrapreso una valutazione qualitativa del loro livello di ambizione, della spinta per il miglioramento continuo, dell’indipendenza e della trasparenza”. La valutazione finale è decisamente negativa: quasi tutte le certificazioni si pongono infatti obiettivi poco ambiziosi e non li aggiornano con il passare del tempo, si limitano a considerare solo alcune fasi del ciclo di vita dei prodotti (escludendo quasi sempre lo smaltimento), sono soggette alle pressioni e all’influenza dei marchi e presentano uno scarso livello di trasparenza. La mancanza di affidabilità di queste iniziative permette così all’industria della moda di presentare i propri prodotti come innovativi e sostenibili quando in realtà non lo sono. “Ciò che questi programmi hanno in comune è che sono tutti volontari e la nostra analisi mostra come l’autoregolamentazione del settore non sia riuscita”, si legge nel report.
Su dieci certificazioni ben sei risultano insufficienti in tutti i gli ambiti presi in considerazione, solo Ecolabel, Bluesign, Oeko-tex e Texile exchange ottengono valutazioni positive, ma in non più di due settori. Una delle migliori, anche se non pienamente sufficiente, è Ecolabel (promossa dall’Ue nella Direttiva 66/2010). Tra quelle analizzate è l’unica a non essere legata agli interessi delle aziende ed è stata valutata positivamente per la sua capacità di prendere in considerazione l’intero ciclo produttivo degli indumenti e per la sua attenzione all’uso di sostanze chimiche durante la lavorazione. Tuttavia non approfondisce in modo adeguato i problemi legati all’inquinamento da microplastiche e non promuove il riuso e il riciclo degli indumenti. Il problema principale, però, è dato dalla mancanza di trasparenza: l’accesso al pubblico dei criteri di valutazione è limitato. Infine, la certificazione dovrebbe aggiornare i suoi criteri ogni quattro anni, ma la sua revisione, che avrebbe dovuto tenersi nel 2020, è stata rimandata al 2025.
Dall’altro lato una delle certificazioni che ha raccolto la valutazione più negativa è l’Higg Index per la sua scarsa scarsa trasparenza, per i forti conflitti di interessi con le grandi aziende e per non aver aggiornato con il passare degli anni, i propri criteri di valutazione. Questa certificazione è stata promossa dalla Sustainable apparel coalition (Sac), fondata dall’azione congiunta di diverse aziende (tra cui Walmart, Nike, Target, Gap e H&M) i cui dirigenti continuano ad essere presenti nella coalizione. Dalla sua fondazione, nel luglio 2012, l’Higg Index è stato raramente aggiornato e il report di Changing Markets evidenzia come i criteri adottati per la valutazione non siano abbastanza ambiziosi. Infine, manca di trasparenza avendo costantemente rimandato o annullato la pubblicazione di report sull’argomento e l’annunciato portale open data annunciato da Sac per il 2021 a marzo 2022 non era ancora disponibile al pubblico.
Una seconda macro-area di analisi del report “Licence to greenwash” si è concentrata sull’uso di fibre sintetiche come poliestere, nylon, acrilico ed elastan: materiali estremamente economici, ottenuti dalla lavorazione di combustibili fossili, ma che hanno un impatto ambientale pesantissimo. Anche in questo ambito la maggior parte delle certificazioni si mostrano inadeguate e solo una (quella promossa dalla Fondazione Ellen MacArthur) ottiene una valutazione positiva essendo una delle poche a promuovere una riduzione dei materiali sintetici avendo adottato ambiziose linee guida che promuovo non solo l’uso di plastica riciclata, ma anche l’utilizzo di pesticidi e fertilizzanti più sostenibili nella produzione di tessuti naturali. Changing markets sottolinea come come la maggior parte delle etichette promuova i tessuti sintetici come più ecologici rispetto alle alternative naturali, spesso ignorandone il reale impatto sull’ambientale e il ruolo che svolgono nel rilascio di microplastiche negli ambienti marini.
“La nostra analisi rivela come le certificazioni molto spesso non considerino le questioni legate alla fast fashion e alla sovrapproduzione e sembrano ignorare come il modello di business prevalente dell’industria sia uno dei maggiori responsabili per il disastro ambientale”, si legge nel report. Negli ultimi venti anni, infatti, il numero di capi di vestiario acquistati per persona è raddoppiato ed è previsto che aumenti di un ulteriore 63% entro il 2030. Allo stesso tempo la durata degli indumenti, ossia il numero di volte che viene indossato durante il suo ciclo vitale, è diminuito del 40% negli ultimi 15 anni. È la cosiddetta fast fashion che produce ogni anno migliaia di tonnellate di rifiuti difficili da smaltire che finiscono nelle discariche di tutto il mondo. Changing markets evidenzia come siano ancora poche le certificazioni che iniziano a prendere in considerazione il problema del “fine vita” dei capi d’abbigliamento tra i criteri di valutazione della sostenibilità delle aziende.
Combattere le strategie di greenwashing dell’industria della moda è possibile, sottolinea la fondazione olandese, ma è necessario che tutti gli attori in gioco adottino delle iniziative corrette. La fondazione si rivolge ai legislatori, con particolare attenzione a quelli dell’Unione europea, perché prendano provvedimenti contro l’inquinamento da microfibre, l’uso di tessuti sintetici e promuovano maggiore trasparenza per le aziende. Anche le certificazioni di sostenibilità devono migliorarsi garantendo una maggiore trasparenza, adottando un approccio “olistico” che comprenda tutto il ciclo vitale degli indumenti e agendo in maniera indipendente dall’industria della moda. In secondo luogo, devono dotarsi di obiettivi ambiziosi e senza promuovere false soluzioni come l’utilizzo di plastica riciclata. Per quanto riguarda l’industria, inoltre, i ricercatori chiedono di compiere tre passi fondamentali: la completa trasparenza sull’uso di tessuti sintetici, una riduzione nell’uso di questi materiali del 20% entro il 2025 rispetto alla quota del 2021 (da portare al 50% entro il 2030) e il taglio delle emissioni climalteranti lungo tutta la catena produttiva del 50% entro il 2030. In conclusione, Changing markets lancia un appello ai consumatori “a esprimersi sulla necessità di un cambiamento e ad accompagnarlo con sforzi educativi, a comprendere che la certificazione non è garanzia di sostenibilità, a individuare e denunciare il greenwashing e a riconoscere i marchi che agiscono veramente per la sostenibilità”.
© riproduzione riservata